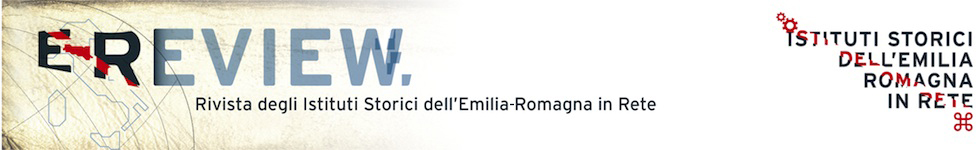Introduzione
La conferenza Narrare il Fascismo è stata un’opportunità per discutere sul modo in cui il fascismo è stato analizzato e presentato al pubblico da diverse discipline. L’intento principale credo fosse quello di esplorare le diverse narrative che le distinte specializzazioni hanno partecipato a creare dal dopoguerra da oggi. Il mio contributo al dibattito è stato quello di presentare il punto di vista degli studi critici sul patrimonio (Critical Heritage Studies) con l’intento di discutere un caso di studio che sintetizza un’analisi delle problematche che i musei affrontano in materia di “patrimoni difficili”, e che ha visto l’idea per un museo sul fascismo al centro di un acceso dibattito pubblico [Noiret 2016].
Patrimonio difficile e musei
Sharon Macdonald definisce il patrimonio storico come “difficile” quando un passato seppur riconosciuto come degno da ricordare, crea al tempo stesso difficoltà nel presente, in quanto genera conflitti in termini di creazione di un’identità contemporanea condivisa [Macdonald 2006]. Questo tipo di patrimonio può persino generare paura, perchè irrompendo nella società può dare origine a divisione sociale. Il patrimonio culturale è tradizionalmente considerato cruciale per la formazione dell’identità nazionale, spesso utilizzato come simbolo positivo nella costruzione di un passato comune sicuro, ma che come la letteratura recente ha dimostrato non è mai una selezione neutrale di un passato “vero”, ma un processo di valori selezionati. Le ideologie che alcuni di questi patrimoni rappresentano possono produrre dissonanza, memoria contesa e divisione sociale [Tunbridge e Ashworth 1996].
I musei possono dover afforntare gli effetti problematici di differenti narrazioni prima ancora dei luoghi simbolo e dei monumenti, poiché espressamente pensati per il pubblico e, come tali, luoghi di dibattito sociale. Creare una narrazione e informare il pubblico è una parte intrinseca dello scopo di un museo, un processo che questi ultimi possono raggiungere a un livello che i monumenti e i luoghi non riescono. I musei con mostre permanenti e temporanee sono luoghi della memoria, specialmente quelli che affrontano questioni contemporanee e storiche.
Smith e Waterstone [2010] discutono come durante il processo di creazione del patrimonio, le storie difficili diventino dibattiti pubblici attraverso la rinegoziazione del passato, un processo in cui sia i manager del patrimonio che gli storici sono coinvolti. Questa rinegoziazione crea conflitti, poiché diverse narrazioni soddisfano un diverso senso di identità; tuttavia, il processo di finanziamento pubblico rende le scelte relative ai musei politicamente più sensibili e allo stesso tempo si rende necessaria la produzione di contenuti che tenga conto delle distinte conoscenze storiche di base di un pubblico eterogeneo [Linenthal 1996].
L’Imperial War Museum e la mostra sul Terzo Reich
Come confermato da Suzanne Bardgett, responsabile della ricerca presso l’IWM, durante il nostro colloquio del 15 ottobre 2016, prima dell’apertura dell’esposizione permanente sull’Olocausto era assente nel museo ogni riferimento a questa tematica. Ciò era dovuto in primis al mission statement del museo all’epoca, ovvero un focus specifico sulle guerre in cui era coinvolto l’Impero Britannico, ma anche in parte a una sensazione di generale difficoltà ad affrontare il tema dell’Olocausto e alla sua percezione pubblica [Bardgett 2004].
Nel 1973 il museo ha partecipato a una famosa serie TV in cui l’episodio The World at War è stato interamente dedicato all’Olocausto. A seguito del successo della serie la direzione del museo iniziò a lavorare a una grande mostra sul Terzo Reich. La cronologia della mostra voleva coprire gli anni dal 1919 al 1933, spiegando l’ascesa al potere di Hitler, per poi affrontare gli anni dal 1933 al 1942, presentando le politiche, le personalità e l’organizzazione del partito nazista, e infine gli anni dal 1942 al 1945 e le conseguenze delle politiche del Reich. In questa sezione finale la mostra avrebbe affrontato le politiche razziali del partito e i suoi numerosi tipi di campi di concentramento.
La mostra avrebbe esposto collezioni private controverse quali la collezione Sweeting (una raccolta di circa 2500 oggetti appartenenti a un collezionista americano) e la collezione Brownlow (proveniente anche questa dagli Stati Uniti). Molti degli oggetti in catalogo erano appartenuti originariamente a ufficiali nazisti di alto rango, cosa che ha reso la collezione estremamente problematica. C’era un arazzo dalla Sala congressi di Norimberga, circa 40 bandiere naziste, e parecchie uniformi. Due pagine del catalogo erano dedicate a manufatti provenienti da campi di concentramento, tra cui poster di propaganda antisemita, una stella gialla francese, la chiave di una cella a Dachau e vari arnesi che erano stati prelevati dai campi.
Come afferma Bardgett, il direttore e lo staff del museo dell’epoca erano consapevoli della problematicità di tale esposizione, soprattutto in considerazione del fatto che gli oggetti nazisti in questione erano di grande interesse per i membri del Fronte nazionale e altri estremisti. La situazione politica britannica negli anni Settanta non lasciava spazio a fraintendimenti sulla posizione del museo su un argomento controverso come il nazismo. La mostra è stata percepita come la “mostra tedesca”, e la reazione pubblica manifestò fin dall’inizio riserve sul progetto: attraverso i giornali, l’opinione pubblica domandava se l’argomento fosse o meno inerente alle tematiche del museo, e se alcuni oggetti non fossero troppo imbarazzanti o traumatici [Bardgett 2005]. La preoccupazione principale era che, concentrandosi sulla Germania nazista, si potesse attirare l’interesse indesiderato dei gruppi neo-nazisti o filo-nazisti. Bardgett afferma che alcuni membri del museo osservarono come l’estetica di alcuni oggetti fosse estremamente glamour e ancor più umiliante quindi nei confornti delle loro vittime: si temeva in sostanza che la mostra potesse creare ulteriore danno alla memoria delle vittime dell’Olocausto [Bardgett 2004].
La stampa all’epoca della programmazione della mostra aveva ricevuto alcune informazioni sul progetto e in particolare su un oggetto estremamente problematico dalla collezione Brownlow: un libro rilegato in pelle umana. Il “Guardian” sottolineò chiaramente quanto fosse inaccettabile presentare una raccolta di questo tipo (anche se ovviamente quel particolare pezzo non sarebbe mai stato esposto) e la paura complessiva che una simile esposizione potesse apparire come apologetica nei confronti del Reich. Bardgett ritiene che in quegli anni una mostra sull’Olocausto non era fattibile. La conoscenza e l’accettazione pubblica dell’Olocausto come parte della Seconda guerra mondiale nella storia britannica non era ancora stata studiata a sufficienza; inoltre gli storici del museo non avevano conoscenze specifiche tali da poter produrre una simile mostra [Dawidowicz 1981].
Dal Terzo Reich all’Olocausto
Nel 1978, il dipartimento di Sound Records del museo avviò un progetto di storia orale per registrare le esperienze dei profughi che erano fuggiti dalla Germania nazista negli anni Trenta. A metà degli anni Ottanta si sono svolte due mostre temporanee che hanno aperto il dibattito sul fenomeno nazista. La Resistenza (1984), curata da Mark Seaman, è stata una mostra che ha fornito il primo resoconto dettagliato nel Regno Unito dell’oppressione nazista nell’Europa occupata. Le carte, i permessi di viaggio, i proclami tedeschi e i manifesti hanno parlato della riduzione della libertà in ciascuno dei paesi occupati e di come la Gestapo avesse fatto applicare in modo brutale le leggi razziali. La mostra è stata un successo, tuttavia non ha specificamente affrontato la resistenza ebraica, tanto da richiamare lettere di protesta da parte di diverse organizzazioni delle vittime.
Il museo ha riconosciuto che il soggetto era stato sottorappresentato e una sezione sulla rivolta del ghetto di Varsavia è stata aggiunta per ovviare a questo. Nell’anno successivo (1985), il museo ha curato Verso una nuova Europa, mostrando manifesti e riviste che illustrano come il sogno nazista di una prospera Europa, purificata da tutti gli elementi stranieri, era stato confezionato per i popoli dell’Europa occupata.
Nel 1991, il museo ha aperto una mostra sulla liberazione di Belsen. Il display ha raccontato la storia della liberazione del campo utilizzando fotografie, film, registrazioni sonore, dipinti e manufatti. Basandosi solo su materiali tenuti nel museo in quel periodo, la mostra Belsen raccontò poco della storia del campo prima dell’aprile 1945, né tentava di mettere la liberazione nel più ampio contesto della guerra di Hitler contro gli ebrei. Tuttavia, è stato un passo importante e ha richiamato molti commenti da un pubblico chiaramente commosso dai suoi contenuti. Questo è stato seguito nel 1993 da una piccola mostra fotografica sul ghetto di Varsavia [Bohm-Duchen 1996].
La decisione di organizzare una grande mostra sull’Olocausto è stata annunciata in una conferenza stampa nell’aprile 1996. Nel suo discorso, Robert Crawford, succeduto ad Alan Borg come direttore generale, ha parlato della centralità dell’Olocausto nella storia della Seconda guerra mondiale e del fatto che ci fosse un “buco nero” nella cronologia del museo. Tuttavia, non tutti pensavano che fosse arrivato il momento di avere una mostra dell’Olocausto presso l’IWM, infatti molte furono le lettere rivolte al museo che definivano la nuova proposta come “scandalosa”.
Curare il contenuto della mostra è stato uno sforzo di squadra di cinque curatori, ognuno dei quali si è occupato di una parte spacifica dell’esposizione. I primi due anni del progetto quadriennale sono stati principalmente impiegati per identificare materiale da esporre, mentre i due anni successivi sono stati dedicati alla ricerca scientifica di ciascuna delle 29 sezioni. Le aspettative della mostra erano estremamente elevate e il personale del museo fece grandi sforzi per non disattenderle: «il nostro primo dovere era quello di informare i visitatori di ciò che era accaduto, senza alcun tipo di estetizzazione, la storia è così forte che non ha bisogno di alcun abbellimento» [Bardgett 2005, 9].
Una delle problematiche riguardava dove posizionare l’ingresso di quella che sarebbe stata una mostra permanete all’interno di una collezione consolidata. Per alcuni l’ingresso attraverso l’atrio monumentale con il suo display di armi non era il più indicato e si doveva tenere conto dei limiti di età per accedere all’esposizione. La mostra doveva coesistere con il resto delle mostre del museo, ma aveva bisogno di una propria identità, rimossa da elementi che potessero interferire su ciò che evidentemente era necessario mostrare in un’atmosfera particolare. A questo proposito, il personale del museo concepì uno spazio introduttivo in cui i visitatori potessero avere il tempo di analizzare ciò che li aspettava una volta iniziato il percorso. La cronologia ha contribuito a fondere la mostra con il resto del museo: la narrazione inizia nel 1918 e termina nel 1945 con una discesa dal quarto al terzo piano dell’edificio a scandire lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Questa soluzione prepara visivamente il visitatore alla “discesa” dalla luce all’oscurità, a cui seguiranno le persecuzioni, lo sterminio e la guerra.
In termini di costruzione della narrazione, la parte più problematica era quella di chiarire il ruolo della Gran Bretagna al momento della scoperta dei campi, tema estremamente controverso. Era fondamentale presentare al pubblico l’arrivo delle prime notizie sull’esistenza dei campi e la reazione dei diversi paesi europei, primo tra tutti il Regno Unito. I curatori adottarono come soluzione le quattro finestre “News Reaches Britain”, che testimoniano la storia di quello che successe nell’Europa occupata, mostrando al visitatore come la notizia delle atrocità raggiunse l’Occidente e come fu ricevuta. La mostra affronta il ruolo svolto in questo processo dai profughi ebrei arrivati nel paese, grazie al prezioso contributo di storie, documenti e oggetti, oggi parte integrante della collezione permanente. Infine, «c’era il problema di riempire una mostra di 1200 metri quadrati con manufatti, quando le collezioni esistenti erano sbilanciate, con abbondanza, sulla liberazione di Belsen, ma poco sull’esperienza ebraica e niente per illustrare argomenti come ghetti o uccisioni di massa sul Fronte orientale» [Bardgett 2005, 11].
Grazie a un appello attraverso la newsletter del museo fu possibile acquisire molto materiale dai sopravvissuti presenti dal Regno Unito, mentre a seguito di viaggi presso campi di concentramento e musei all’estero è stato possibile ottenere una serie di prestiti permanenti. Il tavolo di dissezione in marmo proveninte dall’ospedale psichiatrico di Kaufbeuren in Svevia è un oggetto profondamente inquietante, ma che secondo Bardgett (intervista del 15 ottobre 2016), fornisce un interessante punto di “svolta” tra le premesse della nascita del Reich e l’inizio delle persecuzioni.
Spunti conclusivi
La lunga genesi dell’esposizione permanente sull’Olocausto dell’Imperial War Musuem dimostra come, pur in un paese non direttamente coinvolto nelle persecuzioni razziali, questo tipo di patrimonio difficile sia complesso da presentare al pubblico. La cancellazione della mostra sul Reich esemplifica come le problematiche di un museo siano ben diverse da quelle di una forma più tradizionale di produzione di contenuti storici: la narrativa museale è fatta di scelte nette sia per quanto riguarda gli oggetti che in generale per la creazione di una sintesi narrativa degli eventi. Questo case study mostra inoltre come il rapporto con il pubblico quando si affrontano tematiche “difficili” possa essere un efficace strumento di dibattito volto alla creazione di una narrazione condivisa.
Come dimostrato dalla mostra del Terzo Reich, era essenziale che il museo non venisse percepito come revisionista o apologetico nei confronti del nazismo. Fu proprio il timore di come una mostra sul Reich potesse venir considerata dai gruppi neo-nazisti a far naufragare il progetto. In presenza di una collezione la questione si complica per quanto riguarda sia la provenienza degli oggetti che la storia della collezione stessa: come abbiamo infatti visto nel caso del collezioni Sweeting e Brownlow, molto spesso erano stati gli alti ufficiali nazisti stessi o loro stretti collaboratori ad aver collezionato cimeli delle vittime, aprendo una questione etica su cosa sia giusto esporre.
I musei sono luoghi in cui le narrazioni diventano “ufficiali”, dove gli oggetti cambiano di status dal momento in cui entrano nello spazio museale; questo processo di museum accessioning è un rituale in cui la materialità della vita quotidiana dell’oggetto si trasforma in valore culturale. Ecco perché, nel contesto del nazismo e del fascismo, la definizione di “museo” e l’impiego di oggetti e collezioni è altamente problemtica. Il ruolo universalizzante del museo rischia di trasmettere un messaggio equivoco sulle finalità e gli obiettivi di un display, rischiando di “sacralizzare” oggetti e idee che rappresentano la dittatura. In Germania e altrove nel mondo, le esposizioni permanenti sul nazismo non sono state trasformate in musei tradizionali, ma in “centri di documentazione” appunto, continuamente soggetti a trasformazioni e revisioni.
Infine, il caso IWM illustra quanto sia stato lungo il processo di creazione di una mostra di questo tipo - quattro anni dal suo finanziamento e più di 20 anni da quando il complesso dibattito intorno all’Olocausto cominciò a essere formulato attraverso narrazioni visive. Essenziale alla riuscita dal progetto è stata infine la partecipazione di associazioni delle vittime e dei diversi interlocutori del museo stesso. Numerosi sono stati infatti gli stakeholders che hanno partecipato alla creazione della mission statement del progetto, stabilendo obiettivi chiari per l’esposizione, e creando così quelle premesse per una narrazione condivisa.
Bibliografia
- Bardgett S. 2004
The Depiction of the Holocaust at the Imperial War Museum since 1961, “Journal of Israeli History”, 23 (1) - Bardgett S. 2005
Exhibiting Hatred, “News of Museums of History” - Bohm-Duchen M. (ed.) 1996
After Auschwitz: Response to the Holocaust in Contemporary Art, Sunderland: Northern Centre for Contemporary Art - Dawidowicz L.S. 1975
The War against the Jews. 1933– 1945, London: Holt, Rinehart & Wilson - Dawidowicz L.S. 1981
The Holocaust and the Historians, Cambridge: Harvard University Press - Kushner T. 1994
The Holocaust and the Liberal Imagination: A Social and Cultural History, Oxford: Wiley Blackwell - Linenthal E. 1996
History Wars: The Enola Gay and Other Battles for the American Past, New York: Henry Holt - Macdonald S. 2006
Difficult Heritage: Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond, New York: Routledge - Noiret S. 2016
La public history italiana si fa strada, un museo a Predappio per narrare la storia del ventennio fascista, “Digital and Public History”, 9 maggio 2016 - Schleunes K.A. 1970
The Twisted Road to Auschwitz: Nazi Policy toward German Jews. 1933–1939, Champaign: University of Illinois Press - Smith L-J. e Waterstone E. 2010
The recognition and misrecognition of community heritage, “International journal of Heritage Studies”, 16 (1-2) - Tunbridge J.E. e Ashworth G.J. 1996
Dissonant Heritage: The Management of the Past as a Resource for Conflict, Chichester, New York: J. Wiley
Risorse on line
- Imperial War Museum London
https://www.iwm.org.uk/visits/iwm-london - Imperial War Museum London - The Holocaust Exhibition
https://www.iwm.org.uk/events/the-holocaust-exhibition