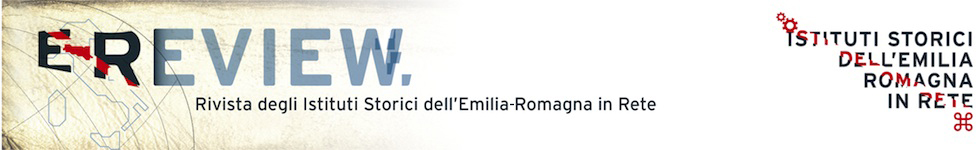Eccellente è il livello raggiunto dall’agricoltura emiliana [anche se] nel complesso
essa è insufficiente ad occupare una popolazione, la cui parte attiva gravita verso l’agricoltura in misura eccessiva, più del 60 per cento. Le condizioni disagiate
della montagna che inducono gli abitanti a scendere verso il piano, hanno aggravato
lo squilibrio […]. L’Emilia è una terra sanguigna, sensuale sul cibo, che spesso vi diventa
quasi un’infatuazione; per questo trasporto greve, profondo e quasi sacro verso le proprie viscere,
le corrispondono soltanto alcune regioni francesi, come il Périgord e la Borgogna.
Guido Piovene, Viaggio in Italia (1957)
Nel dicembre 1946 l’Ispettorato compartimentale dell’Emilia Romagna organizza a Bologna un convegno sulla ricostruzione agricola che contribuisce a definire le linee di un piano in grado di adattarsi alle reti del nuovo assetto creatosi alla fine della guerra. E se sfide e problemi hanno il sapore della novità, identiche sono, invece, le mani della classe agraria e proprietaria cui sono affidate le soluzioni. Orfani della rete di protezione concessa dalla politica autarchica, questi protagonisti vedono nel processo di ricostruzione l’occasione per rilanciare l’agricoltura regionale rendendola competitiva sul mercato internazionale. Sarà una scelta vincente, anche se con i tratti della casualità. Incipit della storia di quella transizione che fa divenire alcune province emiliane tra le più importanti d’Italia nel campo dell’industria leggera (meccanica ma non solo). E del trionfo di una vocazione agricola regionale che si radica e germoglia. Pur tra mille contraddizioni – una fra tutte il pesante consumo del territorio – resta centrale il ruolo del settore agricolo alla base di quell’evoluzione del comparto agroindustriale che trasformerà l’Emilia Romagna nella Food Valley italiana. Si tratta di un’evoluzione che in alcune aree era già iniziata tra Otto e Novecento, aveva conosciuto un’accelerazione negli anni giolittiani, rafforzandosi negli anni Trenta quando la regione – pur nella temperie della crisi economica mondiale – conosce qualche non episodico incremento tecnologico e produttivo. Dopo la guerra, i fili di tutti questi discorsi, sospesi o rimandati, saranno ripresi e intessuti nella trama di una realtà economica plurale e importante. È un risultato che si prepara in anticipo e che s’incardina in una vocazione che «non si limita a mera fruizione di quanto la terra può fornire […] ma investe la mobilitazione delle forze naturali per la produzione di materiali industriali e di beni d’uso, e implica relazioni di mercato e di cultura fra paesi diversi e lontani» [Gambi 1972, 26].
Le trasformazioni del dopoguerra, dunque, si pongono su una linea di continuità con i cambiamenti che, nel corso del Novecento, ma in particolare a partire dalla Prima guerra mondiale, vedono lo stato intervenire sempre più marcatamente in campo economico, spesso con la conseguenza di promuovere interessi locali. E proprio sul piano locale basti pensare alla rinnovata centralità di un’organizzazione come Federconsorzi – fondata a Piacenza nel 1892 – che non aveva mai fatto mancare il proprio sostegno alla politica agraria fascista, anche nei tempi difficili dell’economia di guerra. I Consorzi agrari provinciali (Cap) non solo non scompaiono, ma escono vivificati da una situazione in cui l’impresa agraria specializzata segna il punto di confluenza fra tradizioni locali e nuovo mercato mondiale. Questo dossier ha l’obiettivo di ricostruire le tracce di quella continuità, osservandola nel prisma delle vicende legate alla produzione e al consumo alimentare. Un focus ampio, che non si limita ad analizzare la questione solo dal punto di vista della penuria alimentare o della miseria/fame di guerra (tema già più volte al centro dell’attenzione della storiografia). Si tratta di un dossier volutamente asimmetrico: se la prima messa a fuoco è orientata al secondo conflitto mondiale e al successivo dopoguerra, gli articoli, le immagini e i contributi filmati spaziano su buona parte del primo Novecento, nell’intento di creare una più coerente continuità interpretativa fra i due conflitti, i rispettivi dopoguerra e, in modo particolare, i potenti cambiamenti – qui evocati più che circostanziati – nelle pratiche e nella cultura economiche e politiche nel corso degli anni Trenta. Ed è proprio l’attenzione all’Emilia Romagna a permettere di isolare l’intreccio fra economia del territorio, interessi agrari e modalità di diffusione dell’industria alimentare nel periodo di transizione fra anni Trenta e primissimo dopoguerra. Ne risulta una cronologia volutamente a cavallo fra contesti spesso analizzati separatamente. I saggi, tarati sulla scala locale, illustrano e documentano situazioni territoriali quali indicatori utili e utilizzabili per sondare alcuni nodi tematici. In tal senso la scelta di isolare l’esperienza regionale serve a indicare uno strumento per l’analisi e non va intesa come proposta di riduzione dell’attenzione a un contesto circoscritto. Alcuni casi di studio e approfondimento, infine, riportano la questione su scala nazionale ed europea.
E proprio il rapporto fra modello regionale e modello nazionale è una delle possibili chiavi di lettura del dossier. Un territorio che si sviluppa con ritmi e tendenze simili a quelli delle regioni più sviluppate del paese, ma che si porta dietro una storia e un sistema istituzionale completamente differenti. Il primo Big Push in Emilia Romagna non c’è stato e, al tempo stesso, le classi dirigenti locali non hanno avuto una visione chiara dello sviluppo moderno; in molti casi i più pensano si tratti di qualcosa di paragonabile a quanto avvenuto agli inizi del secolo, quando la costruzione di alcune strade e un certo numero di aree urbanizzate avevano costituito lo spettro di azione per qualche impresa artigiana o poco più. Il partito comunista emiliano, quando ha inizio la ricostruzione, non avverte lo spessore del processo di sviluppo in gestazione. Per molto tempo non lo vedrà, osteggiandolo, invece, frontalmente. Solo nel 1959, con la “svolta” di Guido Fanti alla prima conferenza regionale del partito, il Pci esprimerà esplicitamente il proprio sostegno allo sviluppo. Incontrando numerosi consensi, come pure altrettante resistenze. Certo parlare di Emilia Romagna nel secondo dopoguerra ponendo ai margini il tema delle istituzioni locali può apparire un’omissione. In realtà, l’abbondante letteratura sulla materia esime i curatori di questo dossier dal ripercorrere argomenti e riflessioni già noti. Semmai può essere non del tutto esornativo rammentare al lettore come, nel modello delle sinistre emiliane, il tema della fame, prima, e dell’equità distributiva poi, rappresentino formidabili capisaldi intorno ai quali ruotano le strategie di governo della regione: per gestire l’emergenza nel primo decennio post-bellico, per governare lo sviluppo negli anni del boom. Le scelte dei “comuni rossi” emiliani aprono a una cultura politica capace di drenare e canalizzare risorse – non solo economiche – nell’ideazione di soluzioni innovative a problemi dalla radice secolare.
All’inizio del secondo dopoguerra la struttura economica regionale è per lo più ancora agricola e il reddito del settore primario supera disinvoltamente quello delle attività industriali. Nella fascia collinare e pedemontana prevale la mezzadria, diffusa anche in alcune zone della pianura appoderata; la proprietà coltivatrice ha qualche diffusione nelle zone al confine con Lombardia e Liguria, mentre nel ravennate e nella bassa ferrarese si trovano esempi di conduzione capitalistica con manodopera bracciantile. A sud la montagna inizierà in breve a spopolarsi, soprattutto a causa di dimensioni poderali troppo ridotte che impediscono di assumere quei modelli di vita proposti con efficace insistenza dalla rappresentazione mediatica del boom economico e dai processi di urbanizzazione. E tuttavia lo spopolamento della montagna e della collina è compensato dall’aumento considerevole degli insediamenti lungo la Via Emilia. È un modello che raffigura uno schema di addensamento demografico policentrico capace di sovrapporsi plasticamente alle tendenze territoriali di una crescita economica che corre lungo l’asse principale di scorrimento, ma che s’insinua nelle faglie di una pianura sempre più toccata dai mattoni e dal calcestruzzo dell’industrializzazione diffusa.
Le industrie operanti nel settore alimentare si concentrano nelle aree urbane della parte centrale della regione (Bologna, Modena e Reggio Emilia, dove sono anche le attività produttive legate al metalmeccanico e metallurgico, ma in cui emergono settori innovativi come la maglieria e la ceramica). Sono, spesso, di media dimensione, sopravvissute al conflitto grazie alla loro specializzazione settoriale o alle commesse statali dell’economia di guerra. Nei centri urbani resiste un tessuto di piccole attività industriali e artigiane connesse all’agricoltura e al mercato locale. Nel triennio 1937-1940 il censimento industriale aveva attestato che quella alimentare fosse la prima industria regionale con circa 65.000 addetti, che rappresentavano quasi il 30% dell’occupazione manifatturiera [Zamagni 1997, 139]. Una situazione tutto sommato florida, ma destinata a essere sconvolta dalla distruzione che colpisce zone che, fra il 1943 e il 1945, diventano l’area di combattimento della Linea gotica. Dopo la guerra prevale la voglia di ricominciare, anche se manca un piano nazionale di ricostruzione e le difficoltà materiali sono imponenti. La continuità con il periodo prebellico appare spesso una scelta obbligata e le infrastrutture (materiali e sociali) sono ricostruite sui monconi già esistenti. Ma i criteri-base del processo di ricostruzione sono assai differenti da quelli del modello del settore industriale nel quale s’intrecciano gli interessi particolari dei gruppi imprenditoriali e gli obiettivi della classe politica (sostenuti, peraltro, dagli intenti del Piano Marshall). Il settore agricolo, da cui la crescita dell’industria alimentare dipende, è contraddistinto dalla combinazione di tali eterogeneità e stratificazioni che ostacola l’identificazione di obiettivi riconducibili a un progetto complessivo. Oltre lo scoglio, fattuale, della ricostruzione, la ripresa dello scontro di classe nelle campagne – che si salda in un tutt’organico con le lotte sindacali di fabbrica – apre uno scenario certo non originale (basti pensare al clima di aspra conflittualità che aveva acceso le campagne emiliana a cavallo del secolo, per protrarsi sino all’avvento del regime fascista), ma per tanti versi inedito nella sua nuova conformazione.
In questa dinamica si ritaglia un proprio spazio la rappresentanza politica di una classe agraria che aveva alle spalle esperienze di un modello capace di farsi sistema. Lo slancio spontaneista dei più intraprendenti è una variabile inattesa, che pure avrà un suo peso. Dopo le elezioni del 1948 il rafforzamento degli apparati pubblici a livello nazionale sancisce che tutti gli esperimenti di economia a carattere pubblico o cooperativo usati in modo privatistico dalla possidenza terriera (Federconsorzi, Ente risi, Consorzi di bonifica, solo per fare gli esempi più noti) sono la scelta più opportuna e disponibile. Quella che si era già misurata con la realtà di un passato al quale, dopo la tragedia della guerra, non appariva così male pensare di ritornare.
Anche le vocazioni, così, si riproducono. Nelle province orientali che già negli anni Trenta avevano investito nell’arboricoltura, ad esempio, si procede a ricostituire il patrimonio arboreo perduto a causa dei pesanti danni di guerra, in quella che appare come una vera e propria “ricostruzione agricola” [Cazzola 1980, 87]. Forse è anche per questo che in terra d’Emilia – povera, contadina, devastata da un anno e mezzo di fronte e ora governata dalla forza di un moralismo bolscevico incrollabile che intende superare le diseguaglianze esistenti – si compone una saldatura tra elementi che sembrano, e sono, in netto contrasto, ma che avviano a una ripresa economica così originale. Forse. Certo è che il richiamo a “rimboccarsi le maniche” e mettersi al lavoro dopo la guerra per ricostruire città, strade e stabilimenti ha, qui, un retrogusto particolare. Di una memoria recente della sofferenza che non passa – e non può passare – perché si sovrappone alla memoria di un’altra atavica sofferenza, radicata nelle miserrime condizioni di vita. Certo un po’ migliori di quelle del contadino lucano, ma ancora confinate nella dimensione della frugalità quando non della povertà. Povertà pacificata, si potrebbe dire. Che s’inscrive tuttavia in una visione del mondo nella quale la dedizione assoluta al lavoro – plasmata sui ritmi lavorativi della vita contadina – scandisce la quotidianità delle cose e delle persone, e annuncia un addio che si fa lunghissimo. Per averne testimonianza, si provino a riguardare i filmati – girati fra gli anni Cinquanta e Sessanta – sulla nascita del distretto tessile a Carpi per comprendere cosa significasse questa dedizione e di come possa configurarsi come uno degli ingredienti più importanti del “miracolo” distrettuale emiliano.
È un movimento di ritorno selettivo. Quando l’Italia si affaccia al dopoguerra i ricordi della fame e degli artifizi per mettere in tavola quel che resta delle famiglie durante la guerra, sono ancora vividi. È una memoria che lascia a lungo tracce di sé: almeno fino ai primi anni Sessanta, infatti, prevale uno stile di morigeratezza che induce al riciclo e al riuso. Il “sistema Carosello”, che pure traghetterà il paese a un diverso rapporto con le merci, irrompe in una società ancora piuttosto povera (solo dalla seconda metà degli anni Sessanta molti italiani arrivano ad avere risorse economiche sufficienti per poter diventare “consumatori”) e caratterizzata da una sobrietà di fondo che risente in parte della tradizionale matrice culturale contadina, ma anche da un passato recente che fatica a passare. Solo più tardi la generazione di chi è nato e cresciuto nell’abbondanza potrà accedere a modelli di consumo più disinvolti. L’Emilia rossa si scoprirà così una terra di consumi che andranno ben oltre quel paniere di sobrietà che rappresentava comunque il proprio ancoraggio ideale e identitario. Solo negli anni Sessanta l’Emilia Romagna avrà archiviato la “memoria della fame” per accompagnare al successo un sistema economico in cui le lavorazioni agroalimentari avranno un ruolo di spicco, divenendo una delle espressioni più significative – nel mercato nazionale come pure in quelli esteri – del “made in Emilia Romagna”.
Riferimenti bibliografici
- Cazzola F. 1980
- La trasformazione del paesaggio agrario, in D’Attorre P.P. (a cura di), La ricostruzione in Emilia Romagna, Parma: Pratiche.
- Gambi L. 1972
- Valore storico dei quadri ambientali, in Storia d’Italia, vol. I, I caratteri originari, Torino: Einaudi.
- Piovene G. 1957
- Viaggio in Italia, Milano: Mondadori.
- Zamagni V. 1997
- Una vocazione industriale diffusa, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi. L’Emilia Romagna, a cura di Finzi R., Torino: Einaudi.