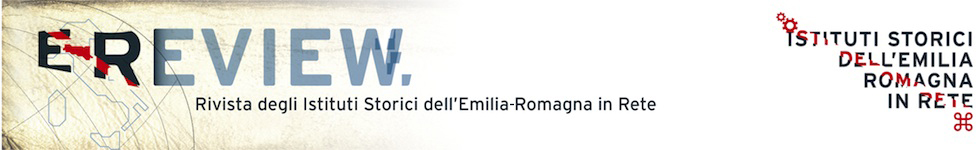Il presente saggio si propone di ricostruire le modalità con le quali le autorità di Pubblica sicurezza della Repubblica sociale italiana (Rsi) applicarono le disposizioni antisemite stabilite dal governo, contribuendo così all’arresto di migliaia di ebrei e alla loro deportazione dall’Italia. Nel primo paragrafo si analizzerà brevemente la normativa decisa dalla Rsi, che radicalizzò le misure antiebraiche prese dal regime fascista nel 1938 e nel corso della guerra, eliminando le cosiddette “discriminazioni” previste dalla precedente legislazione. Si rifletterà poi sul ruolo che, nel periodo della persecuzione delle vite [Sarfatti 2018], ebbe la realizzazione di un fitto sistema di campi di concentramento “provinciali” dove furono rinchiuse centinaia di ebrei, arrestati esclusivamente dalla polizia italiana, molti dei quali deportati nei lager di sterminio. Si proverà così a ragionare sulla collaborazione tra le autorità italiane e quelle tedesche di occupazione nelle pratiche di arresto e deportazione. Infine, si approfondiranno tre casi di campi per ebrei aperti in provincia: a Grosseto, a Padova e a Perugia. Attraverso questi tre casi sarà possibile osservare in che modo la normativa decisa ai vertici venne applicata localmente e fu interpretata da funzionari amministrativi e agenti responsabili sul territorio: ogni provincia ebbe infatti una storia a sé.
1. 30 novembre 1943: la macchina amministrativa si (ri)mette in moto
Il 14 novembre 1943, nel discorso che aprì il congresso del nuovo Partito fascista repubblicano (Pfr) il segretario Alessandro Pavolini dichiarò davanti alla folla dei fedelissimi riuniti a Verona: «Per quel che riguarda gli ebrei la direzione del partito propone che in questa materia si adotti una formula che non lasci campo ad equivoci e che dica che gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri che durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica». Tra applausi e voci di entusiasta approvazione, continuava: «Con tutte le conseguenze, per chi ha studiato questo problema, che questa dichiarazione comporta, perché è la dichiarazione che taglia la testa al toro [...]; niente discriminazioni» [1] [D’Angeli 2016].
Passarono poche settimane e con l’ordinanza di polizia n. 5 del 30 novembre 1943, firmata dal ministro dell’Interno Guido Buffarini Guidi, la Repubblica sociale italiana intervenne ufficialmente nella cosiddetta “questione ebraica”, disponendo il sequestro (e più avanti la confisca) dei beni posseduti dagli ebrei a favore delle popolazioni danneggiate dalla guerra e l’arresto e l’invio di tutti gli ebrei in campo di concentramento: italiani e stranieri, uomini, donne o bambini, giovani e vecchi. Insomma «niente discriminazioni», diversamente da quanto avvenuto dal 1938 in poi.
L’ordinanza ministeriale era molto chiara riguardo la sorte delle persone di origine ebraica: andavano aperti dei campi di concentramento in ogni provincia dove rinchiudere chi veniva progressivamente arrestato, in attesa che fossero realizzati uno o più campi definiti «speciali», attrezzati cioè per contenere le migliaia di individui da fermare. Nell’Italia centro-settentrionale, corrispondente al territorio della Rsi, in base ai più recenti censimenti erano presenti infatti tra i 30 e i 40 mila ebrei, italiani e stranieri [Picciotto 2011; Sarfatti 2018].
La disposizione intendeva inoltre regolare una questione che sembrava essere finita dopo l’8 settembre nelle mani delle autorità tedesche scese ad occupare l’Italia: gli uomini della sezione IV-B4 agli ordini di Eichmann, dipendente dalla Direzione generale per la sicurezza del Reich (RSHA) e responsabili della “soluzione finale” nell’Europa occupata, avevano organizzato tra settembre e novembre retate di ebrei in molte città, arrestando e deportando migliaia di persone – solo a Roma, il 16 ottobre 1943, ne furono prese e deportate più di mille. Ciò avvenne non senza la collaborazione di agenti italiani, delle Prefetture e delle Questure, che comunicarono, o almeno non distrussero, gli elenchi degli ebrei censiti o schedati negli anni precedenti.
Già dal giorno successivo alla diramazione dell’ordinanza n. 5, la macchina amministrativa di Salò si mise, o piuttosto, si rimise in moto: le autorità italiane non erano certo nuove a misure di internamento che colpivano anche individui di origine ebraica. Il compito di arrestare e internare gli ebrei fu affidato alle Prefetture e alle Questure e agli uomini ai loro ordini, che si attennero alle disposizioni contenute nella circolare di fine novembre e in altre comunicazioni ricevute nel corso di dicembre. Quasi subito, infatti, fu necessario un chiarimento riguardo la tipologia delle persone da fermare: il capo della polizia Tullio Tamburini, il 10 dicembre, precisò che andavano rinchiusi in campo di concentramento tutti gli ebrei stranieri e quelli “puri” italiani; i malati gravi e gli anziani, «salvo adeguate misure di vigilanza», dovevano invece essere esonerati, almeno «per ora», così come coloro che facevano parte di una famiglia mista [2]. Considerazioni di carattere organizzativo avevano convinto il capo della polizia a rendere più graduale le pratiche di arresto e di internamento. Fu lo stesso ministro dell’Interno, tuttavia, che alla fine di dicembre ci tenne a ribadire, esprimendosi con un linguaggio molto duro, quanto stabilito inizialmente: «Disposizioni emanate con ordinanza di polizia in data primo corrente numero 5 nei confronti degli ebrei non hanno dico non hanno subito alcuna modificazione a seguito delle disposizioni emanate con telegramma dal capo della polizia». Queste ultime erano solo di carattere esecutivo «attesa la necessità di approntare gli alloggiamenti secondo ogni norma igienica e funzionale alt» [3].
Le circolari inviate nel mese di dicembre diedero il via ufficialmente alla persecuzione fisica degli ebrei da parte dell’amministrazione di Salò, portata avanti con zelo da agenti di polizia e carabinieri. Appoggiandosi agli elenchi degli ebrei schedati negli anni precedenti e durante la guerra, nonché approfittando di denunce e delazioni, le questure cominciarono la ricerca delle persone da fermare, casa per casa, ma ovunque gli stessi perseguitati si presentarono spesso spontaneamente alla polizia dopo aver appreso la notizia delle nuove misure antisemite: il testo dell’ordinanza venne infatti trasmesso via radio e pubblicato in prima pagina su tutti i principali quotidiani dell’epoca, accompagnato da commenti e articoli che appoggiavano e motivavano questa iniziativa del governo [4].
Quanto disposto nell’ordinanza di fine novembre prevedeva dunque la creazione di appositi campi di concentramento provinciali. Nelle grandi città, generalmente, gli ebrei furono rinchiusi nelle prigioni, prima di essere trasferiti in un campo speciale o direttamente deportati, come avvenne dal carcere milanese di San Vittore [Picciotto 2011]. In alcune province le autorità provarono ad aprire dei campi ma si scontrarono con problemi logistici o vi rinunciarono in accordo con i comandi germanici presenti in zona. Altrove ci si appoggiò a campi già in funzione durante la guerra, creati negli anni precedenti per internare prigionieri militari e stranieri nemici, ebrei inclusi, [Capogreco 2004] oppure si decise di aprire nuove strutture denominate dalle stesse autorità “campi provinciali”: fu questo il caso di circa venti province dell’Italia centro-settentrionale [5] [Stefanori 2017].
2. Il funzionamento ordinario dei campi
In continuità con quanto fatto negli anni precedenti in materia di internamento, i campi provinciali furono ricavati requisendo o prendendo in affitto ville private, seminari, alberghi e colonie estive, caserme, edifici pubblici come le scuole: luoghi che avevano una funzione civile, religiosa o culturale nella vita quotidiana di una città o di un paese. L’amministrazione di Salò non produsse nessun nuovo regolamento per l’applicazione delle pratiche di internamento, ma riprese le direttive inviate alle autorità locali già nel giugno 1940, quando si cominciarono ad internare nemici e stranieri per motivi bellici [Capogreco 2004].
Una volta individuata una struttura adatta allo scopo, il capo della provincia (nuova denominazione del prefetto negli anni della Rsi) e il questore nominavano un direttore del campo, quasi sempre un agente di Pubblica sicurezza: assegnavano inoltre il personale di sorveglianza, formato generalmente da un ristretto nucleo di agenti di polizia, di carabinieri o uomini della Guardia nazionale repubblicana (Gnr). I direttori si occupavano delle questioni più pratiche relative al funzionamento: firmare con i proprietari degli stabili prescelti un accordo di concessione e un contratto di affitto, attrezzare il campo dei materiali necessari al suo funzionamento, provvedere ai rifornimenti di cibo rivolgendosi alle aziende locali. Gli spacci alimentari di zona garantivano il vitto giornaliero per gli internati e gli agenti di sicurezza. Una significativa sintesi di cosa avvenisse nelle fasi iniziali di apertura dei campi emerge da quanto comunicato dal questore di Aosta, a metà dicembre ‘43, al capo di quella provincia:
La direzione del campo di concentramento verrà assunta dal Commissario PS Cav. Dott. Alberto [...], il quale è pregato di prendere fin d’ora contatto con il Commissario prefettizio del comune di Aosta per la pulizia e la disinfestazione dei locali, per la sistemazione del recinto metallico atto ad impedire evasioni dal campo di concentramento, per il collocamento delle stufe e relative tubazioni per il riscaldamento dei locali, per l’adattamento dei lavatoi, latrine, cucina, per lo impianto della luce elettrica e del telefono e per tutte le altre opere necessarie per il normale funzionamento del campo di concentramento, tenendo presente che l’allestimento è previsto per circa 50 ebrei. Il funzionario verrà coadiuvato per la parte contabile e burocratica dall’applicato sig. D. C. M. il quale dovrà avere un proprio ufficio nell’ex caserma Mottino, provvisto di tavolo sedie e armadietto [...]. Il direttore del campo di concentramento provvederà perché siano allestiti i locali necessari per la permanenza nel campo dei militari […] scrittoio, armadietto e sedie per il sottoufficiale preposto al servizio di vigilanza. Il Cav. Dott. [...] prenderà accordi con il comando della Milizia forestale e con il Direttore del consorzio agrario di Aosta Cav. B. per la fornitura di combustibile per il riscaldamento. Provvederà inoltre alla fornitura di tutte le brande, pagliericci, lenzuola coperte, stoviglie e gavette, utensili di cucina, necessari per i dormitori e per il funzionamento della cucina; nonché alla fornitura giornaliera dei generi di alimentazione […] [6].
Per ogni questione economica era obbligatorio il passaggio per gli uffici centrali del Ministero. Gli uffici prefettizi ratificavano la requisizione degli edifici e l’erogazione degli indennizzi previsti dai contratti stipulati con i proprietari. Per ottenere un rimborso, le autorità provinciali dovevano presentare invece al Ministero le fatture rilasciate dai fornitori e dalle aziende coinvolte sul luogo: falegnami, fabbri, spacci alimentari ecc. Spesso sono proprio queste ricevute di pagamento a trasmetterci notizie sui campi provinciali, in mancanza di altri documenti ufficiali, andati dispersi o distrutti. A Forlì, ad esempio, una fattura rilasciata dalla Cooperativa Lavoranti Falegnami indicava l’indirizzo esatto dell’edificio nel quale sorgeva il campo provinciale: questa azienda richiese infatti il pagamento per «la costruzione di un divisorio in legno nel corridoio dell’Albergo “Commercio” sito in Corso Diaz di questa città, adibito a campo di concentramento provvisorio degli ebrei di questa provincia» [7].
In base a una diffusa procedura di pagamento, le spese erano sostenute attingendo alle casse delle amministrazioni periferiche: i comuni si facevano garanti di fronte ai fornitori e spesso anticipavano le somme, presentando poi il conto agli uffici centrali del Ministero per il rimborso. Data la scarsa disponibilità di risorse economiche durante la guerra, in realtà molte pratiche rimasero inevase e sospese fino al termine del conflitto.
Sulla base della documentazione disponibile negli archivi è possibile fare solo una stima del numero delle persone che transitarono nei campi provinciali: furono almeno 800, arrestate tutte dalle autorità di polizia italiane. L’età media degli internati era compresa tra i 30 e i 60 anni, in linea con quanto disposto dal governo di Salò, ma vi finirono anche bambini, anziani e malati, in realtà esclusi dalla misura di arresto; più o meno uguale fu invece la proporzione tra uomini e donne, così come quella tra italiani e stranieri [Stefanori 2017]. Questi ultimi dati variavano moltissimo a seconda della provincia in cui erano avvenuti gli arresti e della situazione che si era creata localmente nel corso di quegli anni di guerra: se si trattava cioè di regioni dove erano confluiti sfollati dalle grandi città, dove nei mesi precedenti vi erano stati approntati già dei luoghi di internamento per stranieri, se era una zona in cui agivano i partigiani o soggetta a rastrellamenti [Acciai 2016].
3. La collaborazione con i tedeschi
Pur in presenza di ordini e disposizioni emanati dai vertici della Rsi, gli amministratori di Salò dovettero continuamente fare i conti con le insistenti pressioni provenienti dalle autorità tedesche di occupazione, che chiedevano una più stretta collaborazione ai loro piani di deportazione e sterminio e di applicare misure più rigide di quelle adottate dal governo repubblicano: nello specifico, arrestare e inviare nei campi anche i malati, i bambini, gli anziani e i cosiddetti “misti”, esclusi temporaneamente dal provvedimento, e consegnare nelle loro mani gli ebrei fermati dalla polizia italiana.
Dalla fine di dicembre ‘43, gli ebrei arrestati e internati in ogni provincia iniziarono ad essere trasferiti, secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 5, verso l’unico campo di concentramento speciale aperto sul territorio: l’ex campo per prigionieri di guerra vicino Modena, a Fossoli di Carpi. Alla fine di febbraio 1944 i comandi della polizia germanica assunsero la direzione della parte di campo dove confluivano gli ebrei e gli arrestati per motivi politici, destinati alla deportazione nei lager nazisti. Di fatto, da quella data in poi, inviare gli ebrei a Fossoli voleva dire consegnarli nelle mani dei tedeschi. Proprio dal campo modenese partirono dodici convogli di ebrei diretti ai campi di concentramento e sterminio dell’Europa orientale: il primo con destinazione Auschwitz lasciò Fossoli il 22 febbraio 1944 ed era formato da più di 500 ebrei italiani e stranieri, provenienti dai campi provinciali e dalle prigioni di molte città [Picciotto 2010; D’Amico 2015]. Nell’estate del ‘44, di fronte all’avanzata degli Alleati, Fossoli fu evacuato e le deportazioni vennero organizzate in strutture in funzione nelle regioni nordorientali della penisola, sotto il diretto controllo delle autorità del Reich: il campo di Bolzano-Gries e quello allestito nei locali della ex Risiera di San Sabba a Trieste [Picciotto 2011].
Di fronte alle continue pressioni tedesche, che contrastavano con le disposizioni ufficiali ricevute dal governo, le autorità provinciali della Rsi domandarono ai vertici ministeriali se dovessero aderire alle richieste dell’alleato germanico o continuare a seguire gli ordini repubblicani. In risposta, il capo della polizia Tamburini trasmise, a distanza di poche ore l’uno dall’altro, due telegrammi il 21 e il 22 gennaio 1944, nei quali chiedeva di spedire nei campi tutti gli ebrei puri di qualsiasi nazionalità, anche quelli definiti “discriminati”, ma di attenersi comunque alle disposizioni italiane, spiegandone i contenuti ai comandi tedeschi di zona: nel frattempo il Ministero si sarebbe impegnato ad accordarsi con le autorità centrali germaniche affinché fossero ordinate «direttive intese assicurare permanenza ebrei campi italiani» [8]. In realtà, nella confusione di quel periodo di guerra, i due telegrammi arrivarono in ritardo in alcune province, nonché sovrapposti. A distanza di un mese e mezzo, il capo della polizia riprese la questione in una nuova circolare [9].
La soluzione di lasciare alle autorità locali il compito di gestire i rapporti di collaborazione con le forze alleate tedesche non era nuova, ma si poneva in continuità con quanto già iniziato a fare nei mesi precedenti e, soprattutto, nelle settimane successive all’occupazione nazista della penisola. Per esempio, l’11 settembre 1943 il prefetto di Lucca, quando ancora la Rsi non era nata, propose agli organi centrali del Ministero dell’Interno di rinchiudere in un campo di concentramento gli ebrei presenti nella provincia, onde evitare che questi potessero scappare, spaventati dalla presenza dei tedeschi e dal pericolo di essere trasferiti in Germania. Il Ministero rispose a inizio novembre di intensificare la vigilanza su di essi e di prendere accordi con le locali autorità germaniche [Sarfatti 2018] [10].
Provare a stabilire se sia esistito o meno un accordo segreto ai vertici tra autorità italiane e tedesche per collaborare alla deportazione degli ebrei, come fatto da Michele Sarfatti [Sarfatti 1997 e 2018], è sicuramente utile per riflettere sui caratteri della politica antisemita di Salò e sulle responsabilità che ebbero i principali esponenti governativi nel prendere decisioni che favorirono i piani di sterminio. Tuttavia, per capire meglio le modalità di questa collaborazione occorre concentrare l’attenzione su quello che accadde in ogni provincia: tenute all’oscuro, almeno da quanto emerge dalla documentazione, di un’intesa ai vertici, le autorità locali provarono infatti a muoversi sulla base della normativa emanata dal governo repubblicano e da loro ricevuta, che non prevedeva nessun ordine di deportazione dall’Italia.
L’applicazione delle misure decise ai vertici ministeriali determinò situazioni molto diverse. In alcuni casi, la sorte degli ebrei dipese esclusivamente dalle intenzioni dell’alleato germanico, che non tenne conto del parere di Questure e Prefetture italiane. Ma i dati relativi alla tipologia degli internati nei campi provinciali indicano che, nonostante le pressioni germaniche, le autorità italiane riuscirono a ritagliarsi un certo spazio di autonomia nell’esecuzione degli arresti: collaborarono cioè solo in maniera parziale ai piani nazisti, continuando a mettere in pratica le disposizioni governative e a escludere dalle misure d’internamento gli anziani, i malati e, in molti casi, i cosiddetti misti. Molti ebrei rinchiusi nei campi provinciali, almeno un centinaio [Stefanori 2017], furono fatti uscire in osservanza delle norme italiane e non vennero trasferiti a Fossoli: alcuni scamparono alla deportazione, altri invece finirono in successive retate, furono vittime di ulteriori delazioni oppure caddero nelle mani degli uomini delle bande autonome nazifasciste operanti sul territorio. Diverso invece il discorso relativo alla consegna degli ebrei ai tedeschi, sulla quale l’amministrazione italiana non sembrò avere troppa libertà di azione, considerato anche lo squilibrio delle forze favorevoli all’alleato “occupante” [Klinkhammer 2007].
Sebbene le direttive ministeriali lasciassero ampia discrezionalità agli amministratori locali, nella maggior parte dei casi non si assiste a una piena e automatica collaborazione ai piani tedeschi: salvo eccezioni, capi provincia e questori comunicarono al Ministero i tentativi di ingerenza negli affari italiani e a volte sembrarono stupirsi di fronte a richieste che scavalcavano la normativa di Salò, segnalando le loro perplessità agli uffici centrali e attendendo chiarimenti e autorizzazioni prima di procedere. Emblematico è il caso di Verona e del capo di quella provincia, Piero Cosmin, sulla cui fedeltà al fascismo repubblicano e all’alleanza con i tedeschi non vi sono dubbi [Cifelli 1999, 60] [11]: in quei mesi aveva collaborato con le forze germaniche presenti in zona, gestendo con fermezza l’ordine pubblico e occupandosi del processo di Verona contro i “traditori” del 25 luglio. Ricevuta l’ordinanza di arresto degli ebrei si impegnò ad applicare, in accordo sempre con i tedeschi, quanto stabilito da Salò. Apparve però spiazzato nel leggere, a fine febbraio ‘44, la missiva del comandante di zona della Gnr, il quale segnalava che la polizia germanica intendeva chiudere il campo provinciale per ebrei da lui aperto e deportare gli internati «fuori Italia». Mise infatti un evidente punto interrogativo a matita rossa proprio vicino questo passaggio della lettera, rimarcando qualcosa che in realtà non avrebbe dovuto suscitare in lui troppi dubbi: da gennaio, proprio a Verona, si era insediato l’ufficio della RSHA di Friedrich Bosshammer responsabile della questione ebraica e le deportazioni di ebrei dall’Italia erano iniziate già da tempo [Berger 2016, 126-129, 137].
In alcune occasioni non è escluso che intervennero considerazioni di carattere umanitario a influenzare le scelte di singoli funzionari o agenti. Tuttavia, furono soprattutto motivazioni politiche che sembrano guidare l’atteggiamento dell’amministrazione italiana. A dirigere le Prefetture e, spesso, le Questure della Rsi erano stati chiamati uomini di comprovata e antica fede fascista (fascisti della “prima ora” e attivi nel movimento fin dalla marcia su Roma), che condividevano di certo l’opportunità di applicare una radicale politica antisemita e di collaborare con gli alleati di Berlino: allo stesso tempo, però, non consideravano affatto il loro governo un “fantoccio” in balia dei comandi tedeschi, ma un regime che governava l’Italia da più di vent’anni e che si era rinnovato eliminando i “traditori” del 25 luglio [Borghi 2001; Cassese 2010; Melis 2018]. Continuare ad applicare la normativa italiana senza cedere alle richieste tedesche serviva quindi a dimostrare l’esistenza amministrativa dello Stato di Salò [12].
Nel successivo paragrafo verranno ripercorsi brevemente tre casi locali (Grosseto, Padova e Perugia), che mostrano la complessa e variegata interpretazione che le autorità locali della Rsi diedero alla normativa decisa dal governo e le modalità con cui questa venne applicata nelle province in cui entrarono in funzione dei campi di concentramento provinciali.
4. Grosseto, Padova e Perugia
Cinque giorni prima che l’ordinanza di fine novembre fosse trasmessa agli organi periferici della Rsi, Alceo Ercolani, capo della provincia di Grosseto, comunicò alla Direzione generale della Pubblica sicurezza che, a partire dal 28 di quello stesso mese, sarebbe entrato in funzione un campo di concentramento provinciale per ebrei. Le spese per la sua realizzazione sarebbero state coperte con una parte dei fondi a disposizione della Prefettura (circa 100.000 lire) mentre il resto sarebbe stato recuperato attraverso il sequestro dei beni ebraici. Ad ospitare il campo fu il seminario della curia vescovile nella frazione di Roccatederighi, nel comune di Roccastrada: l’edificio era di proprietà della Chiesa locale, con la quale l’amministrazione provinciale stipulò un contratto di affitto (e le cui rate ancora non pagate furono reclamate a guerra conclusa) [Collotti 2007b].
Interventista e volontario a soli quindici anni in Francia nella Prima guerra mondiale, Alceo Ercolani aveva combattuto poi sul fronte italiano tra il 1915 e il 1918. Fascista “della prima ora”, nel dopoguerra fondò il fascio di Bomarzo, suo paese natale, e partecipò alle campagne militari in Africa e in Spagna: in seguito divenne Federale di Treviso e Ispettore della Gioventù italiana del Littorio. Dopo l’8 settembre, rimasto fedele a Mussolini, fu nominato commissario straordinario del Pfr e capo della provincia di Grosseto dal 22 ottobre del ’43 al giugno del ‘44. Successivamente divenne presidente dell’Ente nazionale per l’assistenza ai profughi e la tutela delle cosiddette “terre invase” [13]. Nella sua attività da prefetto si dedicò con decisione alla lotta contro le bande partigiane e alla persecuzione dei renitenti alla leva. Di questo spregiudicato autoritarismo e della sua volontà di eseguire con rigore gli ordini del nuovo Stato fascista fecero le spese anche gli ebrei: già il 5 ottobre del ‘43 tre persone di origine ebraica furono arrestate nel contesto di azioni di polizia dirette a colpire ogni attività antifascista nella zona. Come spiega Luciana Rocchi, «è legittimo pensare che abbia agito il pregiudizio antiebraico […] ma il dato che si intende qui sottolineare è la contestualità con le ricerche di stranieri, internati politici, antifascisti: sostanzialmente un problema di ordine pubblico e di pulizia di un territorio vasto e difficile, dove già avevano cominciato a organizzarsi le formazioni partigiane» [Rocchi 2007, 286].
Le misure di arresto per motivi razziali di fine novembre furono precedute da un’intensa e precoce attività di spoliazione dei beni ebraici, riscontrabile in tutta la regione in realtà. Le stesse autorità tedesche di occupazione rilevarono lo zelo antisemita in una nota del 18 novembre 1943: «il capo della provincia di Grosseto [...] ha ordinato di concentrare tutti gli ebrei della provincia di Grosseto in un campo di raccolta. […] Al di là della consueta gentilezza degli italiani, non si può disconoscere, particolarmente nel caso dei prefetti di Pisa e di Grosseto molto energici e dinamici, che ci troviamo di fronte ad un vivo desiderio di leale collaborazione» [Rocchi 2007, 285].
Ercolani fu in realtà l’unico capo provincia della Rsi ad agire prima dell’ordinanza di Buffarini Guidi. Appresa la notizia di quanto avvenuto a Grosseto, la Direzione generale di Pubblica sicurezza inviò un critico telegramma nel quale, tra le altre cose, ricordava che «la costituzione e l’organizzazione dei campi di concentramento, come è noto, sono di competenza di questo Ministero»: chiedeva inoltre maggiori informazioni sulla struttura aperta a Roccatederighi e sulla persona nominata al ruolo di direttore [14]. Il chiarimento arrivò qualche settimana dopo:
In evasione alla nota suindicata comunico che l’ordine di istituire dei campi per il concentramento dei cittadini di razza ebraica fu impartito a Firenze dall’Eccellenza Buffarini nella riunione dallo stesso tenuta ai Capi della Provincia. Poiché disposizioni in dettaglio da parte di codesta Direzione generale si sono attese invano, in adempimento dell’ordine impartito dal Ministero ho ritenuto urgente ed indifferibile istituire il campo in oggetto affidandone la direzione al maresciallo di PS di questa Questura Rizziello Gaetano segnalatomi dal Questore come elemento idoneo e capacissimo [15].
La vicenda di Grosseto dimostra quanto fosse importante la discrezionalità delle autorità locali nell’eseguire e interpretare gli ordini, aspetto questo che determinava anche le modalità e l’intensità della persecuzione. Ercolani ad esempio fu uno dei pochi capi provincia che dispose a guardia del campo una sorveglianza sicuramente sproporzionata rispetto alle reali esigenze. Oltre al direttore, sostenuto nel suo ruolo da tre agenti di pubblica sicurezza, ordinò:
Il comando della 98° legione [...] invierà sul posto 20 militi con un ufficiale, muniti di almeno due mitragliatrici e due fucili mitragliatori ed un congruo numero di bombe per ciascun milite. Con detta forza, che sarà scaglionata lungo il reticolato, provvederà alla vigilanza sia di notte che di giorno, perché gli internati per nessun motivo varchino il reticolato stesso od abbiano comunque comunicazioni con le persone esterne, che d’altra parte, non possono avvicinarsi ai detti reticolati.
E, come se non fosse già sufficiente, «l’Arma dei carabinieri provvederà a tenere permanentemente all’esterno dei reticolati una pattuglia che vigilerà che nessuna persona, ad eccezione di quelle autorizzate si avvicini a detto campo, coadiuvando la milizia per le eventuali evasioni di detti internati» [16].
Nei mesi in cui restò in funzione, nel campo di Roccatederighi transitarono 80 persone, arrestate tutte nei giorni seguenti l’apertura, molte delle quali si erano presentate in Questura spontaneamente (41 italiani e 39 stranieri): già il 18 gennaio le presenze erano scese a 75 e il mese successivo a 64, frutto dell’applicazione delle norme relative alla tipologia di persone da escludere dalla misura d’internamento. A questo proposito, Ercolani fu anche uno dei pochi capi provincia a domandare al Ministero se dovessero essere seguite, nelle pratiche di accertamento razziale, le leggi italiane o quelle tedesche [17]. Osserva sempre Luciana Rocchi che «la disinvolta citazione della legge di Norimberga […] lascia supporre una disponibilità acritica all’accoglimento di qualsiasi direttiva in materia e a una pragmatica semplificazione di ogni possibile conflitto di competenza tra norme italiane e tedesche» [Rocchi 2007, 294].
Il 18 aprile del ‘44 vennero trasferiti a Fossoli di Carpi con bus di linea di una società privata locale 21 ebrei internati nel campo, 12 stranieri e 9 italiani, scelti probabilmente dal direttore di Roccatederighi seguendo l’ordine alfabetico della lista delle persone concentrate (salvo eccezioni e scelte arbitrarie fatte a favore di alcuni individui). Altri 25 ebrei, tutti stranieri stavolta, partirono per Fossoli il 7 giugno, sostando al campo provinciale di Scipione Salsomaggiore, vicino Parma. Due giorni dopo Roccatederighi smise di funzionare con l’arrivo degli Alleati. Gli ebrei del primo trasporto finirono tutti deportati nei lager nazisti; del secondo gruppo, invece, ne risultano deportati solo una parte, ovvero le 15 persone che vennero trasferite di sicuro a Fossoli. Se si aggiunge anche la vicenda di altri internati partiti da Roccatederighi al di fuori di questi due trasporti, il totale dei deportati che transitarono per il campo provinciale di Grosseto ammonta a 38 persone [Rocchi 2007, 297-300].
Anche a Padova e nel suo territorio provinciale, il ritorno al governo di Mussolini fece riemergere i sentimenti antisemiti più radicali, rimasti sotto silenzio nel periodo badogliano: giornali locali come “Il Veneto” o “Il Gazzettino” non esitarono a incolpare gli ebrei con violente campagne propagandistiche, accusandoli di aver tramato il tradimento del 25 luglio e dell’8 settembre e di non aver sostenuto l’impegno militare del regime, anzi di essersi arricchiti ai danni degli italiani messi in ginocchio dalla guerra [Selmin 2011; Stefanori 2017].
Il campo provinciale entrò in funzione appena due giorni dopo l’invio dell’ordinanza del 30 novembre. Fu ricavato all’interno di una villa privata in località Vo’ Vecchio, a pochi chilometri da Padova, che apparteneva a un ragioniere e nella quale, nei mesi precedenti, si era trasferito un gruppo di suore sfollate. L’edificio fu requisito dalla Prefettura in cambio di un indennizzo economico e riadattato nel giro di pochi giorni a campo di concentramento grazie all’impegno del direttore, nominato dal questore. Le attrezzature che mancavano alla struttura furono prese dall’ex campo per prigionieri di Saonara, località sempre in provincia di Padova: mediante un accordo tra i sindaci di Saonara e di Vo’ Vecchio, firmato anche dal direttore del campo, alcuni materiali passarono in consegna al podestà di Vo’ e furono poi destinati alla villa (97 coperte, 100 pagliericci da usare come letti, 100 traversine, 8 lenzuola e tre marmitte per cucinare). Le autorità decisero dunque di attrezzare un campo che potesse ospitare al massimo un centinaio di persone, compresi gli agenti di guardia, a fronte di una popolazione ebraica ben più numerosa censita negli anni precedenti: in un elenco della Questura aggiornato a inizio novembre risultavano circa 400 ebrei nella provincia, una parte dei quali provenienti dai Balcani e internati in zona dal 1942.
Nel corso di dicembre cominciarono ad affluire nel campo gli ebrei arrestati da agenti di polizia e carabinieri italiani: Vo’ Vecchio rimase in funzione fino al luglio del 1944 e vi finirono in tutto circa 70 persone, molte donne, bambini e anziani che non diedero mai problemi di ordine pubblico. In applicazione delle direttive ministeriali di Salò, alcuni furono fatti uscire perché malati, troppo anziani oppure perché considerati misti [18].
Leggendo le testimonianze degli internati sopravvissuti alla Shoah e di chi abitava nei dintorni del campo, si apprende che le condizioni di vita all’interno di questa struttura erano sostanzialmente buone: esistevano delle regole rigide da rispettare e c’erano delle guardie di sorveglianza, ma gli ebrei potevano ottenere dei permessi per recarsi in paese, ricevevano regolarmente i pasti, comunicavano con l’esterno e non subivano soprattutto violenze fisiche [Selmin 2011].
Per ricostruire in che maniera fosse portato avanti il funzionamento ordinario e quotidiano del campo abbiamo a disposizione documenti molto significativi conservati presso l’Archivio di Stato di Padova nei fondi della Prefettura e della Questura: si tratta delle relazioni, dei telegrammi e degli ordini che si scambiarono all’epoca gli uffici e gli uomini dell’amministrazione provinciale [19]. Leggendo le comunicazioni interne a questi organi, si nota come chi scriveva non si trattenne dal denunciare le difficoltà né dal polemizzare riguardo atteggiamenti poco collaborativi da parte di uffici o colleghi. Al contrario, gli scambi tra gli uffici amministrativi locali e quelli centrali del Ministero erano influenzati da considerazioni politico-strategiche: molte volte venivano omessi i dettagli più sconvenienti o gli aspetti che potevano lasciar trapelare problemi nella gestione del territorio.
Alla guida della provincia di Padova in quei mesi vi fu Primo Fumei, nato a Udine nel 1903, ragioniere, laureatosi nel novembre 1943 in Economia e commercio. Personalità di rilievo del fascismo friulano fin dal 1922, negli anni Trenta divenne prima presidente del comitato provinciale dell’Opera nazionale dopolavoro di Udine e poi segretario della Federazione provinciale del Pnf, per poi passare a ricoprire lo stesso ruolo a Trento tra il 1936 e il 1943. Nel frattempo si era fatto un nome anche al di fuori della sua regione, diventando consigliere nazionale e componente del Direttorio nazionale del Partito. Fu nominato prefetto nel giugno 1943, per meriti politici e non di carriera, e posto a disposizione con l’incarico di vice commissario civile a Palermo presso l’Alto commissariato civile della Sicilia. Messo a riposo a inizio settembre da Badoglio, fu nuovamente chiamato da Mussolini come capo provincia di Padova dall’ottobre ’43 al luglio 1944, mese in cui fu posto a capo della Direzione generale degli Affari Generali del Ministero degli Esteri di Salò e promosso, nel settembre, Ministro plenipotenziario di 1° categoria [20] [Cifelli 1999, 126-127].
Questore era invece Baldassare Augugliaro, trapanese, classe 1881, a Padova dal settembre del ’42 e con alle spalle un’ordinaria carriera al Ministero dell’Interno nella Pubblica sicurezza: vi era entrato per concorso come alunno semplice a 23 anni e poi, col tempo, aveva raggiunto il ruolo di commissario capo di PS e poi di vice questore con funzioni ispettive, destinato a svolgere il suo lavoro soprattutto in alcune province del nord Italia. A metà degli anni Trenta fu promosso questore e venne assegnato a Verona, dove per la sua proficua collaborazione con le autorità di polizia tedesche in occasione della visita di Hitler ricevette dal governo del Reich, nel 1939, la Croce al merito dell’Aquila tedesca: in particolare era stata apprezzata la sua opera di repressione di un gruppo di antifascisti sovversivi, portati alla sbarra davanti al Tribunale speciale. Nel corso della sua carriera ricevette benemerenze per aver servito con dedizione lo Stato fascista (si iscrisse al Partito nel 1932) e per aver smascherato reti clandestine di comunisti e antifascisti nelle città in cui prestò servizio; ma allo stesso tempo fu oggetto di critiche da parte di suoi colleghi, che denunciarono in molti casi la scarsa capacità nello svolgere le funzioni ispettive e la poca stima che aveva presso la popolazione civile ovunque fosse andato. A Padova concluse la sua carriera nel febbraio ’44, quando fu messo a riposo per anzianità di servizio [21].
A sostituirlo fu Rino Gaetano Palmeri, un questore “fascista” voluto dal capo provincia Fumei, proveniente dai comandi della Gnr e con alle spalle una carriera militare oltre che prefettizia. In realtà, nel corso del 1944 e fino alla Liberazione, alla guida della questura di Padova si alternarono numerosi funzionari: Palmeri terminò il suo incarico già ad aprile e nei mesi successivi al suo posto salirono figure provvisorie, continuamente sostituite.
Scendendo nella scala gerarchica dei responsabili della vicenda, passiamo ai direttori del campo: il primo fu il commissario di Pubblica sicurezza Nicola De Mita, nato a Napoli nel 1890 ed entrato nell’amministrazione del Ministero dell’Interno tramite concorso, poco più che ventenne. Promosso commissario capo di PS nel 1929, prese servizio a Vicenza: nonostante gli fossero stati affidati compiti superiori rispetto al suo grado, non ricevette mai la nomina a vice questore, motivo di evidente frustrazione. De Mita arrivò a Padova nel novembre del 1943 da Vicenza, provincia dalla quale fu allontanato su richiesta del capo provincia locale a causa di «contingenze locali», ovvero problemi. Leggendo il suo fascicolo personale, De Mita risulta per alcuni superiori e colleghi di carattere fermo e volitivo, ma per altri è una personalità irruenta e irascibile, spesso dipinto come totalmente inadatto a qualsiasi ruolo direttivo, disinteressato del suo mestiere, in alcuni casi perfino «elemento deleterio per la PS» e «privo di intuito e prontezza di decisione». Iscritto dal 1933 al Pnf, dopo l’8 settembre giurò fedeltà alla Repubblica sociale senza però mai prendere la tessera del Pfr. La sua attività di commissario di PS proseguì anche nel dopoguerra, nonostante l’Alto commissariato per l’epurazione si fosse occupato di accertare le sue responsabilità di collaboratore dei tedeschi e di Salò, nonché di direttore di un campo di concentramento per ebrei deportati poi ad Auschwitz. Fu prosciolto dalle accuse in quanto al momento della deportazione non era più direttore, ma era stato trasferito all’Ufficio profughi della Prefettura di Padova. Nel 1955 ricevette l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, che confermò lo stesso titolo onorifico riconosciuto dalla Corona durante il regime fascista [22].
A sostituirlo come direttore, nel gennaio del 1944, fu il vice commissario Salvatore Lepore, nato nel 1913, più giovane di De Mita, entrato come volontario nella Pubblica sicurezza nel 1938. Arrivò a Padova dopo aver prestato servizio a Spalato, e vi restò fino ad agosto, quando fu trasferito a Como. Nel dopoguerra proseguì la carriera e diventò commissario capo [23].
La sostituzione al comando del campo fu accolta positivamente dagli internati e dagli abitanti del luogo, che descrissero nelle loro memorie il nuovo direttore come una brava persona, al contrario del suo predecessore. Questa sostituzione comportò, a livello pratico, un passaggio di consegna dei materiali presenti all’interno del campo, elencati su una lista: tra questi figuravano le coperte, i letti, i documenti, le stoviglie, nonché, al punto 30, si leggeva anche «n. 34 concentrati», ovvero le persone rinchiuse in quel momento nella villa [24]. Era avvenuto in maniera evidente ciò che Zygmunt Bauman ha definito come «il processo di disumanizzazione degli oggetti dell’attività burocratica», ovvero «la possibilità di esprimere tali oggetti in termini puramente tecnici ed eticamente neutri» [Bauman 1992, 147-148].
In un’afosa giornata di metà luglio del ’44, un gruppo di SS tedesche irruppe improvvisamente e prelevò i 43 ebrei lì internati (14 uomini, 22 donne e 7 bambini), senza che le poche guardie italiane di sorveglianza si opponessero. Fino a quel momento, la questione ebraica e il funzionamento del campo provinciale non avevano interessato, se non sporadicamente, i rapporti tra le autorità locali italiane e quelle tedesche dislocate in zona. Condotti prima nel carcere di Padova, gli ebrei furono trasferiti alla Risiera di San Sabba e poi deportati ad Auschwitz. Solo in tre fecero ritorno in Italia, il resto trovò la morte nel campo di sterminio polacco [Selmin 2011; Picciotto 2011].
Esito ancora diverso ebbe la vicenda di Perugia. Gli ebrei rinchiusi nel campo provinciale in funzione in quella zona riuscirono a restarvi fino all’arrivo delle truppe anglo-americane e a mettersi in salvo. Ciò fu possibile anche per l’atteggiamento tenuto dalle autorità di Salò, in particolare dal locale capo provincia in carica tra l’ottobre ‘43 e il giugno 1944: Armando Rocchi. Romano, nato nel 1898, laureato in zoologia e veterinario di professione, era partito volontario nel primo conflitto mondiale. Iscritto al Pnf dal 1921, entrò nella Milizia dove diventò Seniore e comandante di legione: ufficiale nella guerra di Spagna, tra il 1941 e il 1943 combatté sui fronti albanese, jugoslavo e montenegrino. Nel giugno del ‘44, giunti gli Alleati in Umbria, decise di trasferirsi a nord, dove fu incaricato di provvedere al funzionamento e al coordinamento dei servizi per il quartier generale del Ministero dell’Interno e, da agosto, prese servizio come Commissario straordinario per l’Emilia Romagna [25]. Questi brevi accenni biografici ci restituiscono insomma una persona di indubbia fede fascista, che preferì proseguire la sua attività nella Rsi piuttosto che arrendersi agli anglo-americani.
Con una comunicazione del 20 gennaio 1944 il questore di Perugia inviò al Ministero e al comando tedesco un elenco di ebrei fermati in provincia che sarebbero stati trasferiti a Fossoli [Boscherini 2005; Picciotto 2011]. Gli ebrei che finirono concentrati nel campo provinciale, invece, non furono fatti partire. Il 13 aprile del 1944 Rocchi comunicò al capo della polizia che, in «conformità disposizioni verbali ricevute da Ministro Interno», stava procedendo all’istituzione di un campo di concentramento in località Isola Maggiore del Trasimeno, dove avrebbe spostato i circa 40 ebrei già internati alle Scuole Magistrali di Perugia, arrestati dopo il 30 novembre [Boscherini 2005, 186-187] [26]. In un telegramma diretto al capo della polizia e che porta la data del 24 aprile ‘44, relativa all’invio al campo modenese di 20 ebrei già fermati in provincia, sempre Rocchi sembrò mettere in dubbio, considerata la gestione tedesca e in vista di ulteriori trasferimenti, che Fossoli fosse il campo speciale previsto dalle misure italiane (vi si legge infatti la frase «qualora trattisi campo concentramento nazionale») [27].
Il 12 giugno, con l’arrivo degli Alleati sulle sponde del lago Trasimeno, grazie anche alla presenza tra le guardie del campo di alcuni informatori vicini ai gruppi della Resistenza locale, i partigiani vennero a sapere che la polizia germanica avrebbe prelevato e deportato gli internati nel campo. Nella memorialistica e nei testi di storia locale figurano diverse versioni riguardo gli avvenimenti che accaddero nelle ore successive: alcuni riconducono i meriti dell’azione di salvataggio degli ebrei ai sorveglianti fascisti, altri ai partigiani, altri ancora ai pescatori della zona. In ogni modo gli ebrei che si trovavano nel campo furono prima fatti uscire e ospitati nelle case dei dintorni; alcuni di loro raggiunsero in barca la sponda del lago già liberata dagli Alleati [Dethick 2004, pp. 70-79; Boscherini 2005].
Questi tre casi studio riportati in maniera sintetica rappresentano esempi diversi di come la persecuzione degli ebrei si sviluppò a livello locale: al momento di applicare la normativa decisa ai vertici governativi, ambigua e suscettibile di discrezionali interpretazioni, le autorità provinciali dovettero tenere conto della situazione politica, militare e sociale dell’area da loro amministrata, caratterizzata dalla presenza ingombrante dell’alleato tedesco, dall’evolversi della guerra e dall’intensità del movimento partigiano. Ciò diede vita a molteplici atteggiamenti, influenzati da personali convinzioni politiche, da prassi amministrative e governative in atto già da anni, dalla contingenza di eventi bellici in continua e rapida evoluzione. Da tutto questo dipese la sorte di migliaia di perseguitati, che finirono deportati nei lager di sterminio o al contrario riuscirono a salvarsi. Quelli di Grosseto, Padova e Perugia furono insomma tre esempi di vie che la Shoah prese in Italia grazie anche all’opera, volontaria o inconsapevole, non tanto di spietati e violenti carnefici, ma di amministratori e «funzionari comuni» [Browning 1995], fedeli servitori dello Stato fascista.
Bibliografia
- Acciai E. 2016
Una città in fuga. I livornesi tra sfollamento, deportazione razziale e guerra civile (1943-1944), Pisa: Edizioni ETS. - Bauman Z. 1992
Modernità e Olocausto, Bologna: il Mulino (ed. or. 1989) - Berger S. (ed.) 2016
I signori del terrore. Polizia nazista e persecuzione antiebraica in Italia (1943-1945), Verona: Cierre edizioni - Borghi M. 2001
Tra fascio littorio e senso dello stato. Funzionari, apparati, ministeri della RSI (1943-45), Padova: Cleup - Boscherini L. 2005
La persecuzione degli ebrei a Perugia. Ottobre 1943-luglio 1944, Montepulciano: Le Balze - Browning C.R. 1995
Uomini comuni: polizia tedesca e soluzione finale in Polonia, Torino: Einaudi (ed. or. 1992) - Capogreco C.S. 2004
I campi del duce. L’internamento civile nell’Italia fascista (1940-1943), Torino: Einaudi - Cassese S. 2010
Lo Stato fascista, Bologna: il Mulino - Cifelli A. 1999
I prefetti del regno nel Ventennio fascista, Roma: SSAI - Collotti E. 2007a (ed.)
Ebrei in Toscana tra occupazione tedesca e RSI: persecuzione, depredazione, deportazione (1943-1945), I, Roma: Carocci - Collotti E. 2007b (ed.)
Ebrei in Toscana tra occupazione tedesca e RSI: persecuzione, depredazione, deportazione (1943-1945), II, Roma: Carocci - D’Amico G. 2015
Sulla strada per il Reich. Fossoli marzo-luglio 1944, Milano: Mursia - D’Angeli R. 2016
Storia del Partito fascista repubblicano, Roma: Castelvecchi - Dethick J. K., 2004
La battaglia dimenticata. Alleati, tedeschi e popolazione civile sulla linea del Trasimeno. Giungo-luglio 1944, Perugia, Uguccione Ranieri di Sorbello Foundation. - Klinkhammer L. 2007
L’occupazione tedesca in Italia, 1943-1945, Torino: Bollati Borignhieri (ed. or. 1993) - Melis G. 2018
La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista, Bologna: il Mulino - Ministero dell’Interno 1938-1974, Ruoli di anzianità del personale delle amministrazioni dipendenti, Roma: Istituto poligrafico dello Stato
- Picciotto L. 2010
L’alba ci colse come un tradimento. Gli ebrei nel campo di Fossoli. 1943-1944, Milano: Mondadori - Picciotto L. 2011
Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia (1943-1945), Milano: Mursia - Rocchi L. 2007
Ebrei nella Toscana meridionale, in Collotti 2007a - Sarfatti M. 1997
Gli ebrei negli anni del fascismo: vicende, identità, persecuzione, in Storia d’Italia, Annali, 11 Gli ebrei in Italia, II, Torino: Einaudi - Sarfatti M. 2018
Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Torino: Einaudi - Selmin F. 2011
Nessun “giusto” per Eva. La Shoah a Padova e nel Padovano, Verona: Cierre edizioni - Stefanori M. 2017, Ordinaria amministrazione. Gli ebrei e la Repubblica sociale italiana, Roma-Bari: Laterza
Note
1. Archivio Centrale dello Stato (d’ora in poi ACS), Segreteria Particolare del Duce (d’ora in poi SPD), Carteggio Riservato (d’ora in poi CR), RSI, b. 61, f. 630.
2. ACS, Ministero dell’Interno (d’ora in poi MI), Direzione Generale di Pubblica Sicurezza (d’ora in poi DGPS), A5G II guerra mondiale, b. 151, f. 230.
3. ACS, MI, DGPS, Massime R9 Razzismo, b. 183, f. 19.
4. Si veda ad esempio: L’arresto degli ebrei, in “Corriere della Sera”, 1 dicembre 1943, 1; Tutti gli ebrei inviati ai campi di concentramento, in “La Stampa”, 1 dicembre 1943, 1; Fino in fondo. Gli ebrei residenti n Italia avviati in campi di concentramento. Confisca di tutti i beni mobili e immobili – Vigilanza di polizia per gli arianizzati, in “Il Resto del Carlino”, 2 dicembre 1943, 1.
5. È possibile consultare on-line alcune mappe che riproducono questo fitto sistema di campi: http://campifascisti.it/; http://www.cdec.it/public/campi-conc.pdf.
6. Archivio storico del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (d’ora in poi ACDEC), Archivio generale (AG)-5F, Campi di concentramento e carceri in Italia, f. Persecuzione e sterminio Italia, Campi di concentramento, Aosta.
7. ACS, MI, DGPS, Massime M4, b. 142, f. 18.
8. ACS, MI, DGPS, A5G II Guerra Mondiale, b. 151, fasc. 230; ACS, MI, DGPS, Massime R9 Razzismo, b. 183, f. 19.
9. Ivi.
10. ACS, MI, DGPS, Massime M4, b. 142, f. 18.
11. ACS, MI, Direzione generale affari generali e del personale (d’ora in poi DGAGP), Divisione del personale 1861-1952, Versamento 1952, fascicoli riservati, b. 50 (bis), f. Cosmin Piero.
12. A. Pajno, 1938, la “vera” legalità, relazione letta durante il 900fest - Festival di Storia del Novecento, V edizione (Forlì, 24-27 ottobre 2018)
13. ACS, MI, DGAGP, Divisione del personale 1861-1952, Versamento 1952, Fascicoli riservati, b. 50 (bis), f. Ercolani Alceo.
14. ACS, MI, DGPS, Massime M4, b. 142, f. 18.
15. Ivi.
16. Ivi
17. ACS, MI, DGPS, A5G II Guerra mondiale, b. 151, f. 230.
18. Archivio di Stato (d’ora in poi AS) di Padova, Questura, b. 41, 42, f. C. C. Vo (Campo di concentramento di Vo Vecchio).
19. Si tratta dei seguenti fondi: AS Padova, Questura, b. 41,42, fasc. C. C. Vo (Campo di concentramento di Vo Vecchio), “Ebrei. Campi di concentramento A4b, 3 dicembre 1943/9 luglio 1947”; Prefettura (Gabinetto), b. 548, cat. XV/23, 1943-1945, Provvedimenti razziali, corrispondenza varia, fasc. “Beni ebraici confiscati ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 4 gennaio 1944 XXII”.
20. ACS, MI, DGAGP, Divisione personale, Fascicoli del personale del Ministero, fascicoli riservati, versamento 1952, b. 50 (bis), f. Fumei dr. Primo.
21. ACS, MI, DGPS, Divisione personale PS (1890-1966), versamento 1957, b. 225, f. Augugliaro Baldassarre.
22. Ivi, versamento 1959, b. 192 bis, f. De Mita Nicola.
23. Ministero dell’Interno 1938-1974.
24. AS Padova, Questura, b. 41, 42, f. C. C. Vo (Campo di concentramento di Vo Vecchio)
25. ACS, MI, DGAGP, Divisione del personale 1861-1952, Versamento 1952, fascicoli riservati, b. 50 (bis), f. Rocchi Armando; utili notizie anche in http://www.armandorocchi.it/
26. ACS, MI, DGPS, Massime M$, b. 144, f. 18.
27. ACS, MI, DGPS, Massime R9, b. 183, f. 19.