1. Introduzione
Lo spazio pubblico del nostro paese vede molto ridotta la presenza femminile nei monumenti e nella toponomastica. Nell’arte istituzionale che popola le nostre vie e piazze le donne realmente esistite sono rare, a favore di rappresentazioni femminili simboliche e generalizzanti. I monumenti, che siano dedicati alla patria, a Giuseppe Mazzini o al milite ignoto, non hanno avuto (e hanno) solo il compito di ricordare, ma soprattutto di costruire la memoria, rappresentare il passato e affermare modelli culturali, tra cui quelli di genere come vedremo in questo articolo. In tal modo, nelle piazze si manifesta la voce narrante del potere e si definisce ciò che è degno di essere rappresentato e ciò che è socialmente accettabile.
In questi ultimi anni, è stata posta attenzione alla problematica della rappresentazione femminile nello spazio pubblico e diversi sono stati gli studi e le azioni intraprese per contrastarla. Il nostro contributo analizza la rappresentazione femminile nelle strade di Bologna e alcune azioni di riappropriazione dello spazio pubblico messe in campo negli ultimi anni, in particolare le esperienze artistiche di Cheap a Bologna e Monumentale dimenticanza a Torino.
Prima di addentrarci nell’argomento, occorre sottolineare un aspetto: di recente si è parlato spesso delle problematiche legate alla statuaria negli spazi pubblici, in alcuni casi senza distinzione tra i soggetti rappresentati. Bisogna, però, evidenziare le differenze tra il cosiddetto patrimonio difficile – fascista, coloniale – con il quale si deve fare i conti in termini di presenza, e l’assenza di un patrimonio che mostri il femminile, e anche il queer, il trans [1].
Statuaria e odonomastica sono in genere coerenti tra loro, specchio dell’orientamento culturale delle amministrazioni comunali e dei comitati cittadini. Per questa ragione i dati raccolti dall’associazione Toponomastica femminile sono di estrema importanza ai fini del nostro discorso. Secondo le loro stime le intitolazioni femminili delle strade del nostro paese oscillano tra il 3 e il 5%, quelle maschili superano il 40%, mentre l’indice nazionale di nuove intitolazioni a figure femminili è dell’8% [Capaso 2019, 8]. Non sorprende che la dedicataria più ricorrente sia la Madonna, seguita, secondo i dati raccolti dall’associazione, da Maria Montessori, Madre Teresa di Calcutta, Matilde Serao, Grazia Deledda, Nilde Iotti, Ilaria Alpi, Maria Grazia Cutuli, Anna Magnani e Artemisia Gentileschi [Capaso 2019, 8]. È semplicistico ritenere che le ragioni di questa disparità siano le minori opportunità di distinguersi che hanno avuto le donne del passato rispetto agli uomini. Il problema è certamente più complesso e riguarda la cultura conservatrice, maschilista e androcentrica del nostro paese, cultura che determina i monumenti e i nomi delle strade. Lo spazio della città è ancora «in prevalenza campo d’azione degli uomini che hanno il potere, politico come pure professionale, essendo molto bassa la presenza femminile in entrambi gli ambiti» [Pirajno 2015, 217].
La presenza femminile nei monumenti non è mai stata oggetto di un analogo censimento su scala nazionale, ma è senza dubbio ancora più ridotta: pochissime sono le donne reali effigiate nelle piazze italiane [Mi Riconosci 2020; Forcella, Lisotti e Lunardon 2020]. A questo proposito è emblematico che nella città di Roma una sola donna sia dedicataria di un monumento: Anita Garibaldi, rigorosamente col cognome del marito. È raffigurata in una statua di epoca fascista che la vede a cavallo mentre brandisce una pistola con la mano destra e regge un figlio neonato con il braccio sinistro. Il ruolo di combattente da solo non è sembrato dunque sufficiente per celebrarla e gli è stato associato quello di madre, in una rappresentazione equestre che di certo non trova confronti stringenti con quelle maschili.
A luglio 2021, è stato reso noto il progetto portato avanti dalla consigliera comunale di Milano Angelica Vasile di dedicare a Margherita Hack una statua. I giornali hanno riportato che sarebbe stata la prima statua dedicata a una donna a Milano, contro 121 dedicate a uomini. In città come Torino, Napoli o Bologna non risultano statue nello spazio pubblico che celebrino specifiche donne del passato. Nell’articolo di Mi Riconosci del 2020 si sottolinea:
È impossibile e superfluo, quindi, fare un elenco di chi manca nei nostri spazi pubblici commemorativi. Ma è evidente che nella selezione delle personalità da omaggiare pubblicamente è intervenuto anche un criterio androcentrico, che ha portato al silenziamento di donne che avrebbero meritato un riconoscimento almeno pari a quello dato a molti uomini di cui conosciamo a memoria i volti. Manca praticamente tutta una metà di umanità e di storia [Mi Riconosci 2020].
2. La statuaria istituzionale pubblica di Bologna e la Lavandaia di via della Grada
La fama di Bologna quale città con una particolare attenzione alle tematiche di genere non trova conferma nella presenza femminile nello spazio pubblico: né nei monumenti, né nella segnaletica stradale.
Statue sul suolo pubblico che celebrino le grandi donne del passato sono del tutto assenti; 1.191 sono le vie dedicate a uomini contro le 104 a donne. Di queste 104 ben 5 sono riferite a Madonne e 15 a sante e beate [2]. Compensa in parte l’intitolazione di 31 aree verdi a figure femminili e la specifica attenzione al problema dimostrata da una pagina web del Comune che approfondisce le biografie delle donne dedicatarie [3].
Camminando per le strade del centro di Bologna si possono incontrare poche statue dalle fattezze femminili: qualche santa nella facciata delle chiese e due colonne con statue mariane (Colonna dell’Immacolata e Colonna della Beata Vergine del Carmine). Tra quelle profane, vicino alla stazione ci si imbatte nella fontana ottocentesca della scalinata del Pincio, opera di Diego Sarti che vede protagonista una ninfa nuda e sensuale. A pochi passi nel parco della Montagnola è collocata un’altra fontana, opera dello stesso Sarti, che comprende tartarughe, leoni e due sirene dalla sensualità marcata. Sirene decisamente avvenenti sono rappresentate anche nel monumento più celebre della città, la fontana del Nettuno di Giambologna in piazza Maggiore (sebbene in questo caso facciano da contraltare a un uomo a sua volta nudo e avvenente). Queste sirene sono addossate agli spigoli del basamento, mentre si sorreggono i grossi seni da cui sgorga l’acqua. Allontanandosi fino a piazza Carducci si vede il monumento di Leonardo Bistolfi dedicato al poeta e inaugurato nel 1928, in cui i corpi femminili nudi abbondano. Quattro figure femminili in cemento si scorgono poi sulla sommità dell’Arena del sole, in via Indipendenza. Realizzate nel 1888 da Alfredo Neri, sono allegoriche e accompagnano Apollo, la metà di loro ha il seno scoperto. Una delle poche figure femminili vestite che si incontrano in questa passeggiata inevitabilmente parziale è la partigiana del Monumento al partigiano e alla partigiana, realizzato da Luciano Minguzzi nel 1947 e collocato nella piazza di Porta Lame. Una menzione merita poi la fontana dei giardini della Lunetta Gamberini, un po’ fuori dal centro. Realizzata nel 1987 da Nicola Zamboni, vede una figura femminile con il seno scoperto e la testa reclinata in avanti, che appare esanime.
La sensualità delle statue pubbliche è stata senza dubbio percepita da chi ha vissuto quegli spazi. Lo mostra bene una scena di Amarcord di Federico Fellini in cui la voce fuori campo di Titta racconta «Questo è il monumento della Vittoria, andavamo a vederlo tutti i giorni... e io me lo sognavo anche la notte», nel frattempo viene mostrato il sedere di una statua sotto la pioggia e un gruppo di cinque uomini e ragazzi che lo osserva, uno dei quali fa gesti espliciti. L’opera in questione è monumento ai caduti della Prima guerra mondiale in piazza Ferrari a Rimini, inaugurato nel 1926 e realizzato dallo scultore Bernardino Boifava. Fellini in seguito ne ebbe a scrivere:
il monumento ai caduti che era vicino al ginnasio. Una potente muscolosa figura virile di bronzo teneva alto verso il cielo un pugnale, su una sua spalla giaceva un po’ scomoda una donna nuda: la gloria. Quando pioveva stavamo sotto gli ombrelli a guardare il bel sederone che l’acqua rendeva lucido, palpitante, sembrava vivo.
Sensuali, allegoriche e ancillari, materne o martiri, e – ad eccezione di quelle religiose – tutte senza nome.
In perfetta continuità con la maggioranza delle statue femminili profane bolognesi si inserisce la più recente Lavandaia, scultura in bronzo realizzata dall’architetta Saura Sermenghi nell’ambito di Bologna città europea della cultura dell’anno 2000, progetto presentato dall’Associazione donne d’arte (Adda).
La statua, che ha per soggetto una donna nuda inginocchiata dentro una bacinella, nasce con l’intento di celebrare le lavandaie in prossimità del lavatoio pubblico che era collocato lungo il canale Reno, oggi coperto. Nelle intenzioni dell’autrice la statua
nasce da un sogno metafisico atto a trasformare l’atto del lavare i panni in un tema simbolico di purificazione. [...] In questo specifico caso, ciò avvenne attraverso l’immagine materiale di una lavandaia che, nella sua nudità, lava e si lava [Sermenghi 2017].
Accanto a questo significato legato alla purificazione Sermenghi ne individua uno storico citando varie testimonianze a proposito dell’oggettificazione sessuale a cui venivano sottoposte le lavandaie da parte degli uomini che si fermavano a guardarle faticare. Spiega dunque:
La situazione della lavandaia che lava alla fonte pubblica implicava un gioco di ruoli fra chi guarda e chi è guardato senza possibilità di scambio fra la condizione attiva e quella passiva … a meno che … altri sguardi osservino. […] Nel contesto specifico della scultura posizionata in Via della Grada se una terza persona esamina colui che guarda la scultura, l’attenzione si sposta sullo sguardo di chi osserva la scultura e non più sulla scultura. Così, nel qui ed ora viene palesato lo sguardo di chi osserva e, in una trasposizione metafisica temporale, viene smascherato, mostrato e riproposto lo sguardo ossessivo di chi stava lì ad osservare il corpo delle lavandaie facendo finta di niente. La vera provocazione attuale non è la scultura in sé ma lo svelamento di tali ruoli e la rappresentazione dello sguardo morboso sulla lavandaia [Sermenghi 2017].
Nelle intenzioni dell’architetta compito della scultura è dunque puntare l’attenzione sullo sguardo di chi la osserva, smascherandone l’aspetto morboso. Seguendo il filo delle sue stesse considerazioni l’operazione non può però avere successo: è assente l’altro elemento dialettico, l’uomo morboso, che non viene sostituito dall’osservatore di oggi che dovrebbe essere osservato a sua volta da una non meglio precisata «terza persona». L’attenzione rimane dunque sulla scultura e non «su colui che guarda la scultura». Quello che si palesa agli occhi è una donna nuda e prona, oggetto passivo dell’attenzione del passante che non ha gli elementi per contestualizzarla.
La denuncia degli sguardi maschili rimane nelle parole e il meccanismo che oggettificava le lavandaie al lavoro non solo non viene scardinato, ma di fatto viene riproposto. Non risulta difficile immaginare i personaggi di Amarcord riunirsi a guardarla, anche senza pioggia.
autrici].
L’esplicita sessualizzazione della lavandaia è stata notata daə bolognesi e ha portato a una raccolta firme per la sua rimozione, rimasta inascoltata.
Sculture che omaggiano le lavandaie sono discretamente diffuse: si tratta senza dubbio della professione storicamente femminile più rappresentata nella statuaria pubblica italiana. Due lavandaie di bronzo si trovano a Sant’Agata Bolognese, a pochi chilometri dalla precedente, appoggiate all’antico lavatoio.
Sono in piedi nell’atto di lavare, seguendo l’iconografia più semplice e tradizionale, a cui corrisponde anche la Lavandaia di Pavia, esempio più celebre in Italia.
Inginocchiate sono invece quella di Bagno a Ripoli e quella di Villasanta. Entrambe meritano alcune delle critiche a quella bolognese, in particolare la seconda che indossa un’improbabile veste corta senza spalline. Anche quando si intende celebrare una professione, particolarmente faticosa peraltro, non è scontato per scultori e amministratori evitare di sessualizzare la figura femminile che la sta praticando.
La statuaria istituzionale pubblica della città di Bologna rispetto al femminile di fatto è continuata nel solco della tradizione otto e novecentesca che si è riassunta. Dopo la lavandaia nuove statue hanno popolato diversi spazi pubblici della città: nel 2003 un Padre Pio di bronzo è stato collocato nel giardino di Porta Saragozza; nel 2016 una statua di Lucio Dalla, studiata per i selfie, è stata collocata in piazza dei Celestini; dal 2018 un volutamente bizzarro Freak Antoni che emerge da un wc è nel parco del Cavaticcio. Le ultime due più che celebrare i cantanti bolognesi sembrano concepite con intento ludico e ammiccano molto chiaramente ai social in una città sempre più turistica. Qualche anno fa si è installata una statua nei giardini Margherita che non è riferita a una donna in particolare, ma al ruolo femminile per eccellenza, si intitola infatti Madre e nelle intenzioni dell’autore Guy Lydster rappresenta «una sorte di fonte di vita naturale» [4]. La forma evoca il manto che accoglie i fedeli della Madonna della misericordia, ma anche una vulva, facendo apparire la scultura come una svilente metonimia della donna [5].
3. Il Monumento al tortellino di Castelfranco Emilia: l’occhio che divora
Spostandoci di qualche chilometro la situazione non cambia, infatti la provincia non fa eccezione e presenta casi altrettanto interessanti per il nostro discorso. Passeggiando tra le vie di Castelfranco Emilia, tra Bologna e Modena, le statue pubbliche che si incontrano sono un po’ le solite di molti Comuni italiani: una Madonna, quella del voto (del 1631) eretta dopo la peste come ex-voto dai castelfranchesi; un monumento ai caduti della Prima e Seconda guerra mondiale (del 1924), raffigurante un soldato con la mantella svolazzante e le mani poggiate sull’elsa di una spada, iconicamente decorata di foglie di quercia; e infine, fuori linea, il Monumento al tortellino (inaugurato nel 2006 in piazza Aldo Moro).
Quest’ultimo, realizzato da Giovanni Ferrari e finanziato dall’associazione La San Nicola e dalla Dotta confraternita del tortellino di Bologna, è decisamente meritevole della nostra attenzione.
Sull’origine del piatto esistono varie leggende e tutte sono originarie di Castelfranco Emilia. L’immaginario di base, in ogni versione, è il disvelamento del corpo femminile attraverso un atto di violenza: la versione dell’ombelico di Venere raccontata da Giuseppe Ceri nel 1908, che riprende arricchendolo il secondo canto de La secchia rapita di Alessandro Tassoni, ha protagonista un oste che ha come ospiti della locanda Marte, Bacco e Venere. In questa versione Venere, una volta da sola, viene osservata dall’oste.
Dopo l’irruzione in camera, l’uomo non può che “sfogare” sulla pasta il turbamento provato alla vista della bellezza divina. In un’altra versione il proprietario della locanda Corona dopo aver sbirciato dalla serratura della stanza di una nobildonna sua ospite rimane così turbato dalla vista del corpo di lei, che “deve” riproporre le fattezze del suo ombelico in un piatto [6].
A ben vedere, la Venere di Ceri – il tortellino da divorare – è una divinità non più sua, abbandonata dalla mistificazione olimpica che impedisce all’uomo lo sguardo e che, anzi, lo dovrebbe accecare quando si spinge al di là. È una donna tradita nella sua privacy, è un corpo femminile soggetto all’occhio dell’uomo: un occhio divorante, che prende l’oggetto guardato, lo incorpora, lo distrugge e lo costringe a subire il proprio volere – il tortellino da divorare.
Il topos della donna spiata mentre “si scioglie i veli” per lavarsi è ancora diffusissimo in epoca moderna. Senza dilungarci nella prossemica della gestualità tipica del velare o disvelare un corpo, in ambito letterario e artistico un corpo femminile velato è un corpo protetto. Come nota Giuseppina Paola Viscardi
letto nell’ottica dello scioglimento dei veli, lo «svelamento» della donna è, dunque, metaforicamente accostabile alla breccia aperta nella difesa della città una volta che se ne è conquistata la fortezza e della violazione della città stessa che inevitabilmente ne consegue [Viscardi 2013, 86].
Si tratta di un topos ben radicato nella nostra cultura, che troviamo ripetutamente in vicende bibliche e mitologiche: da Susanna molestata dai vecchi mentre si lava, a Bethsabea osservata da re David mentre compie la stessa operazione, o ancora Diana e le ninfe sorprese da Atteone mentre fanno il bagno. Riferimento più vicino sono poi le tante pellicole della commedia erotica italiana degli anni Settanta e Ottanta, in cui ricorre frequentemente l’immagine della donna spiata dalla serratura mentre si cambia o lava, lo dimostrano per esempio le locandine dei film Quel gran pezzo dell’Ubalda (1972), Una bella governante di colore (1976) e Viva la Foca (1982).
Non mancano neppure espliciti richiami nella letteratura di quegli anni, basti pensare al romanzo del 1985 di Alberto Moravia, L’uomo che guarda, che già dal titolo allude
al dominante motivo voyeuristico, non solo rappresentato in varie scene ed episodi ma sviluppato anche saggisticamente con riferimenti letterari che spaziano da Erodoto a Mallarmé e a Proust [Cavallini 2019, 7].
Lo scrittore, nel romanzo, giustifica il ricorso al tema dello sguardo, del voyeurismo, con un riferimento che richiama, anche, la cinematografia: «quando il romanziere ci descrive due personaggi in atto di accoppiarsi in realtà guarda e ci fa guardare per un immaginario buco della serratura» [Moravia 2019, 66].
Un dettaglio, però, del monumento del 2006 tradisce una distorsione ben precisa delle dinamiche mitiche tra i due personaggi coinvolti nell’immagine: un gatto comodamente accoccolato sul petto della donna nuda.
La presenza del gatto in braccio alla donna potrebbe avere un significato diffuso in epoca moderna, alludere cioè all’adescamento, all’“azione femminile” di catturare la preda, spesso in arte simboleggiata da un topo o un uccello. Il simbolo del gatto come seduzione femminile si trova già in Adamo ed Eva di Albrecht Dürer del 1504 ed è diffuso anche in Italia in pittura, ma anche nella letteratura erotica, si trova infatti in Aretino e Giorgio Baffo [Porzio 2008, 124-125].
Ed eccoci dove i confini dell’umano e del normato non sono veramente labili: la donna del Monumento al tortellino non è una divinità eterea olimpica, né una misericordiosa e scontornata Madonna, ma un corpo di bronzo chino, nudo, ignaro (nel racconto, compiaciuto quasi nella rappresentazione) di essere divorato dall’infinitesimo squarcio di una serratura; mentre dall’altro lato l’oste (chino anche lui nella sua molestia) fa da estremo opposto per l’elemento centrale, il prodotto pronto ad essere servito nei nostri piatti – il tortellino da divorare.
Del resto i casi non sono molto dissimili: spersonalizzate figure femminili, come la Lavandaia in via della Grada a Bologna, eteree divinità placide o amorfe figure tonde, in confortevole sottomissione.
Di quest’ultima categoria fa parte un’altra installazione, questa volta ferrarese, inaugurata simbolicamente l’8 marzo 2021, la Maestà sofferente di Gaetano Pesce. In questo caso si scomoda addirittura l’immaginario pre-classico: le Veneri paleolitiche diventano, nel quartiere fieristico di Ferrara, una “donna poltrona”, un enorme corpo rosa, gonfio e trafitto come un puntaspilli da 400 frecce, circondato da sei fiere.
Interessante notare come nello spazio urbano si decida di rappresentare la violenza di genere con il più immediato binarismo esistenziale, da un lato le fiere (l’uomo), gli animali non umani simbolicamente associati alla forza del morso; dall’altro un oggetto inanimato (la donna) – il tortellino da divorare.
La Maestà, prima di approdare a Ferrara, nel 2019 è stata collocata in piazza del Duomo a Milano durante la Design Week e ha goduto di una certa attenzione mediatica. In questa occasione è stata oggetto di un’azione femminista da parte del gruppo Non una di meno, che ha organizzato un flash mob riprendendo lo slogan delle Guerrilla girls «Ceci n’est pas une femme». Come approfondiremo nel prossimo paragrafo le Guerilla girls sono riferimento imprescindibile per molte delle azioni di riappropriazione femminile degli spazi pubblici.
La contestazione di Non una di meno è rimasta inascoltata dalla città di Ferrara, che tre mesi dopo l’installazione della Maestà sofferente le ha addirittura collocato vicino un toro di bronzo, intitolato Possanza, in prestito temporaneo.
Siamo così abituati alla celebrazione della violenza machista nello spazio pubblico che neanche riusciamo più a capacitarci di quello che è: prepotenza d’azione permanente nelle rappresentazioni che circondano le nostre azioni sociali.
Quando David Harvey in Città ribelli afferma che «l’agentività sullo spazio è espressione di un classico motivo di segregazione spaziale» [Harvey 2013, 169], parlando di diritto alla città, parla anche del diritto all’esistente. Divenire agenti nello spazio urbano implica avere il diritto alla rappresentazione pubblica dell’esistente che desideriamo, alla costruzione degli infiniti immaginari collettivi che urlano di vedersi rappresentati «per vincere la povertà e la disuguaglianza sociale, per sanare le ferite prodotte dal degrado capitalista» [Harvey 2013, 169].
4. Le esperienze artistiche di riappropriazione femminile degli spazi pubblici: il precedente delle Guerrilla girls
I casi analizzati finora rientrano nel campo dell’arte di committenza istituzionale e mostrano un forte legame con la statuaria ottocentesca. Contestualmente c’è un’altra e ampia parte della sfera della produzione contemporanea che ha cercato, e sta cercando, con multiformi esperienze di comunicare e rappresentare punti di vista diversi e più vari, attraverso percorsi di riappropriazione delle città e dei luoghi pubblici. Tra gli anni Sessanta e Settanta collettivi, gruppi e cooperative di artiste hanno sentito l’esigenza di proporre una prospettiva differente e non androcentrica, e maturato «l’idea di “separare l’arte” delle donne da quella degli uomini» [Seravalli 2017, 59]. Basti pensare all’esperienza italiana di Rivolta femminile, gruppo femminista nato a Roma nel 1970 dalla volontà dell’artista Carla Accardi e della critica d’arte Carla Lonzi, con la partecipazione della scrittrice Elvira Banotti. Il gruppo rivendicava istanze femministe e «il fatto che Rivolta sia nata proprio dalla relazione tra due donne così fortemente coinvolte nell’arte è uno degli elementi più singolari» [Zapperi 2014]. Ancora di più se pensiamo che proprio dopo la rottura tra l’artista e la critica – avvenuta anche a causa della partecipazione della prima al sistema dell’arte contemporaneo, governato dalle sue regole androcentriche e di potere –, Accardi fondò nel 1976, insieme ad altre artiste, la Cooperativa del Beato Angelico con l’obiettivo di indagare il rapporto tra arte e femminismo in Italia, e aprire uno spazio espositivo gestito da donne. Esperienza artistica che rimase, tuttavia, in massima parte in spazi chiusi, privati.
Negli ultimi anni, attraverso l’utilizzo di media tipici dell’arte contemporanea, artiste, gruppi e collettivi hanno tentato di ri-occupare lo spazio pubblico, sia denunciando l’esclusione di intere categorie e soggettività, sia reintegrando queste mancanze.
Proprio per questo, andando oltre la statuaria celebrativa, rintracciamo negli esempi di seguito proposti una linea di continuità con la nostra riflessione, trattandosi di pratiche di sperimentazione del tutto inquadrabili in azioni tanto politiche quanto performative e artistiche: pratiche che occupano lo spazio e se ne riappropriano in ogni forma possibile.
Come ha scritto Patrizia Ferri, «la trasformazione dello spazio pubblico e la sua rigenerazione nella nuova realtà metropolitana è una delle questioni sostanziali della cultura contemporanea che vede la città come un organismo»; questo organismo è in costante movimento grazie a processi e dinamiche innescate da singoli, gruppi, associazioni, comunità a favore di «nuove utopie praticabili», percorse anche attraverso forme d’arte e di architettura [Ferri 2014]. È in questo scenario che si collocano le esperienze artistiche miranti a colmare l’assenza.
Il tentativo di introdurre nello spazio pubblico un protagonismo femminile affonda le sue radici nelle pratiche artistiche e di protesta degli anni Settanta, e ancor di più nel decennio successivo, quando, nel 1985, nei quartieri Soho e East Village di New York comparvero i primi poster di denuncia del collettivo di artiste e attiviste Guerrilla girls [Newhall 1987, 28].
Si tratta di un’esperienza imprescindibile per la trattazione degli argomenti, e un precedente dichiarato (come vedremo) di ciò che negli ultimi anni si è mosso nella città di Bologna.
I poster, realizzati in bianco e nero, della campagna What Do These Artists Have in Common? ponevano lə newyorkesi di fronte a dati emblematici sul sistema dell’arte americano – escludente e discriminante – attraverso frasi dirette come:
How many women had one-person exhibitions at NYC Museums last year?
Guggenheim 0
Metropolitan 0
Modern 1
Whitney 0
o ancora «Women in America earn only 2/3 of what men do. Women artists earn only 1/3 of what men artists do».
Il proposito, annunciato già con il primo comunicato ufficiale (1985), era quello di proseguire la campagna di informazione e denuncia pubblica in forma anonima e collettiva, minando quegli «atteggiamenti retrogradi» [Guerrilla girls 1985] e quel protagonismo elitario che caratterizzavano il mondo dell’arte della metà degli anni Ottanta.
Le Girls mascherate da gorilla hanno proseguito le loro attività, sia con affissioni di manifesti sia con dimostrazioni durante le inaugurazioni di mostre, occupando sempre più spazio fisico e dibattito pubblico.
Pochi anni dopo, nel 1989, hanno dato avvio alla loro campagna più famosa: Do women have to be naked to get into the Met. Museum? Accanto alla domanda provocatoria, proponevano una rivisitazione della tela di Jean-Auguste-Dominique Ingres La grande odalisca (1814), in cui il volto della protagonista era sostituito da quello di un gorilla.
Se il loro intento iniziale era quello di denunciare all’esterno di un sistema chiuso, come quello dei musei, le discriminazioni di un’élite culturale androcentrica, il loro ambito d’azione si è man mano allargato e le Guerrilla girls sono diventate un riferimento importante.
Consapevoli che non sia un caso isolato, ma frutto di un più articolato movimento di lotta che già da decenni avanzava istanze femministe, non possiamo esimerci dal riconoscere all’esperienza delle Guerrilla girls il merito di aver parlato in maniera chiara del settore culturale e di rappresentare un precedente significativo di riappropriazione di spazi condivisi e tradizionalmente maschili.
In Italia quest’assenza da colmare è stata percepita come sempre più impellente, forte anche della ribalta che la nuova ondata del movimento femminista e transfemminista ha avuto negli ultimi anni; si pensi in particolare alle azioni collettive di Non una di meno.
Contestualmente, storiche dell’arte, accademiche, critiche e curatrici hanno cominciato ad avanzare il problema, «ponendo in discussione la storiografia consolidata che per circa tre decenni ha trascurato, con poche eccezioni, l’analisi dei rapporti tra arte e femminismo e, più in generale, del ruolo delle donne nella storia dell’arte italiana» [Perna 2019].
In questo scenario non stupisce rintracciare sperimentazioni artistiche che hanno l’obiettivo non solo di colmare assenze, ma di riappropriarsi di una autonoma voce narrante attraverso gli spazi pubblici.
Tra quelle messe in pratica in questi anni da collettivi e singole artiste, ne presentiamo alcune nella nostra breve ricognizione, che non vuole essere esaustiva e completa, quanto piuttosto aprire una riflessione.
5. L’esperienza bolognese di Cheap
Fondato nel 2013 a Bologna, Cheap è un progetto di street poster art, diventato ormai di richiamo nazionale, soprattutto attraverso i canali social. Prendendo in prestito la pratica delle Guerrilla girls, Cheap ha deciso di riempire il vuoto, l’assenza femminile dallo spazio pubblico bolognese, per «cambiare quel paesaggio, per cambiare l’immaginario in strada» [7].
Nato come festival, dopo cinque anni di iniziative, le sei fondatrici hanno scelto di proseguire in maniera «più fluida, più situazionista» [8], pur rimanendo coerenti con la scelta, fatta sin dalla nascita, del medium: l’impiego di poster di carta, per loro natura effimeri. I progetti messi in campo negli otto anni di attività si sono concentrati sulla partecipazione pubblica e hanno mantenuto il focus sulle soggettività a cui per secoli tale partecipazione non è stata concessa.
Non solo poster nel loro repertorio: nel 2017, infatti, Cheap, insieme a Orticanoodles – due street artist milanesi –, ha realizzato un wall con il volto di Irma Bandiera, cogliendo la sfida di «utilizzare un linguaggio contemporaneo per celebrare l’antifascismo, intervenendo sul paesaggio urbano della città per aggiungere un altro tassello a quell’ingranaggio collettivo che è la memoria» [9] .
A questo intento si è aggiunta la volontà di raccontare una storia che non ammette esclusioni, rafforzata dalla scelta di collocare il grande ritratto su uno dei muri esterni delle scuole elementari Bombicci, nel quartiere Porto-Saragozza, nei pressi dell’abitazione dei genitori della partigiana bolognese, luogo in cui venne trucidata dai fascisti. Irma Bandiera venne infatti catturata e barbaramente torturata per sei giorni, nel tentativo di farle decifrare i documenti che trasportava. Lei non parlò e, condotta davanti casa dei genitori nell’ultimo tentativo di convincerla, venne uccisa con una raffica di mitra. La presenza del wall sul muro della scuola ha un significato che va oltre la sua commemorazione e diventa un dono alle generazioni in formazione. Quella di Irma Bandiera è una figura di donna straordinaria, una donna reale e non una rappresentazione allegorica, la sua vicenda biografica tuttavia non rompe gli schemi evidenziati all’inizio del nostro discorso: è infatti una martire.
Di poco successivo è il progetto Staffette partigiane, promosso da Canicola, associazione culturale bolognese che si occupa di divulgare la cultura del fumetto, a cui Cheap ha collaborato.
Lə promotorə lo hanno definito un «percorso per la valorizzazione di una pedagogia della memoria» [10], perché sviluppato a partire da laboratori e incontri che hanno coinvolto alcuni gruppi classe di ragazzi e ragazze bolognesi.
Attraverso la lettura di fumetti, lo studio dei documenti e l’ascolto di testimonianze, gli studenti e le studentesse, guidatə da tutor, hanno tradotto in simboli visivi, in disegni e in brevi frasi le biografie delle partigiane che hanno contribuito alla Resistenza.
Sia nell’edizione del 2018 sia in quella successiva del 2019, i poster realizzati sono stati affissi in via San Giacomo: un’installazione che ha dato vita ad un «temporaneo luogo di memoria» [11], frutto di una partecipazione collettiva e di punti di vista intergenerazionali.
Negli stessi anni il collettivo di attiviste ha proseguito su questo solco con altre iniziative tra cui: Taci, anzi Parla insieme a MissMe [12], La lotta è FICA [13], o ancora Tette fuori insieme a School of feminism [14]. Non senza creare scandalo e animare un acceso dibattito pubblico: infatti la senatrice leghista Lucia Borgonzoni è intervenuta sulla stampa disprezzando l’iniziativa e il progetto, aprendo così una controversia sulle colonne dei giornali [Guerra 2020].
Un progetto – tra gli ultimi – è di un certo interesse: LE articolo autodeterminativo, realizzato in collaborazione con Moleste [15], un collettivo di operatrici del mondo del fumetto che rivendica il riconoscimento professionale in un ambiente di lavoro equo, non discriminante, sicuro e libero da molestie. Attraverso l’affissione di 11 poster, hanno raccontato «altrettante tappe nella storia dell’autodeterminazione trans-femminista, tra lotte e figure di donne che hanno messo in discussione lo status quo» [16].
Le raffigurazioni diffuse per le strade di Bologna, hanno mostrato per settimane allə passanti non un’altra storia, ma quella parte di storia quasi sempre eclissata nei manuali e nella comunicazione mainstream: dalle «pionere» come Ada Lovelace (1834), alle «iconoclaste» tra cui Tamara De Lempicka, dalle «resistenti partigiane», alle «impavide» come Franca Viola (1966), dalle «indipendenti» che hanno manifestato e lottato per l’approvazione della legge sul divorzio nel 1970, alle «abuelas de plaza de mayo», e ancora le «auto-determinate» che hanno ottenuto l’aborto nel 1978, le gioiose (sex positivity) degli anni Ottanta, le «scomode» come Franca Rame (1987) che ha raccontato in un monologo il suo stupro, le queer degli anni Novanta e le «innamorate» che nel 2016 hanno finalmente ottenuto matrimonio same sex.
Insomma, tappe di lotte collettive, risultati a cui le proteste e i movimenti hanno portato tra il XX e il XXI secolo, che attestano l’urgenza di risignificare gli spazi e restituirli alla collettività, di reintegrare una rimozione a lungo forzata, attraverso immagini semplici e dirette, immediate.
6. La monumentale dimenticanza di Torino
Fuori dai confini dell’Emilia-Romagna, un altro gruppo si è posto le stesse domande sull’assenza femminile dagli spazi pubblici e più nello specifico dalla statuaria, ed è Monumentale dimenticanza, nato nel 2018 a Torino da Safe – Centro studi e documentazione pensiero femminile, in collaborazione con Toponomastica femminile. Il progetto è articolato in alcune azioni principali: il «censimento delle statue di donne presenti sul territorio» [17], attività didattiche mirate a far conoscere alle e agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado i monumenti presenti nella città e performance di artiste che impersonano statue femminili che così prendono vita e si raccontano.
Due sono state le tappe principali nel 2019. La prima, il 7 marzo a Torino in piazza Carlo Emanuele II accanto alla statua di Cavour, con un gruppo di attrici per dare voce a Rosalie Montmasson, Virginia Oldoini contessa di Castiglione, Rita Montagnana e Teresa Noce [18], per «raccontare la loro storia e il loro contributo alla cultura e alla società del nostro paese» [Romano 2019].
La seconda, invece, ad Asti – città in cui non ci sono, come a Torino, statue di personalità femminili [Sandrucci 2019] – il 9 marzo lungo un percorso articolato in più strade, con la messa in scena delle vicende biografiche di Maddalena Orsola e Anna Francesca Guglielma Caccia, Francesca Baggio, Lina Guenna Borgo, Rita Montagnana, Rita Levi Montalcini e Enrica Jona [19].
Nelle parole dell’artista Irene Pittatore, che ha colto le istanze di Monumentale dimenticanza e le ha sviluppate nel progetto artistico Monumenta Italia, si legge la riflessione alla base di questa iniziativa:
Non c’è dubbio che il patrimonio artistico nello spazio pubblico è sessuato. Ci muoviamo in una scenografia urbana prevalentemente composta di uomini “che hanno fatto la storia”.
Il più delle volte eretto e quasi mai inclinato, il monumento può essere interpretato come un io maschile che non prevede mai un noi. Il monumento non interroga la storia, vuole essere la storia. Il corpo pubblico è dunque il corpo maschile. Le statue delle donne non hanno nome, non documentano un fatto e si presentano il più delle volte come archetipi, simboli, muse: la prosperità, la patria, la giustizia, spesso rappresentate reclinate o inginocchiate ai piedi dell’eroe, sono simboli, quasi mai donne protagoniste di fatti o azioni.
Monumenta Italia è un cantiere artistico di studio, divulgazione e produzione che intende creare consapevolezza rispetto all’esiguità del numero di monumenti dedicati alle donne, trasformando ciò che rimane del monumento, il plinto, in una sorta di piattaforma dialettica per interrogarsi su cosa oggi significhi parlare di monumentalità, memoria e storia rispetto alla questione di genere [20].
Non è stata la prima volta che Irene Pittatore si è occupata di questioni di genere attraverso i suoi progetti artistici. Sempre nel 2019, ad esempio, è stata tra le promotrici della campagna, poi diventata un libro, #WHOSARTFOR. Art workers against exploitation con «l’obiettivo di sostenere la ricerca sulle condizioni di lavoro nel mondo dell’arte, da una prospettiva femminile» [21].
Il coinvolgimento di artiste e autrici è avvenuto tramite una open call internazionale, cosa che attesta la volontà di costruire processi partecipati e collettivi. Il mantra della partecipazione è, infatti, un’altra caratteristica di una certa produzione femminile di questi anni: tra le esperienze più note quella di Marinella Senatore, con la sua School of Narrative Dance, ossia laboratori itineranti ogni volta in una città diversa che prevedono il coinvolgimento attivo degli abitanti del posto e l’esecuzione di performance e manifestazioni nelle strade e nelle piazze. Ma anche delle sue luminarie effimere – ispirate a quelle tipiche delle feste popolari dell’Italia meridionale e arricchite con frasi tratte da scritti femministi o costruite appositamente –, come quelle realizzate per la sfilata Dior Cruise 2021 o nel cortile del Palazzo Strozzi di Firenze o per la mostra Io dico Io tenutasi nella primavera 2021 alla Galleria nazionale di arte moderna di Roma. Proprio in quest’ultimo caso la frase scelta è stata «remember the first time you saw your name», suggerendo l’idea di una fuoriuscita dal personale al pubblico.
7. Colmare l’assenza e trasformare l’esistente
Ci chiediamo a questo punto se non debba essere la partecipazione pubblica a ricucire quelle ferite urbane che l’aggiunta di statue non sarebbe di per sé capace di risanare, e se non siano da rintracciare proprio nei militanti cortei colorati e colmi di persone, negli slogan, nei cori e nei flash mob, elementi performativi tali da poter considerare gli stessi delle pratiche culturali di nuova occupazione degli spazi, a partire dalle piazze.
L’arte istituzionale ha come intento quello di occupare lo spazio urbano di commons culturali quel tanto che basta per rispolverare i confortevoli immaginari rimasti plastificati nel boom economico, al costo di una strizzata d’occhio: continuiamo ad essere rappresentazioni di bellezza, virtù cardinali, pazienti ancelle e silenti vittime di abusi; così come rimangono a farci da custodi soldati rampanti, colonizzatori, goliardici guardoni e animali feroci. Anche l’8 marzo o nelle più importanti giornate collettive, ci viene propinata una rappresentazione specifica dei ruoli sociali e delle nostre oppressioni, edulcorata e confortevole, per rimanere da monito nelle strade che percorriamo. Ne sono esempio le sempre più diffuse scarpe rosse e panchine rosse, occasione di inaugurazioni con snocciolamento di buoni propositi, più che di azioni effettive contro i femminicidi.
Ci chiediamo, quindi, di quante nuove statue abbiamo bisogno, di quante altre coscienze infelici dobbiamo circondarci prima di opporci alla devota immutabilità dei valori e alla concezione che «l’autenticità, la creatività e l’originalità siano un esclusivo prodotto borghese e non invece operaio, contadino o di altre esperienze storico-geografiche» [Harvey 2013, 140].
Le statue celebrative delle nostre città del resto non sono sempre percepite come parte di uno spazio vissuto e condiviso, non sono sempre realmente partecipate e la maggioranza delle persone che vive la città probabilmente non saprebbe collocarle con sicurezza, o magari ci è passata sotto tante volte senza davvero osservarle. Non ci stupiamo se le statue meno percepite sono anche quelle dotate dei basamenti più alti che le vanno, di fatto, a separare dal tessuto della città, non perché la contemporaneità abbia tolto il filtro “amarcord” dallo sguardo dellə passanti, ma semplicemente perché sotto la stessa pioggia felliniana (e sotto quegli alti piedistalli) non c’è più la stessa città. Tornando a Bologna tra quelle più imponenti, e meno partecipate, possiamo incontrare la statua di Luigi Galvani del 1879 di fronte all’Archiginnasio, la statua equestre di Vittorio Emanuele II nei giardini Margherita e il monumento a cavallo di Giuseppe Garibaldi in via Indipendenza.
Le esperienze contemporanee, come manifesti e murali, tendono a catturare molto di più l’attenzione del passante. Attraggono sia per il loro carattere effimero, legato al presente, sia perché parlano un linguaggio più vicino al nostro, più quotidiano e meno formale. Un’appropriazione dei linguaggi quotidiani, più che dei contenuti specifici, sul solco di quell’arte di appropriazione postmoderna degli anni Ottanta di cui ci parla Rosalind Krauss, «come critica della rete di potere che penetra nella realtà, che la struttura già da sempre» [Krauss 2017, 50].
La pietra e il bronzo sono materiali affermativi, che raccontano verità sovradeterminate. La direzione delle pratiche contemporanee effimere è opposta: la stessa scelta del medium definisce il ruolo dell’intervento nello spazio pubblico, che non si pone quindi come qualcosa di consolidato e indiscutibile. L’effimero è per sua natura soggetto al cambiamento e alla distruzione, è quindi un’esperienza che non si vuole imporre.
Un utilizzo molto consapevole di materiali non duraturi è stato sperimentato nel Monumento alle cadute partigiane nel parco di Villa Spada a Bologna, fuori dal centro. Il monumento è dedicato a 128 donne partigiane bolognesi cadute durante la lotta per la Liberazione ed è stato realizzato nel 1975 dal gruppo di architettə Città nuova. È frutto di un processo partecipativo che ha coinvolto bambinə e ragazzə di varie scuole, lə qualə ne hanno realizzato alcune componenti con materiali deteriorabili. Questa scelta è «legata all’obiettivo di costruire un monumento da rinnovare nel tempo come la memoria della Resistenza e la partecipazione condivisa al ricordo delle lotte antifascista e partigiana» [22].
Guido Checchi].
Il paragone, a margine, tra la violenta permanenza della statuaria pubblica su commissione e la denuncia performativa di strada e di piazza, è immediato: a poco servono le produzioni statuarie omogenee che nelle piazze provano ad accontentare con presunzioni di allargamento e rispetto delle specificità, quando si vive con sempre maggiore esigenza un cambiamento radicale della politica degli spazi, una trasformazione dell’esistente a partire dalla riappropriazione dell’agentività urbana. Paulo Freire, in tempi in cui il regime oppressivo degli anni Sessanta in Brasile non consentiva l’espressione di critiche né di liberi pensieri e opinioni in pubblico, teorizzava il Teatro do Oprimido, un metodo di espressione artistica dei corpi oppressi che facesse da tramite per la presa di coscienza necessaria alla decodifica dei sistemi imposti attraverso la collaborazione e la distribuzione delle informazioni.
L’assenza o la segregazione si manifestano negli spazi pubblici sia fisici – come abbiamo fino ad ora analizzato – legati alla cultura materiale, sia figurati.
I corpi delle donne, siano di pietra o di carne, sono assenti, repressi, segregati dagli spazi pubblici attraverso meccanismi che la filosofa Françoise Collin individua in: «esaltazione della “specificità femminile” e “indifferenza dei sessi”» [Laurenzi 2020, 226] [23].
Ad oggi, la lotta alla segregazione degli spazi può passare solo dalla liberazione dei corpi e delle creatività culturali dal basso di una comunità per la costruzione di relazioni sociali, politiche ed economiche di altro tipo. Abbiamo bisogno di un ripensamento, di indirizzare la rabbia alla risignificazione trasgressiva del corpo urbano; di riprenderci la sessualità, la religione, i costumi sociali e le convenzioni artistiche e architettoniche, togliendo campo d’azione alle pratiche di dominio che infestano le istituzioni culturali; di innescare processi di risignificazione e rioccupazione dello spazio, perché sia davvero libero di essere attraversato e partecipato.
Bibliografia
- Bussoni, Perna 2014
Il gesto femminista. La rivolta delle donne: nel corpo, nel lavoro, nell’arte, a cura di Ilaria Bussoni, Raffaella Perna, Roma, DeriveApprodi, 2014. - Capasso 2019
Livia Capasso, Bilanci toponomastici, in Donne in pista. On the road. Toponomastica femminile. Azioni e politiche di genere. Atti del VI e VII Convegno di Toponomastica femminile, a cura di Danila Baldo, Roma, UniversItalia, 2019, pp. 7-15, https://www.toponomasticafemminile.com/sito/images/convegnitutti/AttiVIeVII.pdf. - Casero, Di Raddo, Gallo 2017
Cristina Casero, Elena Di Raddo, Francesca Gallo, Arte fuori dall’arte. Incontri e scambi fra arti visive e società negli anni Settanta, Milano, Postmedia, 2017, https://issuu.com/gianniromano2/docs/000tuttoissuu. - Cavallini 2019
Giorgio Cavallini, Introduzione, in Moravia 2019, pp. 5-18. - Ferri 2014
Patrizia Ferri, La metropoli flessibile, in «Il Manifesto», 2 agosto 2014, https://ilmanifesto.it/la-metropoli-flessibile/. - Forcella, Lisotti, Lunardon 2020
Alexandra Forcella, Benedetta Lisotti, Ester Lunardon, Perché ci sono così poche statue di donne?, “Jacobin Italia”, 7 luglio 2020, https://jacobinitalia.it/perche-ci-sono-cosi-poche-statue-di-donne/. - Guerra 2020
Jennifer Guerra, L’arte femminista di strada che spaventa la lega di bologna svela le ipocrisie della destra bigotta, in “The vision”, 1 luglio 2020, https://thevision.com/attualita/cheap-femminismo-bologna-borgonzoni/. - Harvey 2013
David Harvey, Città ribelli. I movimenti urbani dalla Comune di Parigi a Occupy Wall Street, Milano, il Saggiatore, 2013. - Krauss 2017
Rosalind Krauss, Postrutturalismo e decostruzione, in Arte dal 1900. Modernismo, antimodernismo e postmodernismo, Bologna, Zanichelli, 2017 (I ed. 2004), pp. 42-50. - Laurenzi 2020
Elena Laurenzi, La tradizione in disputa. L’eredità filosofica nelle e delle pensatrici del Novecento, in «Post filosofie», 13 (2020), pp. 225-246. - Mi Riconosci 2020
Mi Riconosci, Perché non ci sono donne nei nostri monumenti?, in «Mi Riconosci?», 28 giugno 2020, https://www.miriconosci.it/donne-nostri-monumenti/. - Moravia 2019
Alberto Moravia, L’uomo che guarda, Milano, Bompiani, 2019 (I ed. 1985). - Newhall 1987
Edith Newhall, Whitney’s Girl Trouble, in «New York Magazine», 20 aprile 1987, p. 28. - Perna 2019
Raffaella Perna, Arte e femminismo in Italia: ragioni di una mostra, in «Flash Art», 23 luglio 2019, https://flash---art.it/2019/07/arte-e-femminismo-in-italia-ragioni-di-una-mostra/. - Pirajno 2015
Rossana Pirajno, Il senso della donna per la polis, in Le strade maestre. Un cammino di parità. Atti del II e III Convegno di Toponomastica femminile, a cura di Maria Pia Ercolini, Loretta Junck, Roma, Universitalia, 2015, pp. 127-130. - Porzio 2008
Francesco Porzio, Pitture ridicole. Scene di genere e tradizione popolare, Milano, Skira, 2008. - Romano 2019
Patrizio Romano, Monumentale dimenticanza: flash mob per ricordare le donne, in «La Stampa», 5 marzo 2019, https://www.lastampa.it/torino/2019/03/05/news/monumentale-dimenticanza-flash-mob-per-ricordare-le-donne-1.33685408. - Sandrucci 2019
Chiara Sandrucci, A Torino non ci sono statue dedicate a donne. Perché?, in «Corriere della Sera», 7 marzo 2019, https://torino.corriere.it/cultura/19_marzo_07/a-torino-non-ci-sono-statue-dedicate-donne-perche-f476d90a-40ee-11e9-8d4c-9b3b6b114344.shtml. - Sermenghi 2017
Saura Sermenghi, Considerazioni sulla mia scultura La lavandaia, in Saura Sermenghi: La lavandaia in Via della Grada a Bologna che “nella sua nudità lava e si lava”, in «Inchiesta online», 19 aprile 2017, http://www.inchiestaonline.it/arte-poesia/saura-sermenghi-la-lavandaia-in-via-della-grada-a-bologna-che-nella-sua-nudita-lava-e-si-lava/. - Viscardi 2013
Giuseppina Paola Viscardi, Usi letterari e significati culturali del Kredemnon in Grecia antica: la “retorica costitutiva” del velo nella prassi dell’invisibilità, in «I Quaderni del Ramo d’Oro» 6 (2013/2014), http://www.qro.unisi.it/frontend/node/167.
Risorse
- Canicola
https://www.canicola.net/. - Cheap Festival
https://www.cheapfestival.it/. - Mi Riconosci, Mappa dei monumenti femminili italiani
https://www.miriconosci.it/mappa-dei-monumenti-femminili-italiani/. - Moleste
http://www.moleste.org/. - Monumentale dimenticanza
http://www.fundforsafe.org/eventi-satellite-monumentale-dimenticanza/. - Monumenta Italia
https://irenepittatore.it/monumenta-italia/.
Note
1. In questa sede affronteremo soltanto gli aspetti legati alla rappresentazione dei soggetti femminili.
2. Dati del censimento di Toponomastica femminile, https://www.toponomasticafemminile.com/sito/index.php/bologna-bo. I dati sono commentati sullo stesso sito dell’associazione https://www.toponomasticafemminile.com/sito/index.php/bologna-e-le-sue-donne.
3. http://sitmappe.comune.bologna.it/ToponimiFemminili/.
4. https://www.bibliotecasalaborsa.it/cronologia/bologna/2020/la_scultura_madre_di_guy_lydster_ai_giardini_margherita#top
5. Non intendiamo con questa considerazione generalizzare sulla simbologia della vulva e sulla sua rappresentazione. Infatti, ad una appropriazione fatta da un artista uomo, si può contrapporre la riapproriazione iconografica della vulva, condotta dai gruppi femministi a partire dagli anni Settanta con la reiterazione nelle piazze del «gesto femminista» [Bussoni, Perna 2014]. Più di recente, alcuni collettivi territoriali di Non una di meno hanno recuperato questa simbologia anche attraverso la realizzazione di statue-vulve, esibite durante i cortei. Nello specifico a Bologna per l’8 marzo del 2017 è stata portata in processione una Sacra vulva di cartapesta e a Roma in piazza Sempione nel marzo del 2021 è stata esposta una grande vagina di cartapesta fucsia per la celebrazione della Holy Vagina, manifestazione di protesta contro gli attacchi ai diritti civili da parte di un parroco del Terzo municipio.
6. La vicenda viene addirittura interpretata ogni anno alla sagra del tortellino di Castelfranco Emilia, https://www.lasannicola.it/festa-di-san-nicola-sagra-del-tortellino/osti-e-dame.html.
7. Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=Q3m-Ge7HHW4.
8. https://www.cheapfestival.it/le-festival-est-mort-vive-le-festival.
9. https://www.cheapfestival.it/irma-bandiera-wall-il-video/.
10. https://www.canicola.net/2020/04/25/staffette-partigiane/.
11. https://www.cheapfestival.it/cheap-per-staffette-partigiane/.
12. https://www.cheapfestival.it/taci-anzi-parla-missme-per-cheap-foto-gallery/.
13. https://www.cheapfestival.it/la-lotta-e-fica-un-progetto-femminista-di-art-pubblica-di-cheap/.
14. https://www.cheapfestival.it/tette-fuori-a-bologna-la-nuova-affissione-di-poster-di-cheap-insieme-a-school-of-feminism/.
15. http://www.moleste.org/chi_siamo/.
16. https://www.cheapfestival.it/cheap-moleste-le-articolo-autodeterminativo/.
17. http://www.fundforsafe.org/eventi-satellite-monumentale-dimenticanza/.
18. Si tratta di quattro donne piemontesi o legate alla regione: Rosalie Montmasson (Saint-Jorioz 1823-Roma 1904) patriota; Virginia Oldoini contessa di Castiglione (Firenze 1837-Parigi 1899) patriota; Rita Montagnana (Torino 1895-1979) politica e costituente; Teresa Noce (Torino 1900-Bologna 1980) partigiana e costituente.
19. Maddalena Orsola Caccia (Moncalvo 1596-1676) pittrice; Anna Francesca Guglielma Caccia (Asti 1608?-1628) pittrice; Francesca Baggio insegnante e attivista per l’emancipazione femminile; Lina Guenna Borgo (Novi Ligure 1869-Asti 1932) pedagogista; Rita Montagnana (Torino 1895-1979) costituente; Rita Levi Montalcini (Torino 1909-Roma 2012) neurologa; Enrica Jona (Asti 1910-2000) insegnante deportata ad Auschwitz.
20. https://irenepittatore.it/monumenta-italia/.
21. https://associazioneimpasse.org/.
22. https://www.storiaememoriadibologna.it/monumento-alle-cadute-partigiane-1877-opera.
23. Il riferimento alla filosofa franco-belga Françoise Collin è tratto da un contributo pubblicato nel 2021 sull’eredità filosofica nelle e delle pensatrici del Novecento. Per approfondimenti si rimanda allo stesso.
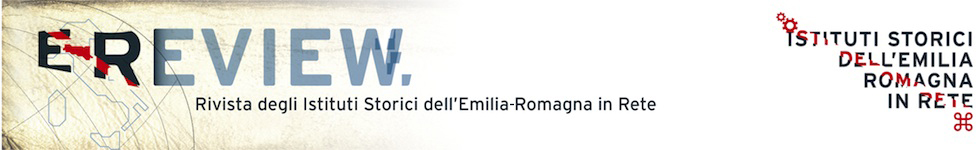
![Fig. 1. Mario Rutelli, monumento ad Anita Garibaldi, 1932, Roma. Nel dettaglio Anita guida attraverso le pampas una schiera di combattenti [foto delle autrici].](./sites/default/images/articles/media/260/Carrieri_Forcella_Piazzi_Women_01.jpg)


![Figg. 3 e 4. Saura Sermenghi, “Lavandaia”, 2000, Bologna [foto Guido Checchi].](./sites/default/images/articles/media/260/Carrieri_Forcella_Piazzi_Women_04.JPG)
![Fig. 5. Nicola Zamboni, “Lavandaie” (dettaglio), 1998, Sant’Agata Bolognese, Bologna [foto delleautrici].](./sites/default/images/articles/media/260/Carrieri_Forcella_Piazzi_Women_05.jpg)


![Figg. 6-8. Giovanni Ferrari, “Monumento al tortellino”, 2006, Castelfranco Emilia, Modena [foto delle autrici].](./sites/default/images/articles/media/260/Carrieri_Forcella_Piazzi_Women_08.jpg)
![Fig. 9. Guerrilla girls, posters, 1985, New York [foto Flapane, CC0, via Wikimedia Commons].](./sites/default/images/articles/media/260/Carrieri_Forcella_Piazzi_Women_09.jpg)
![Fig. 10. Guerrilla girls, “Do women have to be naked to get into the Met. Museum?”, 1989 [foto Eric Huybrechts, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons].](./sites/default/images/articles/media/260/Carrieri_Forcella_Piazzi_Women_10.jpg)
![Fig. 11. Cheap e Orticanoodles, “Irma Bandiera”, 2017, Bologna [foto Marcella Culatti].](./sites/default/images/articles/media/260/Carrieri_Forcella_Piazzi_Women_11.jpg)

![Figg. 12-13. Monumentale dimenticanza, 2019, Torino [foto Safe].](./sites/default/images/articles/media/260/Carrieri_Forcella_Piazzi_Women_13.JPG)
![Fig. 14. Associazione Rosso Magenta, panchina rossa inaugurata il 5 giugno 2021, piazza Matteotti, Budrio, Bologna [foto delle autrici].](./sites/default/images/articles/media/260/Carrieri_Forcella_Piazzi_Women_14.jpg)
![Fig. 15. “Monumento alle cadute partigiane” (dettaglio), 1975-2015, Parco di Villa Spada, Bologna [fotoGuido Checchi].](./sites/default/images/articles/media/260/Carrieri_Forcella_Piazzi_Women_15.JPG)



