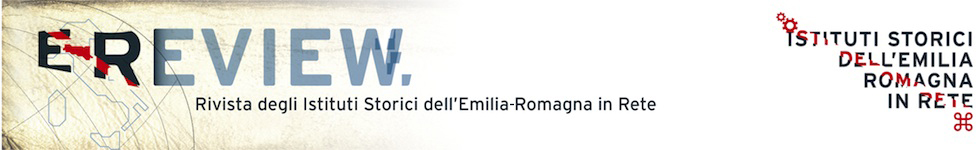Narrare il fascismo deve partire da tre considerazioni primarie: la prima è che il fascismo sia un terreno di controversie, che si muovono vorticosamente dalla storiografia alla memoria pubblica e viceversa, che non potrà essere eluso, ma che dovrà per certi versi percorrere il centro di interpretazione di Predappio; la seconda è che proprio in ragione di queste complesse radici storiche e culturali la sua rappresentazione storiografica sia un cantiere aperto, nel quale molte domande restano ancora senza una risposta compiuta e condivisa; la terza riguarda una permanente attualità del fascismo nella coscienza collettiva italiana e anche europea, che emerge anche se riflettiamo solamente sul dibattito che si è aperto tra gli storici e gli intellettuali di fronte al progetto fortemente voluto dal Comune di Predappio. Questa attualità dipende a mio giudizio non tanto dal fatto che sia all’orizzonte nello spazio politico continentale il ritorno di una soluzione fascista della crisi che stiamo attraversando, come invece accadde negli anni Trenta, quanto piuttosto dal fatto che fare i conti con il fascismo - sia sul piano dell’interpretazione storica, sia su quello delle memorie pubbliche - si è rivelata, e continua a rivelarsi, un’operazione più complessa del previsto e questo a mio parere per due ragioni sostanziali.
La prima chiama in causa, soprattutto nei paesi che hanno vissuto il fascismo, le profonde eredità in una molteplicità di campi della vita collettiva. È in sostanza il fascismo un passato che non passa, non solo e non tanto, a mio parere, per la permanenza di piccoli gruppi politici che esplicitamente si rifanno a quell’ideologia, ma soprattutto perché la sua persistenza nel discorso pubblico, combinata con le difficoltà di elaborare un giudizio condiviso, fanno apparire il fascismo un fenomeno ancora non completamente concluso. Questa prima ragione è fortemente connessa alla seconda e chiama in causa direttamente la storiografia, le sue incertezze, le sue incapacità nel riconoscere la complessità teorica e l’effettiva dimensione storica di un fenomeno che ha segnato profondamente e drammaticamente, come peraltro il comunismo, l’intera storia del Ventesimo secolo. Soprattutto la storiografia italiana, debitrice per oltre un trentennio del quadro interpretativo elaborato dai militanti antifascisti durante gli anni feroci della repressione e nell’esilio, è rimasta prigioniera di categorie e di griglie metodologiche sostanzialmente inadeguate ad aggredire quella complessità e quella dimensione implicite nel suo oggetto di studio.
Infatti la rappresentazione del fascismo come regime reazionario antiprogressista, accompagnata dalla denuncia della sua inconsistenza ideologica – basta qui ricordare Bobbio -, dei suoi caratteri classisti, della sua incapacità a favorire lo sviluppo economico e sociale, della sua anti-modernità, ha retto sempre meno alla prova dei fatti e si è rivelata inadeguata a rendere compiutamente ragione di un fenomeno, che alla vigilia della Seconda guerra mondiale si era imposto in mezza Europa e appariva dotato di una forza propulsiva superiore non solo alla democrazia parlamentare, ma anche al comunismo. Nonostante l’Italia fosse stata il laboratorio del fascismo, solo con la storia del nostro paese si poteva spiegare una parte soltanto del fenomeno, che era nella sua stessa origine transnazionale. Inoltre con le chiavi di lettura del fuoriuscitismo antifascista – dalla «malattia morale» della borghesia di Benedetto Croce, all’autobiografia della nazione di Gobetti, alla «dittatura terroristica aperta degli elementi più reazionari, più sciovinisti e più imperialisti del capitale finanziario», come recitavano i documenti della III Internazionale - restava sullo sfondo quell’intreccio di fenomeni collegati ai processi di massificazione della società, con la trasformazione del “popolo” ottocentesco nella folla anonima della modernità novecentesca, che in anni recenti si è rivelato un terreno criticamente fecondo per penetrare più a fondo la natura del fascismo e le cause del suo successo.
Non dobbiamo dimenticare che questo modello di spiegazione del fascismo, giustamente definito come “paradigma antifascista”, improntò la ricerca storica nel trentennio successivo alla Seconda guerra mondiale e venne divulgato prima dalla scuola, poi dai mezzi di comunicazione di massa. Si trattò del fondamento non solo del lavoro storiografico di una intera generazione di studiosi, ma anche del discorso pubblico sul fascismo. Esso definiva cioè contemporaneamente il perimetro euristico nel quale orientare gli studi e lo spazio di legittimità di ogni giudizio sul fascismo presso l’opinione pubblica. Le conseguenze di questo modello interpretativo dominante, nel quale la condanna etico-politica prevaleva sullo sforzo analitico sono state molteplici. La prima e più grave è consistita nel fatto che la storiografia antifascista non si sia cimentata in uno scavo storiografico compiuto del Ventennio, capace di produrre una “storia del fascismo” paragonabile per ampiezza della documentazione e per novità metodologiche a quella elaborata da Renzo De Felice e dalla scuola cosiddetta “revisionista”, ma si sia è concentrata quasi esclusivamente sull’affermazione della dittatura nei primi anni Venti e sul suo crollo negli anni della Seconda guerra mondiale, secondo uno schema analitico che si affermò già con i primi due tentativi di scrivere una storia “antifascista” del fascismo: le lezioni di Federico Chabod tenute nel 1950 all’Institut d’études politiques di Parigi e pubblicate con il titolo L’Italia contemporanea 1918-1948 pochi anni dopo da Einaudi in un volumetto che può essere annoverato tra i grandi successi editoriali del dopoguerra, e la Storia del fascismo di Luigi Salvatorelli e Giovanni Mira, edita nel 1952 da un piccolo editore romano.
La centralità delle origini aveva una indubbia valenza politica, che riguardava più la repubblica nascente che l’oggetto storico specifico, nella misura in cui indagando sul nesso continuità/rottura tra Italia liberale e fascismo si tentava di mettere in evidenza la necessità di una radicale discontinuità tra la democrazia repubblicana e il liberalismo, poiché il fascismo non era altro che una degenerazione di quest’ultimo. Ma questa operazione che possiamo definire di uso pubblico della storia, sul piano della ricerca storica comportò il paradosso di escludere dal suo campo d’indagine proprio il fascismo stesso, cioè l’affermazione e la stabilizzazione del regime che occupò circa un quindicennio, dal 1926 al 1940. Dallo sguardo storiografico sono così fuoriusciti programmaticamente il partito e la sua organizzazione di massa, l’ideologia come strumento di mobilitazione politica, le forme di integrazione sociale, le trasformazioni istituzionali, le dinamiche del corporativismo perché ritenuti fenomeni inessenziali alla formulazione di un giudizio storico sul fascismo; oppure, se vi comparivano, erano rubricati esclusivamente nel novero dei “fallimenti” del regime.
Da questa scelta è derivata la seconda conseguenza: l’assenza di una analisi dei rapporti tra il regime e la società italiana tra le due guerre. In un quadro interpretativo modellato sul binomio reazione/stagnazione e sull’asse fascismo/antifascismo le trasformazioni della società italiana sfuggivano necessariamente all’osservazione scientifica, in parte perché tutta l’azione del regime era letta come mera manifestazione di un disegno restauratore privo di elementi di novità e chiuso in un perimetro di motivazioni e nessi causali dominato dalla difesa degli interessi di classe, dalla retorica strumentale, dalle spinte regressive o della mera reiterazione di scelte già operate in precedenza; e in parte perché tutti i fenomeni sociali e politici che uscivano dalla dialettica repressione/resistenza, controllo autoritario/ribellione, entravano in un cono d’ombra che faceva loro perdere progressivamente lo statuto di oggetti storiografici.
La terza conseguenza ha riguardato la difficoltà, se non addirittura l’impossibilità, di confrontarsi con i modelli di spiegazione del fascismo elaborati, fin dagli anni Trenta, dalle scienze sociali. I riferimenti d’obbligo vanno da Karl Mannheim di Ideologia e Utopia, uscito nel 1929, a Emil Lederer de Lo stato delle masse del 1940 (ma pubblicato in Italia solo nel 2007 per iniziativa di Mariuccia Salvati), fino a Hannah Arendt con il suo Le origini del totalitarismo, di un anno successivo.
La chiave interpretativa che li accomuna è la ricerca di una “teoria generale” del fascismo inteso come categoria ermeneutica valida per spiegare il fascismo al di là delle sue specificità nazionali, facendo leva non solo su una serie di concettualizzazioni che derivavano dall’analisi del rapporto tra masse e stato nell’epoca della società di massa, ma anche definendo in chiave scientifica la categoria del totalitarismo, che gli stessi regimi fascisti avevano utilizzato per definire se stessi, ma che gli storici italiani invece avevano completamente lasciato da parte. In realtà anche questi sociologi, soprattutto tedeschi, intendevano rispondere alla domanda: che cos’è il fascismo? Ma per rispondere, nonostante l’indubbio profilo ideale antifascista che li accomunava, scelsero un percorso critico del tutto diverso da quello seguito dagli storici militanti italiani, volto a cogliere le novità espresse da questo nuovo progetto politico emerso nell’Europa del primo dopoguerra.
In questo contesto furono proprio il concetto di reazione e la convinzione che il fascismo non appartenesse al novero delle grandi correnti del pensiero politico novecentesco a essere sottoposto a una critica serrata. Infatti le indagini convergevano a evidenziare come nell’Europa dopo la Grande guerra avessero una forza prorompente nello spazio politico nuove dottrine radicali, caratterizzate dal rifiuto dello stato di diritto e del parlamentarismo in nome di una tavola di nuovi valori ideali e politici che ruotava attorno al collettivismo, all’autoritarismo dirigista, al primato dello stato come interprete e fondatore di una comunità organica, all’attivismo e al nazionalismo, da cui si sarebbero generati nel crogiuolo della guerra mondiale la soluzione bolscevica e quella fascista.
L’intreccio causale che aveva generato questo nuovo profilo ideologico del Novecento, tanto diverso da quello del secolo precedente, doveva essere ricercato nelle interconnessioni tra guerra totale di massa e crisi della democrazia: qui stava la genesi delle forze rivoluzionarie che si incaricarono del compito di dissolvere la vecchia Europa liberale e di ricostruire “ordini nuovi”, fondati sul controllo totalitario della società da parte di élite radicali e fortemente politicizzate.
Il fascismo si collocava dunque nell’ambito di un processo di radicalizzazione politica, generata da quell’“apprendistato alla politica di massa”, per dirla con François Furet, che per milioni di giovani si realizzò nelle trincee disseminate in tutto il vecchio continente tra il 1914 e il 1918. È la guerra, dunque, l’evento originario di un’“era rivoluzionaria”. In essa non solo si vennero delineando soluzioni diverse e contrastanti alla crisi dello stato liberale e dei suoi strumenti di integrazione sociale, imperniate sulla contrapposizione delle due idee guida di classe/nazione - la prima attribuibile al comunismo, la seconda al fascismo -, che furono in grado di incanalare in un nuovo quadro ideologico e istituzionale la democratizzazione e la mobilitazione sociale messe in moto dal conflitto mondiale.
In questo quadro la coppia di opposti reazione/progresso non era in grado di cogliere la complessità delle questioni in gioco perché essa apparteneva a quella “civiltà ottocentesca” dal cui tramonto sono emerse quelle forze rivoluzionarie le cui ideologie, pur differenziate, sono accomunate da una critica radicale alla democrazia e ai fondamenti dello stato rappresentativo, e dall’intento di trasformare le nazioni in comunità di destino sotto la guida del partito unico e del capo carismatico. Era infatti emersa, tra gli esiti sconvolgenti della Grande guerra, una “rivoluzione” di tipo nuovo, che si collocava fuori dal perimetro ideale definito dall’idea di progresso e di emancipazione che aveva trovato il suo modello di riferimento nella rivoluzione del 1789, ma che non poteva essere sbrigativamente liquidata come una semplice controrivoluzione. Rispetto a questo quadro di problemi lo storicismo antifascista ha continuato a intrecciare un rifiuto pregiudiziale e una difficoltà oggettiva a confrontarsi criticamente con le categorie elaborate nell’ambito delle scienze sociali. Le difficoltà nascevano anche dal fatto che il paradigma antifascista era diventato una componente essenziale della cultura politica dei partiti su cui si reggeva la Repubblica democratica e gli storici antifascisti avevano avuto un ruolo essenziale nella sua costruzione. Inoltre non bisogna dimenticare che, fino agli inizi degli anni Sessanta, attorno al regime e alla Resistenza era stato steso uno spesso velo di oblio dalle classi dirigenti moderate, strette intorno alla Democrazia cristiana. Le battaglie civili degli storici contribuirono a infrangerlo definitivamente solo alla vigilia degli anni caldi del Sessantotto. Infine a rafforzare la scelta di non mettere in discussione quel paradigma che con tanta fatica si era consolidato nell’opinione pubblica, contribuì anche la presenza di una radicata, seppur minoritaria, costellazione di forze neofasciste, arroccate in una pregiudiziale delegittimazione della cultura antifascista.
Ridurre il peso dei condizionamenti degli usi pubblici della storia sull’inevitabile innovazione storiografica significava ridimensionare l’approccio esclusivamente etico-politico allo studio del fascismo. Questo ridimensionamento comportava alcune inevitabili rinunce. La prima consisteva nel rinunciare al presupposto che lo spazio politico tra le due guerre fosse diviso tra due estremi - “destra” e “sinistra” – radicalmente eterogenei tra di loro, dal punto di vista ideologico, sociale, e culturale, perché appartenenti ai campi opposti della reazione/conservazione e della rivoluzione/progresso. La seconda comportava abbandonare la convinzione che il fascismo non rappresentasse uno dei fenomeni attraverso i quali declinare la modernità novecentesca: la sola ammissione era ritenuta spia di una rivalutazione storica del regime e preludeva a un oggettivo “fiancheggiamento” di quelle forze presenti nel mondo culturale e nella società civile che tentavano di mettere in discussione il fondamento antifascista della democrazia italiana.
In questo contesto la revisione storiografica proposta da Renzo De Felice, frutto soprattutto di una indagine condotta su una massa di fonti per la prima volta a disposizione degli storici, irruppe con una radicalità che dipendeva non solo dalle novità interpretative che emergevano dalla monumentale biografia di Mussolini, ma soprattutto dall’impatto che essa ebbe sull’uso pubblico del passato, in un momento nel quale il progetto politico di Craxi implicava una delegittimazione del paradigma antifascista. Tuttavia il “revisionismo” storiografico di De Felice e dei suoi giovani allievi non poteva essere racchiuso nei suoi usi pubblici, né tanto meno considerato un fenomeno solo italiano. Si inseriva infatti in una nuova stagione di studi sul fascismo e il totalitarismo su scala internazionale, i cui punti di forza furono gli studi di George Mosse sulla nazionalizzazione delle masse, quelli sulla destra rivoluzionaria francese di Zeev Sternhell e Michel Winock, e le ricerche del sociologo Gino Germani sui rapporti tra autoritarismo e modernizzazione.
Il merito principale di De Felice fu quello di aver legittimato lo studio del fascismo come campo di ricerche aperto da cui sono emerse alcune questioni fondamentali su cui si è soffermata la storiografia degli ultimi tre decenni: il rapporto tra il regime e la società italiana, il consenso di massa alla dittatura soprattutto delle classi medie, l’ideologia, la natura e le funzioni del partito unico, il ruolo della leadership di Mussolini, e soprattutto i caratteri della modernizzazione generata dalle politiche totalitarie, dirigiste e corporative. Si leggevano dietro quest’ultimo aspetto le ricerche di Barrington Moore jr., confluite nel volume Le origini sociali della democrazia (1966), nel quale venivano comparate le diverse vie alla modernizzazione industrialista: una di esse era quella fascista, i cui caratteri distintivi dipendevano dalla debolezza delle élite economiche, dal ruolo giocato dallo stato nel promuovere il decollo industriale, dal peso della rendita negli equilibri sociali e dalla soglia raggiunta dai processi di democratizzazione della società.
Sull’ideologia del fascismo si è soffermato soprattutto Emilio Gentile, allievo di De Felice, con i suoi studi sulle connessioni tra il fascismo e la cultura nazionalista, ma anche sulla coniugazione di questo bagaglio di idee e valori con le ideologie della modernità presenti nella cultura italiana del primo Novecento. La conquista della modernità, i miti industrialisti, l’esaltazione della velocità, la fiducia nella tecnica, la passione per il nuovo si trasferirono integralmente nell’ideologia fascista.
Il fascismo ebbe l’ambizione - ha scritto Gentile - di portare a compimento la conquista della modernità attraverso la rivoluzione totalitaria, che come la rivoluzione spirituale delle avanguardie voleva essere rivoluzione totale, cioè investire tutti gli aspetti della vita individuale e collettiva, del costume e del carattere, per rigenerare la nazione, forgiare l’“italiano nuovo”, costruire una nuova civiltà. Lo stato totalitario e la “sacralizzazione della politica”, con l’integrazione delle masse nella nazione attraverso la fede, i riti e i simboli della religione fascista erano i fondamenti della “modernità fascista” [...] che imponeva agli individui e alle masse la rinuncia alla libertà e alla ricerca della felicità in nome del primato assoluto della collettività nazionale organizzata nello stato totalitario, per conseguire fini di grandezza e di potenza.
È l’ideologia, propagandata dal partito, il grande pedagogo collettivo, il perno e lo strumento di quel “consenso” al regime che costituì l’innovazione ermeneutica più rilevante e nota del progetto scientifico defeliciano e l’oggetto che scatenò per un decennio una durissima polemica storiografica con la storiografia antifascista. Infatti molti storici antifascisti, da Guido Quazza a Nicola Tranfaglia, non solo misero in dubbio che la mobilitazione coatta della popolazione a sostegno del regime potesse essere confusa con una adesione effettiva alla sua religione politica, ma lessero in quella nuova interpretazione del rapporto tra masse e fascismo il tentativo di rivalutare la dittatura e di legittimare uno dei punti di forza della cultura neofascista.
In realtà la tesi di De Felice affondava le sue radici in quel nesso tra totalitarismo e democratizzazione delle società industriali che era stato portato alla luce dagli studi sociologici dei primi anni Sessanta, e che in un quadro metodologico del tutto differente confermava le intuizioni che nel carcere fascista aveva avuto Antonio Gramsci, poi raccolte nel quaderno su Americanismo e fordismo.
De Felice confermava dunque che la tesi cara alla storiografia antifascista secondo la quale il fascismo sarebbe stato una “chiesa senza fedeli” era purtroppo infondata, perché il totalitarismo era un fenomeno politico del tutto nuovo rispetto ai regimi autoritari del passato, proprio perché si fondava sulla mobilitazione politica di numerose fasce sociali. In questo quadro il fascismo poteva essere letto come movimento politico e poi sistema politico delle classi medie, che per la prima volta agli albori del Novecento erano comparse con un profilo autonomo nello spazio politico. A differenza della borghesia e del proletariato, le classi medie stavano progressivamente smarrendo le già scarse connotazioni di classe ereditate dall’Ottocento, ed erano sospinte dai processi strutturali verso una collocazione sociale ambigua, nella quale a talune possibilità individuali di miglioramento di status si contrapponeva un processo di generale atomizzazione sociale. Il fascismo esprimeva sul piano ideologico questo complesso mutamento sociale, nel quale le classi avevano lasciato il posto alle “folle anonime”: un aggregato sociale di proporzioni crescenti nel quale avevano progressivamente perduto di significato il valore della persona e le appartenenze di gruppo, che trovava la sua caratterizzazione di fondo nella fusione emotiva degli individui in un insieme di credenze e di sentimenti collettivi, al di là delle differenze di classe e di stato.
Ma le ricerche che su questo nuovo tronco interpretativo si sono mosse dagli anni Novanta fino a oggi hanno messo in evidenza alcune aporie che minavano la forza interpretativa del revisionismo defeliciano. La prima riguardava l’esclusione del fascismo italiano dal novero dei totalitarismi - in questo condividendo il punto di vista dei suoi antagonisti, cioè gli storici antifascisti -, sulla scorta delle analisi della Arendt che applicava la categoria del totalitarismo solo al nazismo e allo stalinismo. A ben guardare, come ha messo in luce Gentile, da questa scelta che affondava le sue radici nel rifiuto di considerare il fascismo in un’ottica comparata, prendeva le mosse una complessa operazione di “defascistizzare” il fascismo stesso. Liberato da un lato dalla sua natura totalitaria e dall’altro ridotto ad un unicum, il fascismo restava quasi una sorta di regime reazionario “all’italiana” che aveva perduto tutta quella forza innovativa che De Felice stesso gli aveva attribuito. In quest’ottica, il consenso perdeva il suo significato di esito della mobilitazione totalitaria, ma si riduceva alla semplice adesione della popolazione al suo aspetto esteriore di dittatura “bonaria”, priva di quelle valenze terroristiche che contraddistinguevano nazismo e bolscevismo, riassunta nel mito di Mussolini, capo egocentrico, megalomane, spietato nel tenere sotto controllo la classe dirigente fascista, ma generoso con gli italiani, amato più che temuto, se non da sparute minoranze ininfluenti. Con la collocazione del fascismo al di fuori del totalitarismo, si negava la possibilità (e l’utilità euristica) di poterlo paragonare con il regime nazista, che di conseguenza poteva essere comparato solo con il bolscevismo, rapidamente assurto a effettivo modello dello stato totalitario. In questa ansia di liberare il fascismo da ogni paragone con il nazismo, fino a svalorizzare il peso delle leggi razziali nel profilo ideologico dell’ultimo fascismo, De Felice compiva un ulteriore distacco dalle premesse metodologiche originarie del suo progetto interpretativo. Il fascismo veniva ridotto a “mussolinismo”, cioè al potere dispotico di un capo politico ambizioso, progressivamente travolto dalle sue utopie e dalle sue debolezze e nello stesso tempo a una sorta di rivoluzione fallita, dalla quale era nato un regime autoritario che si collocava in un’ambigua continuità con il passato prebellico, di cui rimanevano lacerti dello stato di diritto.
Alla fine del suo itinerario De Felice si era trovato su molti punti di vista meno lontano dai suoi critici di quanto non era apparso durante la polemica sul revisionismo, ma la strada aperta dai suoi studi aveva ormai mosso una nuova generazione di storici consapevole della centralità del fascismo nel “secolo breve”, nella misura in cui al suo interno erano transitate tutte le questioni cruciali con cui leggere il XX secolo: modernità, mobilitazione delle masse, violenza politica, rapporti tra stato e mercato, ideologie di massa, partiti, in una chiave transnazionale. E questo è il fenomeno che noi dobbiamo cercare di restituire ai visitatori del nostro futuro museo.
Bibliografia
- Arendt H. 1967 (ed. or. 1951)
Le origini del totalitarismo, Milano: Edizioni di Comunità. - Chabod F. 1961
L’Italia contemporanea (1918-1948), Torino: Einaudi. - De Felice R. 1965-1997
Mussolini, Torino: Einaudi. - Gentile E. 1975
Le origini dell’ideologia fascista (1918-1925), Roma-Bari: Laterza. - Gentile E. 1982
Il mito dello Stato nuovo. Dal radicalismo nazionale al fascismo, Roma-Bari: Laterza. - Gentile E. 1993
Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Roma-Bari: Laterza. - Gentile E. 1995
La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista, Roma: La Nuova Italia Scientifica. - Germani G. 1975
Autoritarismo, fascismo e classi sociali, Bologna: il Mulino. - Gramsci A. 1978
Quaderno 22. Americanismo e fordismo, a cura di F. De Felice, Torino: Einaudi. - Lederer E. 2004 (ed. or. 1940)
Lo Stato delle masse. La minaccia della società senza classi, a cura di M. Salvati, Milano: Bruno Mondadori. - Mannheim K. 1957 (ed. or. 1929)
Ideologia e utopia, Bologna: il Mulino. - Moore jr. B. 1969 (ed. or. 1966)
Le origini sociali della dittatura e della democrazia. Proprietari e contadini nella formazione del mondo moderno, Torino: Einaudi. - Mosse G.L. 1975 (ed. or. 1974)
La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania (1815-1933), Bologna: il Mulino. - Quazza G. 1973
Storia del fascismo e storia d’Italia, in Id. (a cura di) 1973, Fascismo e società italiana, Torino: Einaudi. - Salvatorelli L. e Mira G. 1956
Storia d’Italia nel periodo fascista, Torino: Einaudi. - Sternhell Z. 1997 (ed. or. 1978)
La destra rivoluzionaria, Milano: Corbaccio. - Tranfaglia N. 1973
Dallo Stato liberale al regime fascista. Problemi e ricerche, Milano: Feltrinelli. - Winock M. 1990
Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Paris: Seuil.
Risorse on line
- Video della relazione al convegno Narrare il fascismo (Predappio, 20-21 gennaio 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=0seXx0shRgQ&list=PLxGOsmJFBypCG3djptXjFGTm1yLP902u-&index=1