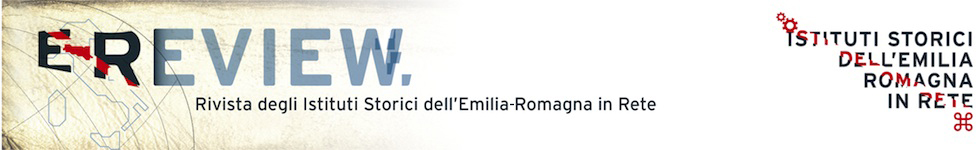A proposito di Fausto Anderlini, Il voto, la terra, i detriti. Fratture sociali ed elettorali. Dall’alba del 2 giugno 1946 al tramonto del 25 febbraio 2013, Bologna, Editrice Socialmente, 2013
L’autore parte da una intuizione intorno alla quale i suoi studi riflettono da anni. Analizzando l’insediamento territoriale dei partiti nella fase fondativa della Repubblica (1946-1953) emerge una connessione immediata fra strutture agrarie e comportamenti di voto. «La Repubblica italiana sgorga dunque dalla terra» (p. 12) e vede emergere due grandi “monopolisti” terrieri: la Democrazia cristiana e il Partito comunista, capaci di fissare un rapporto di supremazia con porzioni macro-regionali dello spazio agrario. Segnatamente, la Dc come rappresentante del mondo dei conduttori agricoli del Nord e del Centro-sud, oltre che dei ceti possidenti; il Pci acquisendo il monopolio della rappresentanza mezzadrile nell’Italia centrale e di buona parte delle masse salariate dell’agricoltura padana e del latifondo meridionale (proprio attraverso il forte insediamento nelle campagne, i comunisti riescono a scalzare il Partito socialista dal ruolo di partito-guida della sinistra italiana, circoscrivendone il radicamento alle periferie urbano-industriali). A partire da queste basi popolari a carattere regionale, Dc e Pci procedono ad acquisire una compiuta fisionomia nazionale, divenendo i mediatori privilegiati dei rapporti centro-periferia e i fondamentali canali integratori delle masse nello Stato democratico.
Fino a quando – viene da chiedersi – è applicabile un quadro socio-politico di questo tipo? Secondo Anderlini esso mantiene una validità di fondo più a lungo di quanto non ci si aspetti. Si potrebbe pensare, infatti, che l’Italia degli anni Settanta, quella uscita dal boom economico, certifichi una volta per tutte l’abbandono e il superamento del rapporto fondativo tra i partiti e la terra. Ma, a ben vedere, non è così. Del resto, come argomenta Anderlini, la clamorosa crescita delle città degli anni Cinquanta e Sessanta è sostenuta dalle migrazioni che originano dal mondo rurale; e questo è vero sia nella dimensione locale-regionale, che per quanto concerne gli spostamenti inter-regionali. Una delle peculiarità delle nuove masse urbane è che i loro membri arrivano in città dopo aver già conosciuto la socializzazione politica dei grandi partiti “nazionali-agrari”, ed è perciò naturale che la ri-socializzazione urbana avvenga tramite gli stessi soggetti politici. «Non per caso i due massimi monopolisti della terra, il Pci e la Dc, quest’ultima almeno nelle sue componenti socialmente più impegnate (emblematica, ad esempio, l’esperienza del dossettismo nella Bologna dei ’50), si ingaggiano in una gara a infrastrutturare socialmente e culturalmente la crescita tumultuosa delle nuove e vaste periferie della città industriale: con sezioni, case del popolo, parrocchie – luoghi che diventano la base di una capillare iniziativa di “patronato sociale”» (p. 23).
Nei centri industriali si ricrea un contrasto politico per molti versi affine alla contrapposizione agraria. Buona parte della politica urbana del Pci – Anderlini cita Giuseppe Campos Venuti, il più autorevole urbanista del Pci, protagonista di una delle stagioni più alte ed esemplari del “modello emiliano” – si svolge all’insegna della lotta alla rendita speculativa, secondo «un transito lineare quanto naturale della lotta alla rendita fondiaria dall’ambito rurale a quello urbano» (p. 24). Inoltre è significativo che nelle città di taglia piccola o media dell’Italia di mezzo e del Nord-est, il capitale sociale cooperativo portato in dote dalle sub-culture politiche di matrice agraria – tanto comunista quanto cattolica – innervi e favorisca lo sviluppo di fiorenti sistemi di piccola impresa, in una efficace fusione tra la dimensione urbano-industriale e i valori solidaristici e fiduciari del mondo rurale. «È il “territorio” che conforma la realtà “urbana”» (p. 25), secondo un processo storico nel quale la città trae gli alimenti culturali dalla terra, cioè dalla vicenda agraria, ritrasformandoli.
Nella periodizzazione di Anderlini la svolta epocale arriva più tardi. Essa si annuncia a partire dagli anni Ottanta, quando comincia a manifestarsi quello “sradicamento” della politica dalla terra e dal territorio che conduce fino all’esito degli anni Duemila: la “Repubblica dei detriti”, secondo l’efficace formula coniata dall’autore. A monte di tutto ciò stanno gli effetti indotti dalla globalizzazione sugli Stati nazionali, qui intesi come concentrato di autorità, territorio e diritti di cittadinanza e come naturale palcoscenico dei partiti di massa, i quali proprio all’interno della cornice nazionale avevano faticosamente conquistato, attraverso la ricerca del consenso, un ben preciso insediamento geografico e sociale.
Dello scenario apertosi negli ultimi due o tre decenni Anderlini individua (spesso in modo gustoso) imposture e paradossi: da una parte, il modello pseudo-carismatico e la sovra-esposizione mediatica delle singole personalità politiche non sono altro che la «parodia pubblicitaria di una funzione di rappresentanza andata perduta» (p. 39); mentre dall’altra parte la re-invenzione di un territorio/patria come centro motore di identità, propria della Lega Nord, viene derubricata dal sociologo bolognese a pura rappresentazione parodica «di qualcosa che è andato irreversibilmente perduto» (p. 45).
Un ulteriore passaggio – assai rivelatore dei mutamenti in atto, e brillantemente analizzato da Anderlini – si consuma con il recente successo del Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche del febbraio 2013. Il movimento di Grillo realizza, infatti, uno scardinamento quasi totale di quell’impianto territoriale che aveva resistito anche al passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. Per la prima volta nella realtà italiana si afferma una formazione politica la cui forza è equamente distribuita a livello nazionale, senza un prevalente insediamento regionale: si assiste cioè alla «dissoluzione dei cleavages» (p. 364) che erano stati emblematici della storia politica italiana. Ad esempio, pare rompersi la frontiera del Nord leghista-berlusconiano e, in maniera ancora più evidente, sciogliersi la tipicità elettorale del Nord-est. Votano M5S «i padroncini leghisti della marca veneta e trevigiana» come «la classe operaia di grande impresa investita dalla crisi» (Mirafiori), «i tarantini esasperati dall’Ilva» e «i siciliani disamorati del padrinato mafioso». La zona rossa centrale resiste solo a fatica, tanto da configurare una diarchia Pd/M5S, con il secondo a volte prevalente come in Liguria, nelle Marche e in parte del Piemonte. Ma anche gli emiliani e i toscani sono ormai in rotta con la civiltà (un tempo rispettata) della forma partito.
Per uscire dalla melma della Repubblica dei detriti l’unica strada percorribile, secondo Anderlini, è quella che passa per un grande “spazio partitico continentale”, per il rafforzamento cioè di grandi partiti europei; una dimensione nella quale la stessa sinistra (collocazione politica nella quale si riconosce l’autore) possa ritrovare la propria originaria vocazione internazionalista, fronteggiando in modo più efficace i condizionamenti della finanza globale. È facile notare, però, che anche in questo spazio politico allargato – a meno che non si privilegi una prospettiva dirigistica o tecnocratica – resterebbe comunque ineludibile il rapporto tra la dimensione continentale e quella regionale, tra l’Europa e i suoi territori.