1. Storiografia fluviale e categorie analitiche
La tesi [di The Organic Machine] è che il modo migliore per comprendere il fiume sia considerarlo come un’entità in costante mutamento. Gli esseri umani lo hanno gradualmente modificato, creando l’illusione di aver conquistato il fiume, trasformandolo, come si dice comunemente lungo la costa ovest del nord degli Stati Uniti, in una serie di laghi con acque stagnanti. Usiamo un linguaggio sociale per riferirci al fiume. Lo abbiamo violentato o ucciso; ma un linguaggio simile è fuorviante. Abbiamo cambiato il fiume Columbia, a scapito di alcune specie e a beneficio di altre. Dove un tempo il Columbia significava salmone, ora significa alosa e altri pesci di acqua dolce. Il Columbia non è morto [...]. Le dighe dipendono da ritmi naturali di scala maggiore, come le nevicate, lo scioglimento delle nevi, la pioggia, la gravità e le stagioni, ma abbiamo creato un sistema in cui ciò che è naturale e ciò che è umano diventano sempre più difficili da distinguere. Ogni sfera invade e influenza l’altra. Il fiume è diventato una macchina organica [White 1999, 221].
Con queste parole Richard White ricapitolava il messaggio centrale del proprio volume The Organic Machine: The Remaking of the Columbia River (Hill & Wang, 1996) e riprendeva uno dei dibattiti che in quel decennio avevano animato la storia ambientale, cioè la relazione tra natura e cultura. In sintesi, un fiume come oggetto storiografico andava sempre inteso come un sito di trasformazioni sia ecologiche che umane allo stesso tempo.
Il fiume Columbia, pur rimanendo caso studio seminale, condensa gli innumerevoli usi e significati presenti nella storiografia fluviale. Esso è stato usato come via di comunicazione; come fonte di irrigazione per le aziende agricole; come luogo di generazione di energia idroelettrica; come sito di produzione di cibo e come spazio ricreativo; come generatore di conflitti ideologici e dispute legali e dibattiti etici; come un esempio di natura manipolata e habitat per la fauna selvatica. Ha assunto un significato sociale per le comunità che da esso trovavano sostentamento; significato politico in quanto regolato da norme sui diritti di pesca, in particolare quella del salmone; un significato ecologico quando oggetto di studio sono diventate le sue forti correnti e passaggi impervi e disseminati di rocce [Cohen 2005, 448-449].
Facendo sintesi di usi e significati appena menzionati, la storiografia sui fiumi è stata tradizionalmente intesa come l’insieme delle ricostruzioni storiche che hanno indagato e interpretato, in primo luogo, le modalità in cui le comunità hanno vissuto lungo i fiumi e con i fiumi e, in secondo luogo, di come i fiumi sono stati percepiti e alterati dalle comunità [Warren 2003, 1]. Ma non tutte le storie si sono concentrate esclusivamente sui fattori antropici. Ad esempio, Ling Zhang nel suo The River, the Plain, and the State [Zhang 2016] ha guardato al fiume Giallo nella Cina settentrionale come a una entità poco controllabile dagli umani: lo ha considerato come un agente che non può essere ridotto all’interno di una analisi degli interventi e dei quadri interpretativi umani. La geografia storica, la storia ambientale, la storia della scienza e tecnologia, più recentemente, le Environmental Humanities sono gli ambiti disciplinari che maggiormente hanno elaborato storie fluviali.
Sintesi storiografiche hanno individuato categorie analitiche comuni. Ad esempio, Paula Schönach [Schönach 2017, 240-252] e Etienne Benson [Benson 2024, 4-7] segnalano diversi elementi chiave da tenere in considerazione quando si scrivono storie fluviali.
• La dimensione spaziale, che si articola in due modi. Da un lato, il fiume svolge un ruolo di connettore: esso trasporta persone, merci e idee, ma anche sostanze inquinanti o non desiderate. E in quest’ultimo caso il fiume diventa manifestazione delle trasformazioni antropiche avvenute lungo le proprie sponde. Inoltre, molte storie di fiume mettono in relazione comunità a monte e a valle oppure città e campagne. Dall’altro lato, i fiumi hanno rappresentato barriere fisiche che le società hanno superato attraverso la realizzazione di ponti e tunnel. O, ancora, arte e letteratura hanno dato ampio spazio a corsi d’acqua non praticabili perché soggetti a congelamento o – come successo nelle ultime stagioni estive – prosciugamento. Infine, fiumi che attraversano vari stati sono stati protagonisti di relazioni diplomatiche e negoziazioni sull’uso non nazionalistico delle risorse idriche [Schenk 2020].
• I rapporti di potere, generati dalla consapevolezza che «l’acqua è politica, le acque fluviali sono politiche e le interazioni umani-fiumi sono politiche» [Schönach 2017, 244; Rethinking the Entangled History 2022]. I fiumi entrano nell’arena politica in tre modi: l’agency del corso d’acqua – inteso nelle sue caratteristiche fisiche – ha la capacità di influenzare le decisioni umane; l’uso umano intenzionale della tecnologia, nel suo significato più ampio, modifica la conformazione e le funzioni di un fiume e lo rende un soggetto ibrido culturale e naturale insieme; i fiumi, le relative gestione e risorse sono spazi contesi tra gruppi sociali diversi.
• La sovrapposizione e la compenetrazione di diverse temporalità. Le storie di fiumi presentano una stratificazione di tempi naturali – maree e cambiamenti stagionali, eventi sporadici o ciclici come nei casi di siccità e alluvioni – e tempi delle trasformazioni umane – progetti legati ai processi di modernizzazione (la “conquista” di un fiume) e effetti del degrado ambientale che possono anche, ma non necessariamente, richiedere tempi più lunghi e portare alla “morte” biologica di un fiume.
• La comprensione di un fiume come sistema in cui convergono economie, società, strutture politiche e, in particolare, infrastrutture tecnologiche e che va interpretato attraverso categorie delle scienze naturali, dei saperi tecnici e delle discipline umanistiche. Questa lettura del fiume come sistema ibrido dove ambiente e tecnologia si fondono ritorna nelle analisi di storici e storiche che lavorano all’intersezione tra storia ambientale e storia della tecnologia.
Come la storiografia ambientale in generale, anche le storie fluviali di età contemporanea hanno messo al centro della propria analisi i progetti e le alterazioni dei bacini dei fiumi all’interno di processi di modernizzazione sia economica – attraverso l’industrializzazione – che politica – quale la costruzione dello stato-nazione [Bonan 2019, 319-323]. Il legame tra fiumi e programmi di regimentazione delle acque, di cui le dighe sono l’esempio più emblematico, è entrato in crisi negli anni Settanta. Infatti, sul finire del decennio il tasso di costruzione di nuove dighe del mondo è diminuito, soprattutto in Nord America e in Europa. Al contempo, vale la pena menzionare due faraonici progetti di produzione di energia idroelettrica ideati e costruiti negli ultimi cinquanta anni: la diga delle Tre Gole sul fiume Giallo in Cina e la diga di Balbina sul fiume Uatumã nella foresta Amazzonica [Mauch, Zeller, 2008, 4-5; Johnson 2024, 203-241; Ding 2024].
2. Il ruolo dei fiumi nel dibattito storiografico italiano di età contemporanea
In Italia, a fronte di una storiografia sulle acque di grande rilievo e in continua evoluzione, i fiumi sono rimasti meno indagati soprattutto in età contemporanea. La letteratura prodotta, però, permette di osservare sia un allineamento alle tematiche del dibattito internazionale che l’emergere di temi peculiari al contesto italiano.
In primo luogo, vale la pena notare che non solo i “grandi” fiumi sono stati oggetto di ricerche. Anzi, guardando agli estremi cronologici del dibattito storiografico ambientale italiano si nota la centralità dei fiumi “minori” nel comprendere le dinamiche di modernizzazione economica e politica menzionate in precedenza. Sono il fiume Liri e il suo affluente Fibreno che offrono a Stefania Barca in Enclosing Water [Barca 2010] l’opportunità di entrare nel processo di industrializzazione del Regno delle Due Sicilie prima e del Regno d’Italia poi attraverso l’analisi della valle del Liri, un’area appenninica dell’Italia centrale, tra il 1796 e il 1916. Così come è il fiume Toce, in contesto alpino, a permettere a Sebastian De Pretto di esplorare le relazioni di potere tra centro e periferia durante il fascismo e le relative conseguenze. Il progetto di produzione idroelettrica in Piemonte iniziato negli anni Venti non solo serve a mettere in evidenza la logica estrattivista fascista nei confronti delle regioni alpine, ma anche l’incapacità degli interventi post-1945 nel ridurre l’eredità in termini di disuguaglianze socio-economiche e squilibri territoriali di tale modello [De Pretto 2025].
In secondo luogo, non tutte le aree della penisola sono egualmente rappresentate e per spiegare questo squilibrio si possono ipotizzare tre motivazioni. In parte deriva dalle differenze idrografiche tra Nord e Sud. Come mostra la storia ambientale, i fattori fisici non possono essere ignorati e quindi, pur nella consapevolezza che molti dei corsi d’acqua del Mezzogiorno rimanevano – e rimangono – spesso secchi nei mesi estivi [Bonatesta 2023, 6], ciò non basta a giustificare le poche ricerche sulle acque superficiali nel Sud. Una apertura interdisciplinare sta dando, per esempio, nuova centralità ai fiumi siciliani [The Nature of Mafia 2020; Pappalardo 2021; Gruppuso, Garozzo 2025]. In parte la rilevanza del Nord-Est, in particolare i fiumi Adige e Piave, e del delta del Po è spiegata dall’importanza storica di alcuni territori per lo sviluppo di una legislazione sul regime idrogeologico nazionale e sui piani di bonifica e protezione dalle alluvioni [Vallerani 2013; Biasillo, Armiero 2019; Bonan 2000; Agostini, Raito 2021; Bonan 2025]. Il valore simbolico e culturale attribuito ad alcuni fiumi, in primis Piave e Po, ha contribuito a rafforzare questo squilibrio [Minniti 2015; Peterle, Visentin 2017; Manera 2017].
Infine, un aspetto che connette dibattito internazionale e peculiarità della storia ambientale italiana è la stretta relazione tra fiumi e questione urbana. I programmi di risanamento, sbancamento e costruzione di nuovi quartieri e argini originati dalle teorie igieniste e dalla necessità di proteggere i centri urbani dalle alluvioni hanno riguardato molte delle principali città italiane attraversate da fiumi. Nel periodo postunitario, a partire dall’epidemia di colera nel 1865 e dal piano regolatore del 1889, a Bologna si avviarono i lavori di copertura dei canali del Reno. Tale approccio alle acque urbane, non esclusivo di Bologna, fu ribadito durante il Ventennio e ancora nel 1957 ci furono coperture di canali [Zanotti 2000]. Negli stessi anni, quando Roma diventava capitale del Regno venne colpita da una alluvione che diede il via a un lungo dibattito sulla necessità di difendere la città dal fiume che portò alla costruzione di altissimi muraglioni lungo il corso del Tevere nei decenni a seguire [Giannetti, Casini 2022; Valenti 2023]. Firenze e il suo rapporto con l’Arno, invece, aprono allo studio dell’alterazione del rapporto tra risorse e spazio urbano in età repubblicana, in cui l’alluvione del novembre 1966 ha rappresentato un momento chiave. Le conseguenze di urbanizzazione e industrializzazione in Toscana hanno incrementato la necessità di infrastrutturazione del fiume, subordinando una gestione delle acque secondo principi ecologici alle esigenze della espansione urbana [Paolini 2020, 49-62]. Se gli studi di storia ambientale in età contemporanea hanno riflettuto sulla rottura del metabolismo tra fiumi e spazio urbano attraverso l’introduzione di argini, canalizzazioni, interramenti e deviazioni, uno sguardo di natura interdisciplinare ha negli ultimi anni ridiscusso il carattere fluido delle nostre città. Un esempio fra tutti è il caso di Milano: muovendo da una critica alla comprensione della modernità urbana come separazione fisica e mentale tra ambiente naturale e ambiente costruito, Serena Ferrando [Ferrando 2014] ricostruisce il legame intimo tra milanesi e Navigli.
3. Gli studi sul Po
Il Po, pur essendo il più importante fiume italiano sia per lunghezza di corso (652 km) sia per ampiezza di bacino (74.970 km2), non ha ad oggi occupato un ruolo di rilievo nella storiografia fluviale e ambientale italiana di età contemporanea. La maggior parte degli studi sul Po hanno riguardato le epoche precedenti [Cazzola 1979; Gambi, Ferrari 2000; Adattabilità antropica 2021]. Per quel che attiene l’età moderna, la recente opera di Franco Cazzola, Uomini e fiumi [Cazzola 2021], ha ricostruito con accuratezza la storia idraulica e agraria della bassa pianura padana, concentrandosi sul governo delle acque, la gestione del territorio e i conflitti di potere tra XV e XVII secolo nelle province venete ed emiliano-romagnole. Il volume di Cazzola ha anche confermato una tendenza a congiungere la storia delle acque a quella delle terre circostanti. Come sintetizzato da Matteo Di Tullio [Di Tullio 2022], il «lungo percorso di bonifica utile all’insediamento e allo sfruttamento agricolo della valle del Po è il fil rouge attorno al quale si dipanano i tanti esempi e le tante esperienze di lavoro, governo, disputa e cooperazione». Secoli di storia di relazioni complesse che hanno fatto sì che il Po diventasse «il fiume maggiormente antropizzato d’Italia, morfologicamente ed ecologicamente» [Coates 2013, 123].
Nel periodo tra età moderna e contemporanea il dibattito storiografico ha continuato lungo questi assi tematici. Alcuni contributi sono stati rivolti alla lunga storia della bonifica, tra fine Settecento e la prima metà del Novecento, delle aree del delta del Po e delle rive del Reno prestando attenzione allo sviluppo del capitalismo agrario e alle lotte agrarie, al ruolo dei consorzi e al credito agrario, all’uso politico delle opere pubbliche da parte, in particolare, del regime fascista, ai (falliti) tentativi di sfruttare il bacino fluviale del Po per la navigazione commerciale a servizio dell’industrializzazione e alle trasformazioni del suolo nelle aree coinvolte [Isenburg 1971; Menzani 2008; Proto 2011; Menzani, Troilo 2016].
La storia postunitaria del principale fiume nazionale non è stata, tuttavia, solo storia di usi agricoli. A partire dal XIX secolo il bacino idrogeologico del Po, con la sua rete di affluenti e canali compresi tra le Alpi e l’Appennino, sino al suo delta, è stato uno dei principali scenari dei fenomeni di industrializzazione del Nord del paese, anche grazie al crescente uso delle sue acque per la produzione di energia elettrica. Le trasformazioni tecnologiche e le forme assunte dallo sfruttamento delle fonti idriche delinearono nuove strutture economiche e geografie di potere, rendendo nel corso del Novecento il bacino del Po il principale polo di produzione di energia idroelettrica del paese, con la partecipazione di una pluralità di interessi e capitali privati che sarebbe stata ridimensionata solo dopo la nascita dell’Enel nel 1962 [Parrinello 2018].
Le pressioni ambientali derivanti dall’elevata concentrazione di attività lungo il fiume Po e l’inquinamento crescente del suo bacino hanno alterato la qualità delle acque fino a far emergere emergenze ambientali negli ultimi cinquanta anni. Eppure la necessità di depurazione e bonifica, vitale per l’attività di pesca, non ha prodotto una mobilitazione della popolazione locale. La letteratura sulla giustizia ambientale ha interpretato il Po come un terreno di «conflitto blando» che si è espresso tramite strategie legali e mediatiche. In particolare, una delle recenti vertenze ambientali ha trovato una soluzione grazie all’intervento dell’Unione europea, che nel 2004 ha costretto la città di Milano ad applicare la direttiva 91/271/Cee del 1991 sul trattamento delle acque reflue urbane, in seguito a paventate sanzioni di 150 mila euro al giorno fino all’avvenuta costruzione degli adeguati sistemi di depurazione. Due fattori hanno «depotenziato il conflitto»: la costruzione dei depuratori, che però ha dato vita a una nuova problematica – quale la produzione di fanghi da depurazione, ricchi di metalli pesanti –; la complessità del sistema di governance con un alto numero di attori privati e istituzionali coinvolti e la difficoltà di individuare responsabili chiari nei fenomeni di contaminazione [Carrosio 2013, 83-84].
L’area del grande delta del Po, in particolare dopo la nascita del parco nel 1988, è progressivamente divenuta, oltre che meta di flussi turistici, oggetto di sempre più approfonditi studi. Recentemente in particolare, ma non esclusivamente, intorno all’area deltizia si sono sviluppate numerose riflessioni sull’antropocene, a causa dei fenomeni di innalzamento delle acque marine che stanno destando particolari preoccupazioni, generate dall’interazione tra elemento umano ed elemento geo-morfologico, approfondendo così la questione del rapporto umani-ambiente [Parrinello, Bizzi, Surian 2021; Marchetti 2002].
L’interesse per il Po non è d’altronde mai stata un’esclusiva prerogativa di specialisti. La fascinazione letteraria, culinaria, fotografica e cinematografica per il “grande fiume” affonda in una lunga storia culturale [Coates 2013, 133-146], che da Il Mulino del Po di Riccardo Bacchelli (1957) passa per Ossessione di Luchino Visconti (1943), sino agli argini, ai canali e ai campi immortalati da Luigi Ghirri. Ancora nell’ultimo decennio nuovi racconti si sono affiancati ai precedenti da parte di autori italiani e internazionali, in una letteratura, talora di viaggio, intesa a valorizzare la cultura prodotta sul Po e intorno al Po, la costruzione di memorie individuali e collettive e a restituire la complessità dei rapporti tra il fiume e gli abitanti della sua pianura [tra gli altri, Zamboni, Brondi 2016; Conti 2020; Jones 2024; Wu Ming 1, 2024].
Lo scopo di questo dossier è quello di proporre riflessioni e saggi sulla storia del Po e delle acque in Emilia-Romagna in epoca contemporanea, arricchendo, senza alcuna pretesa di esaustività o completezza, il panorama degli studi. Affrontando alcuni aspetti relativi alla gestione del territorio, alle bonifiche, all’industrializzazione, alle rappresentazioni cinematografiche e letterarie, al rapporto tra uomini e fiume, si cercherà di dimostrare la rilevanza del “grande fiume” e del suo bacino nella storia italiana e internazionale del XX e XXI secolo.
Bibliografia
- Adattabilità antropica 2021
Michele Abballe, Daniele Bortoluzzi, Michele Cavalazzi, Stefano Marabini, Adattabilità antropica ed evoluzione dei sistemi fluviali nell’area del delta padano meridionale tra la tarda Età romana e l’inizio del Medioevo, in Storia e archeologia 1 (2021). Italia settentrionale e regioni dell’arco alpino tra V e VI sec. d.C., Atti del convegno (15-17 aprile 2021), Trieste, EUT-Edizioni Università di Trieste, 2021, pp. 13-32. - Agostini, Raito 2021
Polesine e acque nell’età moderna e contemporanea, a cura di Filiberto Agostini, Leonardo Raito, Milano, FrancoAngeli, 2021. - Barca 2010
Stefania Barca, Enclosing Water. Nature and Political Economy in a Mediterranean Valley, 1796-1916, Cambridge, The White Horse Press, 2010. - Benson 2024
Etienne Benson, Rivers in History: Systems, Agents, and Places, in Handbook of the Historiography of the Earth and Environmental Sciences. Historiographies of Science, a cura di Elena Aronova, David Sepkoski, Marco Tamborini, Cham, Springer, 2024, pp. 1-17. - Biasillo, Armiero 2019
Roberta Biasillo, Marco Armiero, The Transformative Potential of a Disaster: A Contextual Analysis of the 1882 Flood in Verona, Italy, in «Journal of Historical Geography», 66 (2019), pp. 69-80. - Bonan 2019
Giacomo Bonan, Riflessi sull’acqua. Ricerca storica e biografie fluviali, in «Contemporanea. Rivista di storia dell’800 e del ’900», XXII, 2 (2019), pp. 317-328. - Bonan 2020
Giacomo Bonan, Le acque agitate della patria: l’industrializzazione del Piave (1882-1966), Roma, Viella, 2020. - Bonan 2025
Giacomo Bonan, Old Woods, New Rule: The Annexation Of Veneto to the Kingdom of Italy from a Forest History Perspective, in «Modern Italy», 22 gennaio 2025, doi:10.1017/mit.2024.71. - Bonatesta 2023
Antonio Bonatesta, Acqua, Stato, nazione. Storia delle acque sotterranee in Italia dall’età liberale al fascismo, Roma, Donzelli, 2023. - Carrosio 2013
Giovanni Carrosio, Ingiustizia ambientale nel bacino del Po: il conflitto tra il Polesine e la città di Milano per l’inquinamento delle acque, in «Partecipazione e Conflitto», 6, 1 (2013), pp. 83-101. - Cazzola 1979
Franco Cazzola, Fiumi e lagune: le acque interne nella vita regionale, in Cultura popolare nell’Emilia Romagna. Mestieri della terra e delle acque, Milano, Silvana Editoriale, 1979, pp. 185-213. - Cazzola 2021
Franco Cazzola, Uomini e fiumi. Per una storia idraulica ed agraria della bassa pianura del Po (1450-1620), Roma, Viella, 2021. - Coates 2013
Peter Coates, A Story of Six Rivers: History, Culture and Ecology, London, Reaktion Books, 2013. - Cohen 2005
Benjamin R. Cohen, Escaping the False Binary of Nature and Culture through Connection: Richard White’s “The Organic Machine: The Remaking of the Columbia River”, in «Organization & Environment», 18, 4 (2005), pp. 445-447. - Conti 2020
Guido Conti, Il grande fiume Po, Firenze, Giunti, 2020. - De Pretto 2025
Sebastian De Pretto, From Cadarese to Morasco: The Creation of a Fascist Hydroscape in Alpine Space after 1928, in «Modern Italy», 30, 1 (febbraio 2025) pp. 39-55. - Di Tullio 2022
Matteo Di Tullio, Recensione a Franco Cazzola, Uomini e fiumi. Per una storia idraulica ed agraria della bassa pianura del Po (1450-1620), Roma, Viella, 2021, in «ARO», 2 (2022), https://aro-isig.fbk.eu/issues/2022/2/uomini-e-fiumi-matteo-di-tullio/. - Ding 2024
Xiangli Ding, Hydropower Nation: Dams, Energy, and Political Changes in Twentieth-Century China, Cambridge, Cambridge University Press, 2024. - Ferrando 2014
Serena Ferrando, Water in Milan: A Cultural History of the Naviglio, in «ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment», 21, 2 (2014), pp. 374-393. - Gambi, Ferrari 2000
Un Po di terra: guida all’ambiente della bassa Pianura padana e alla sua storia, a cura di Lucio Gambi, Carlo Ferrari, Reggio Emilia, Diabasis, 2000. - Giannetti, Casini 2022
Ilaria Giannetti, Francesca Casini, The Construction and the Collapse of the Tiber Retaining Walls in Rome, Italy (1870-1900), in «Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Engineering History and Heritage», 175, 2 (2022), pp. 48-58. - Gruppuso, Garozzo 2025
Paolo Gruppuso, Erika Garozzo, Walking a Sicilian River, in «Springs: The Rachel Carson Center Review», 7, 2025, https://doi.org/10.5282/rcc-springs-15268. - Isenburg 1971
Teresa Isenburg, Investimenti di capitale e organizzazione di classe nelle bonifiche ferraresi (1872-1901), Firenze, La Nuova Italia, 1971. - Johnson 2024
Matthew P. Jonnson, Hydropower in Authoritarian Brazil: An Environmental History of Low-Carbon Energy, 1960s-90s, Cambridge, Cambridge University Press, 2024. - Jones 2024
Tobias Jones, Il Po. Viaggio lungo il grande fiume, Milano, Mondadori, 2024. - Manera 2017
Enrico Manera, Mitologie padane. Dall’ampolla del Po a Capitan Padania, in «Novecento.org», 8 (2017), https://www.novecento.org/dossier/italia-didattica/mitologie-padane-dallampolla-del-po-a-capitan-padania/. - Marchetti 2002
Mauro Marchetti, Environmental Changes in the Central Po Plain (Northern Italy) Due to Fluvial Modifications and Anthropogenic Activities, in «Geomorphology», 44, 3-4 (2002), pp. 361-373. - Mauch Zeller 2008
Christof Mauch, Thomas Zeller, Rivers in History and Historiography: An Introduction, in Christof Mauch, Thomas Zeller, Rivers in History. Perspectives on Waterways in Europe and North America, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2008, pp. 1-10. - Menzani 2008
Tito Menzani, Le bonifiche in Romagna. La realizzazione del canale in destra di Reno (sec. XVIII-XX), Imola, Editrice La Mandragora, 2008. - Menzani, Troilo 2016
Tito Menzani, Matteo Troilo, Carte d’acqua. Le mappe della bonifica in Romagna, secc. XVIII-XXI, Faenza, Edit Faenza, 2016. - Minniti 2015
Fortunato Minniti, Il Piave, Bologna, il Mulino, 2015. - Paolini 2020
Federico Paolini, Environment and Urbanization in Modern Italy, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2020. - Pappalardo 2021
Giusy Pappalardo, Paesaggi tenaci: il processo ecomuseale del Simeto, Milano, FrancoAngeli, 2021. - Parrinello 2018
Giacomo Parrinello, Systems of Power: A Spatial Envirotechnical Approach to Water Power and Industrialization in the Po Valley of Italy, ca.1880–1970, in «Technology and Culture», 59, 3 (2018), pp. 652-688. - Parrinello, Bizzi, Surian 2021
Giacomo Parrinello, Simone Bizzi, Nicola Surian, The Retreat of the Delta: A Geomorphological History of the Po River Basin during the Twentieth Century, in «Water History», 13, 2021, pp. 117–136. - Peterle, Visentin 2017
Giada Peterle, Francesco Visentin, Performing the Literary Map: ‘Towards the River Mouth’ following Gianni Celati, in «Cultural Geographies», 24, 3 (2017), pp. 473-485. - Proto 2011
Matteo Proto, Le utopie fluviali nell’Italia contemporanea. La navigazione padana e l’idrovia Padova-Venezia, Bologna, Clueb, 2011. - Rethinking the Entangled History 2022
Giacomo Parrinello, Simone Neri Serneri, Debjani Bhattacharyya, Ruth A. Morgan, Corey Ross, David Pietz, Matthew Evenden, Rethinking the Entangled History of Water and Power, in «Contemporanea. Rivista di storia dell’800 e del ’900», 2 (2022), pp. 319-344. - Schenk 2020
Joep Schenk, The Rhine and European Security in the Long Nineteenth Century: Making Lifelines from Frontlines, London, Routledge, 2020. - Schönach 2017
Paula Schönach, River Histories: A Thematic Review, in «Water History», 9, 2017, pp. 233-257. - The Nature of Mafia 2020
Marco Armiero, Filippo Gravagno, Giusy Pappalardo, Alessia Denise Ferrara, The Nature of Mafia: An Environmental History of the Simeto River Basin, Sicily, in «Environment and History», 26 (2020), pp. 579-608. - Valenti 2023
Salvatore Valenti, Water in the Making of a Socio-Natural Landscape Rome and Its Surroundings, 1870-1922, London, Routledge, 2023. - Vallerani 2013
Veneto d’acque, a cura di Francesco Vallerani, numero monografico, in «Venetica», 28 (2013). - Warren 2003
Louis S. Warren, Introduction, in American Environmental History, a cura di Louis S. Warren, Malden, Blackwell, 2003, pp. 1-4. - White 1999
Richard White, The Problem with Purity. The Tanner Lectures on Human Values Delivered at the University of California, Davis, May 10, 1999, https://tannerlectures.org/wp-content/uploads/sites/105/2024/07/white00.pdf. - Wu Ming 1 2024
Wu Ming 1, Gli uomini pesce, Torino, Einaudi, 2024. - Zamboni, Brondi 2016
Massimo Zamboni, Vasco Brondi, Anime galleggianti. Dalla pianura al mare tagliando per i campi, Milano, La Nave di Teseo, 2016. - Zanotti 2000
Angelo Zanotti, Il sistema delle acque a Bologna dal XIII al XIX secolo, Bologna, Editrice Compositori, 2000. - Zhang 2016
Ling Zhang, The River, the Plain, and the State: An Environmental Drama in Northern Song China, 1048-1128, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.
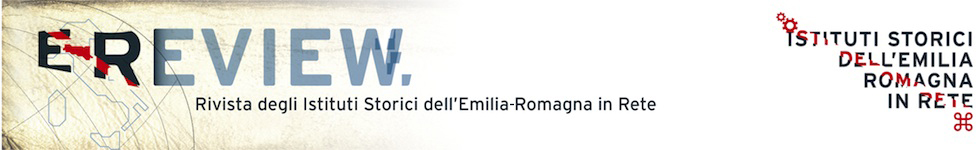
![Fig. 1. Servizio fotografico, Italia, 1974, Paolo Monti [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paolo_Monti_-_Servizio_fotografico_(Italia,_1974)_-_BEIC_6328957.jpg].](./sites/default/images/articles/media/328/intro_2025_01.jpg)



