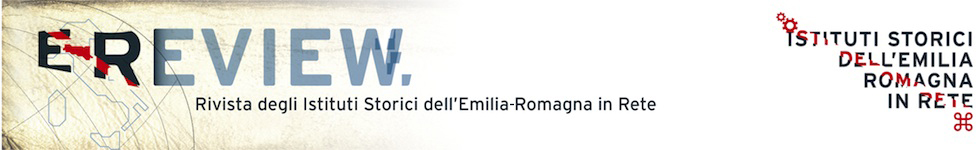1. Visitare i campi di battaglia: un fenomeno del percorso di “nation building”
Il ritorno dei reduci sui luoghi della Grande guerra o più semplicemente la visita a questi di chi non vi aveva preso parte fu un passo fondamentale del percorso di rielaborazione delle profonde ferite piscologiche che il primo conflitto mondiale aveva lasciato. Fu un fenomeno che spesso ebbe un carattere di massa, quasi fosse un passaggio obbligato nel percorso educativo delle folle e dei “nuovi italiani” emersi, se non addirittura “forgiati”, come diceva il linguaggio retorico del regime fascista, nelle trincee.
Occorre però fare un breve passo indietro. La visita ai campi di battaglia è un fenomeno che non nasce affatto con la Grande guerra. La spettacolarizzazione della guerra fiorisce in pieno nel secolo antecedente al primo conflitto mondiale. Vedere la guerra, o quantomeno i luoghi in cui si era combattuto, fu una prassi comune nel corso dell’Ottocento. Non a caso Tolstoj nel suo capolavoro Guerra e pace colloca Pierre Bezuchov sul campo di battaglia di Borodino nel 1812, alle porte di Mosca. Parallelamente Victor Hugo comincia la propria narrazione de I miserabili con la rievocazione della battaglia di Waterloo attraverso una sua visita al campo di battaglia nel 1861.
La guerra era diventata uno spettacolo alla portata di tutti. Durante le prime fasi della Guerra civile americana, in particolar modo durante il primo grande scontro del conflitto, la battaglia di Bull Run combattuta a breve distanza da Washington, furono molti gli “spettatori” che assistettero ai combattimenti, spesso addirittura travolti dall’inaspettato cedimento della linea difensiva di uno dei due eserciti contendenti.
Era indubbio che oltre alla naturale curiosità verso la guerra tipica degli ultimi strascichi del Romanticismo, una guerra che ovviamente non aveva ancora assunto quel carattere totalizzante tipico del Novecento, dietro alla visita dei campi di battaglia c’era molto di più. Il mito delle nazioni, nato nell’Ottocento, come spiega magistralmente Patrick Geary nel suo studio, Il mito delle nazioni su questo fenomeno, doveva assolutamente far percepire la presenza di una nazione sulla propria popolazione. Parte fondante di questo percorso era, senza alcun dubbio, la possibilità di accomunare persone dalle caratteristiche più disparate attraverso una comunanza linguistica e soprattutto storica. Vivere una storia comune e possedere le stesse basi storiche era un punto focale di questa strategia di “nation building” intrapreso dalle nazioni mondiali in particolar modo nella seconda metà del XIX secolo. Fu compito dei rispettivi storici costruire queste basi comuni andando a scavare, addirittura, fin nell’antichità, creando spesso un artefatto che non aveva fondamenti reali ed oggettivi. Ma non era solo nell’antichità che andavano scovate le radici comuni delle nazioni europee. Gli stessi avvenimenti che si stavano svolgendo nel corso di questi decenni di lavoro di costruzione di identità nazionale e dei rispettivi nazionalismi potevano essere piegati e strumentalizzati a tal scopo, tramutandoli in tappe fondamentali di un percorso che proveniva da molto lontano.
La “giovane” Italia, nata proprio nella fornace incandescente dell’Ottocento, ebbe a sperimentare in maniera tangibile e forte questa necessità di costruire la credibilità della propria nazione attraverso una storia comune e condivisa. Per quanto potesse sembrare semplice, in particolar modo grazie agli ovvi riferimenti all’Impero romano, era sul presente che l’Italia difettava di unità di intenti nel proprio percorso di “nation building”. La forte cesura rappresentata dalla “guerra per il sud” che aveva dilaniato il paese per oltre un decennio aveva causato ferite importanti all’interno di questo percorso che ancora oggi, tramite ridicole recrudescenze di neo borbonismo, si ripresenta saltuariamente. Il Risorgimento fu la base di partenza di questo graduale, e spesso coatto, processo di formazione di una identità nazionale italiana. Per “educare la nuova” Italia alla propria storia, già subito dopo l’Unità si cominciarono ad erigere monumenti, ossari e ad invitare le scolaresche, i curiosi e i semplici cittadini ad avvicinarsi ai campi di battaglia per rivivere, commemorare e instillare anche nelle menti più semplici il concetto che in quei luoghi “si era fatta l’Italia”. Fiorirono così lungo tutto lo stivale luoghi del ricordo, sacri alla patria. Per anni, fino addirittura al secondo dopoguerra, non mancava mai nelle uscite scolastiche delle classi elementari e medie la visita ad uno di questi luoghi, da Solferino a Redipuglia: una prassi oramai quasi del tutto abbandonata ai giorni nostri ma che ha caratterizzato il percorso di scolarizzazione di diverse generazioni di giovani italiani. Accanto ai grandi ossari, come quelli di Solferino e Custoza, nascevano luoghi di ristoro, musei, alberghi, percorsi tematici che conobbero, negli anni, periodi di grande afflusso. In particolar modo a Solferino, o per meglio dire a San Martino, l’angolo settentrionale del grande campo di battaglia dove si consumò in modo specifico lo scontro fra i piemontesi e gli austriaci, fu costruita la grande torre monumentale ancor oggi visitabile. Tramite un percorso elicoidale all’interno dell’edificio si può ammirare un unico grande affresco murario che celebra solennemente l’intera epoca risorgimentale, dalla Prima guerra d’indipendenza (1848) alla presa di Roma (1870).
L’immagine che ne scaturisce è di potenza, legata soprattutto alla casa regnante dei Savoia, i cui appartenenti erano rappresentati come i padri della patria e i fautori del percorso di unificazione nazionale.
Le guerre di indipendenza oggettivamente avevano coinvolto attivamente una porzione ristretta della popolazione e avevano caratterizzato, in particolar modo, solo una piccola parte del territorio nazionale: ad esclusione dell’ossario di Calatafimi in Sicilia e di quello di Castelfidardo, non lontano dal quale troneggia una enorme statua bronzea di Enrico Cialdini, non esistono a sud del Po, nemmeno sul campo di battaglia del Volturno, lo scontro più grande sostenuto dall’armata garibaldina nel risalire la Penisola, luoghi “sacri alla patria” come quelli presenti nel nord.
Solo la Grande guerra allargò notevolmente questo fenomeno a tutta la nazione italiana. La dimensione degli eserciti coinvolti portò ogni singola famiglia italiana ad avere un padre, un figlio, un fratello o un marito al fronte. Una guerra totalizzante che portò il lutto o la disgrazia del ritorno di un soldato ferito o mutilato nella casa di milioni di italiani. Fu così che, a fianco del prosieguo del percorso di “nation building” attraverso il già consolidato processo di avvicinamento e di familiarizzazione degli italiani ai campi di battaglia, urgeva la costruzione di un nuovo percorso strutturato che permettesse alla popolazione l’assorbimento e l’accettazione dell’estrema violenza di questa nuova guerra che aveva violato la dimensione intima e sociale di ogni famiglia italiana.
A fianco quindi della glorificazione di quella che fu interpretata come la “quarta guerra di indipendenza”, tappa necessaria del completamento dell’unità nazionale intrapreso, come oramai doveva essere noto agli italiani, con le battaglie del 1848, nacque quindi il cosiddetto “mito dei caduti”, un fenomeno che aveva solo fatto capolino all’interno dell’educazione italiana alla storia militare nazionale attraverso pochi famosi esempi: Pietro Micca, Giovan Battista Perasso detto Balilla, i fratelli Bandiera, Carlo Pisacane e i suoi 300 “giovani e forti” di Sapri, Ciro Menotti, Silvio Pellico, i martiri di Belfiore, Ippolito Nievo e tanti altri. Serviva ora una mitizzazione mirata che comprendesse tutti i caduti e che potesse toccare nell’intimo ogni singola famiglia italiana che aveva sofferto per la perdita di un caduto in guerra: un fenomeno ben più vasto che necessitava di un perfetto funzionamento per coinvolgere ed appagare chi era stato travolto dalla tragedia.
Fu così che al percorso di “nation building” si affiancò quello della costruzione del mito dei caduti, andandosi presto a fondere in un unicum fortissimo amplificato ed irrobustito dalla propaganda nazionale e nazionalista del regime fascista che creò a tavolino un riuscitissimo processo di legittimazione attraverso la celebrazione, l’esaltazione e, al contempo, la commemorazione dei caduti della Grande guerra.
Tutti questi fenomeni culturali che si avviarono già negli anni stessi del conflitto sfociarono in un vero e proprio processo di costruzione di memoria storica, edificazione di sacrari e di aree sacre, del quale il pellegrinaggio al cosiddetto campo di battaglia era parte fondamentale.
2. Reduci e campi di battaglia: esempi emiliano-romagnoli e non
I primi a ritornare sui campi di battaglia furono senza alcun dubbio i reduci. Questo fenomeno prese vita negli anni immediatamente successivi alla fine del conflitto, quando ancora la “bonifica” dei residuati bellici ed il recupero di quanto poteva risultare riutilizzabile non erano ancora stati compiuti del tutto. In particolare non era ancora stato avviato quel vasto programma di riordino dei cimiteri di guerra, dai più piccoli ai più grandi, e la costruzione dei grandi sacrari che avvenne solamente negli anni Trenta.
Sono molte le tracce bibliografiche sul fenomeno di “ritorno” dei reduci della Grande guerra ai luoghi dove si era combattuto. Addirittura un autore di memorie, il marchigiano Luigi Bartolini, famoso incisore nel dopoguerra, redasse i propri ricordi di combattente come osservatore di artiglieria sul Basso Isonzo attraverso il proprio viaggio, nel 1930, sui luoghi dove aveva vissuto la propria esperienza di guerra. Questo libro, il noto Ritorno sul Carso, edito per i tipi della Mondadori, è un punto di riferimento alquanto significativo per quanto riguarda la tematica dei pellegrinaggi dei reduci ai vecchi campi di battaglia: il Basso Isonzo stava tornando a vivere, la popolazione era rientrata ai propri paesi rimpossessandosi del terreno sconvolto dalla guerra e, per certi versi, creando un piccolo business attorno a questo nuovo turismo di guerra. Qualcuno addirittura provò ad approfittare della mancanza di validi mezzi pubblici in loco per lucrare un po’ di denaro:
In piazza, cercai una automobile la quale passo, passo, come camminando, m’avesse portato in su, fermandosi magari un quarto d’ora per ciascuno dei luoghi da me indicati. […] Lo chauffeur mi domandò una cifra favolosa e, alle mie obiezioni, rispose che non eravamo mica a Roma, e le tariffe erano quelle che erano per i viaggiatori del Carso! Gli obiettai che, in altri tempi, ci portarono gratis in su, né si fece questione di prezzo. […] Ma egli […] disse che faticava soltanto quando era ben pagato e che tanto voleva di tariffa ecc… ecc… Mi rivolsi, allora, a un fiaccheraio, un buon uomo che non disse di no; anzi, contrattammo per una settantina di lire il viaggio completo fino a Castagnevizza [Bartolini 1930].
Il caso del libro di Bartolini è alquanto anomalo ed esemplare. Vi sono testimonianze anche illustri su questo ritorno sulla linea del fronte. Una di queste è senza dubbio quella di Carlo Salsa, autore di uno dei libri più noti e letti sulla Grande guerra, Trincee. Nell’edizione del 1924, la quarta della sua opera, sempre per la casa editrice Sonzogno, l’ultimo dei 13 capitoli di cui è composto il libro, intitolato Commemorazione, racconta proprio di un viaggio dell’autore sui luoghi del Medio Isonzo in cui combatté: monte Mrzli, monte Vodil, testa di ponte di Tolmino… Salsa non è solo: è con Giubo, uno dei suoi commilitoni, collega ufficiale nel 68° reggimento fanteria della brigata Palermo, con cui condivise la maggior parte della sua guerra combattuta. In questo suo ritorno sull’Isonzo, dieci anni dopo la guerra, Salsa e il suo commilitone visitano in particolar modo i cimiteri di guerra, alla ricerca delle sepolture dei compagni caduti. È qui che si imbattono nel padre anziano di uno dei loro soldati, inginocchiato davanti ad una tomba ignota di uno dei cimiteri di guerra del monte Mrzli, simbolicamente, per ricordare il figlio disperso in guerra proprio su quel tratto di fronte. Salsa decide di concludere così il proprio libro, con questo incontro straziante. Nelle edizioni del secondo dopoguerra, misteriosamente, questo capitolo viene stralciato dal libro.
Salsa mette alla luce una delle motivazioni principali che spinsero questi reduci a tornare sui luoghi di guerra: il ricordo della memoria dei compagni caduti, fatto nel silenzio della propria intimità e non nella pomposità celebrativa della macchina propagandistica del regime fascista che si era impossessato della liturgia della memoria dei caduti e ne aveva fatto uno dei propri cavalli di battaglia, come vedremo fra breve. Spesso questi viaggi della memoria avevano proprio come scopo quello di cercare sepolture o addirittura cadaveri ancora dispersi sul campo di battaglia per dare dignità e una tomba a un combattente di cui si erano perse le tracce. È il caso di Giani Stuparich, triestino di nascita e quindi suddito dell’Impero austro-ungarico, irredentista convinto, volontario, assieme al fratello Carlo nel regio esercito italiano. Giani Stuparich dedicò molti infruttuosi ritorni sull’Altipiano di Asiago, nella zona del monte Cengio, per cercare il corpo del fratello Carlo, caduto il 30 maggio 1916, al culmine dell’offensiva austro-ungarica detta Strafexpedition che, partendo dalle Prealpi venete, mirava alla Pianura Padana. Solo nel maggio 1919, grazie all’aiuto del cappellano militare don Michele Massa, Stuparich poté ritrovare il corpo del fratello, sepolto frettolosamente dagli austriaci che ne avevano trovato le spoglie e dargli una sepoltura dignitosa e nominale. Ma i pellegrinaggi di Giani Stuparich verso l’Altipiano non erano certo finiti. Spinto dal ricordo e dalla volontà di commemorare il fratello caduto, anno dopo anno, anche nel secondo dopoguerra, questi tornava sistematicamente là, su quei luoghi. Egli stesso ne scrisse su “Il Tempo” il 6 marzo 1960:
I miei pellegrinaggi ai campi di battaglia della prima grande guerra si sono in questi ultimi anni diradati. Ma prima che scoppiasse la seconda guerra mondiale io mi recavo quasi tutti gli anni, nel maggio, sull’Altipiano di Asiago. Su quell’altipiano dove avevamo combattuto, mio fratello Carlo ed io, nel maggio 1916 e dove mio fratello era caduto. Se c’è un’impressione fondamentale che mi sia rimasta di quelle mie visite, è questa: tra il variare delle abitazioni, degli uomini, della rete stradale una cosa rimaneva sempre la stessa: la natura. E questa natura aveva la capacità di farmi rivivere subito quell’atmosfera del 1916, anche se da allora erano passate diecine d’anni. Farmela rivivere, non nei singoli episodi e nei luoghi particolari, il cui ricordo sorgeva più tardi, ma nell’insieme: ridarmi l’atmosfera era un che di surreale e di intimo allo stesso tempo. Il rapporto tra la natura e noi è uno dei più antichi e fondamentali problemi della mente umana.
Il connubio natura-memoria all’interno di questi percorsi di commemorazione intimi dei reduci che ritornano sui campi di battaglia, del resto, è una delle tematiche principali sottolineate da George Mosse nel suo Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, un’opera fondamentale ed imprescindibile nel suo genere per studiare come ogni paese belligerante mise in atto un vero e proprio programma a tavolino per incanalare tutte le energie della rielaborazione del lutto nazionale generato dal conflitto. Scrive Mosse:
L’utilizzazione della natura per mascherare la morte e la distruzione, trasfigurando l’orrore della guerra, conobbe il suo vero dispiegamento soltanto dopo la cessazione dei combattimenti. Da un lato troviamo […] i lindi e ordinati cimiteri militari, o i boschi degli eroi. Ma sui campi in cui aveva infuriato la battaglia la natura subì trasformazioni più vaste della mera fioritura dei papaveri. Qualcosa come trentadue anni dopo la battaglia di Waterloo, Victor Hugo poteva ancora trovare tracce delle trincee, delle colline e dei muri che avevano giocato un ruolo nei combattimenti. Ma R. H. Mottram, rivisitando il fronte occidentale vent’anni dopo la fine della Grande Guerra, poteva soltanto esclamare: – Ogni somiglianza è scomparsa, irrimediabilmente scomparsa – […] La Francia aveva occultato le sue cicatrici sotto il frumento, ondeggiante e i papaveri piegati dal vento. […] La natura servì a mediare tra la realtà della guerra e la sua accettazione [Mosse 2005].
L’Italia, che aveva avuto gran parte della linea del fronte in territorio montano, ebbe gioco facile a seguire questo semplice dettame per l’accettazione della tragedia della guerra. Ben presto sulle Dolomiti, sugli altipiani, tornò la vita di tutti i giorni: la pastorizia, l’agricoltura e addirittura il turismo. La natura incontrollata assorbì quello che la guerra aveva lasciato: trincee, crateri di granata, tonnellate di rifiuti ferrosi, resti di membra umane. Il binomio tra il cimitero di guerra come luogo idilliaco per il ricordo, ed il campo di battaglia bonificato dai resti della guerra di materiali ed immerso nella natura, fu una delle principali “cartoline” per i viaggi al fronte delle associazioni combattentistiche e per i ritorni sui luoghi dei reduci. Una studiata immagine di facciata per la costruzione di una vera e propria liturgia.
Anche Mario Rigoni Stern racconta nei suoi racconti di vita dell’Altipiano di Asiago di questo ritorno dei reduci sui campi di battaglia, risultandone, più di una volta, coinvolto in prima persona.
Per le mie montagne, tra il 1916 e il 1918, gli alpini piemontesi hanno lasciato molte scarpe al sole e per citare un monte basterebbe solo dire Ortigara, e tanti, troppi, sono i cognomi che nei loculi dell’ossario mi ricordano le Langhe e le valli che vanno dalle Alpi Marittime alle Lepontine. Così non mi era raro quando lassù andavo a pernici bianche, incontrare dove finisce la strada automobili targate Torino, Cuneo, Aosta, e comitive di familiari dove un anziano del gruppo illustrava con voce emozionata davanti a quel tragico teatro di guerra le avventure sue o degli sventurati compagni
scrisse su “La Stampa” del 17 agosto 1980. Poche righe dopo raccontò del suo incontro con due reduci, incrociati fuori sentiero sull’Ortigara. Ancora più significativo è il suo ricordo di un altro reduce: «Un giorno di Ferragosto di vent’anni fa mi telefonò un albergatore perché un signore voleva ritornare su un luogo particolare, assieme alla moglie e alla figlia; che lo accompagnassi, mi avrebbe pagato la giornata». Un altro ritorno sui luoghi della guerra, per un viaggio della memoria nell’intimità della propria famiglia.
Salimmo su un’altura, camminavo lentamente perché vedevo che faticava, ma da lassù non riusciva ad orientarsi; c’era, sì davanti a noi il massiccio dell’Ortigara ancora sconvolto dalla battaglia di quarant’anni prima, ma non riconosceva il suo posto. – Non mi ritrovo… – sussurrava. – Lo so com’è, – dicevo io, – l’ho provato. Quando sparano i cannoni e le mitragliatrici corri con la testa bassa, buttando avanti gli occhi per cercare un riparo qualsiasi. – Scendemmo, girammo per trinceramenti sconvolti, cespugli di pino mugo e di ontano fino a giungere nei pressi della Malga Campiluzzi, in un luogo chiamato La Crocetta dove il Ceva, il Mondovì e altri ancora uscirono per l’attacco del 10 giugno 1917. – Da qui, – dissi, – siete partiti per andare tra l’Ortigara e il Monte Chiesa. – Allora ricordò, fu come se un sorso di un liquore misterioso lo animasse e paralizzasse. Andammo per quel sentiero da carbonai: la moglie e la figlia tacevano. […] Giungemmo oltre il Corno della Segala dove si ergono le ripide scogliere del Campigoletti; d’un tratto si guardò attorno con apprensione e stupore, fissò gli occhi a un masso isolato, con passo incerto si avvicinò, si sedette e scoppiò in pianto. Lo lasciai sfogare, ma quando si avvicinarono le due donne si ricompose rapidamente. Lì vicino a quel masso, mentre cercava riparo era stato gravemente ferito e dietro aveva visto i corpi ormai senza vita di tanti compagni. I portaferiti erano venuti a prenderlo quando scese la sera.
La sfera intima, personale, di questi viaggi di reduci è presente in ognuna delle memorie citate. Sembra anzi che le persone che questi pellegrini incontrano sui luoghi dei loro ricordi disturbino il loro “momento”, la sacralità della loro memoria. Ne fa cenno il già citato Bartolini, infastidito dal trattamento riservatogli a Monfalcone dalla popolazione ritornata nella cittadina navale ai piedi del Carso:
Stanotte, tra la gente che incontravo, forse qualcuno s’accorgeva di me: uno de’ tanti reduci che qui tornano in pellegrinaggio. Ricordo che svoltai per una strada onde non incontrarmi con una massa di persone, gruppi di famiglia, giovanotti, ragazze che sfociavano dalla porta, stretta, d’un cinema. […] Ero adirato quasi senza motivo contro tale povera gente, buona, crapulona, randagia, venuta a ripopolare il mondo. Avrei preteso, chissà, che il governo ci avesse mandati i combattenti soli a ripopolare il leggendario Carso e, di certo, io ci sarei venuto e ci avrei portata la moglie, ed avuto casa e figlioli [Bartolini 1930].
Bartolini si sente incompreso da questa gente che non coglie l’importanza di quei luoghi e le sofferenze che essi trasudano. Continua l’artista marchigiano nel suo racconto:
Sortito dall’alberghetto, alla bottega dove vado a comprare della carta e delle matite, domando dell’autobus. Il commesso sembra aver l’aria di prendermi in giro, e siccome gli domando se c’è una strada che dalle Cave di Selz, per il monte Cosich e il Débeli, costeggiando Doberdò, mi rimonti verso Mikoli, Ferleti, al Vallone (e così rivedrei Palkisce da vicino e toccherei i muri delle sue case, col rispetto dei pellegrini che vanno a Loreto a visitare la casetta di Nazaret, ognuno ha le sue ubbie ed io questo bell’amore pei luoghi dove ho combattuto), a sentirmi parlare con amore dei luoghi di guerra, abbozza un risolino del pagliaccio pronto a rispondere con lo spirito delle pezze da piedi [Bartolini 1930].
Altra firma famosa che in un suo testo meno noto della sua lunga produzione racconta del suo ritorno sui luoghi della sua guerra è Paolo Caccia Dominioni. Combattente di tre guerre, dedicò diversi anni nel secondo dopoguerra al recupero delle salme dei soldati italiani caduti nell’area di El Alamein nonché alla progettazione del famoso sacrario di Quota 33 per raccoglierle. Ma la sua opera di conservazione della memoria dei caduti della Seconda guerra mondiale non si limitò a questo. Di mestiere ingegnere, progettò e realizzò diversi altri sacrari, quali l’ossario di Murchison in Australia, a ricordo dei caduti italiani in prigionia, e varie cappelle commemorative. L’indissolubile connubio fra l’opera di Caccia Dominioni e la conservazione della memoria di quanto vissuto durante le guerre da lui combattute è indubbio ed è scaturito fin dalla sua prima esperienza bellica nella Grande guerra. Anch’egli tornò più volte sui luoghi che lo videro prima pontiere, poi flammiere del regio esercito sul fronte dell’Isonzo. Come Bartolini, Caccia Dominioni sentiva propri quei luoghi tanto da volersene quasi appropriare: è noto infatti che acquistò in località Gabrje, ai margini settentrionali del Carso di Comeno, una casa che divenne una sorta di piccolo mausoleo. Il suo legame con il Carso appare prorompente in una sua cosiddetta “opera minore”, La fine del Carso, nella quale, come chiosa finale del breve testo, racconta del suo ritorno in pellegrinaggio solitario sul Carso appena due anni dopo la fine della guerra:
Finalmente, dopo due anni, potei ritornare a Quota Innominata, solo, in un Carso silenzioso e deserto. Ma non presi più il camminamento Genova, perché la pace lo aveva ostruito di erbaccie [sic] spinose, e perché non c’era più bisogno di camminare nascosti. Stentai a riconoscere Dolina Gabucci: ma ritrovai il nostro fornello da caffè nel baracchino di Chini. Scesi nella trincea austriaca a vedere come era: somigliava alla nostra. E ritrovai anche il cartello indicatore: Vigilare con coscienza, resistere ad ogni costo, con due fucilate in più rispetto a quelle lasciate da me. In quel momento vidi due pastori slavi che raccoglievano pezzi di legno, onde ravvivare la fiamma nel loro riedificato focolare. E allora, con religiosa prudenza, mi legai il cartello indicatore al sacco da montagna e me lo portai a casa [Caccia Dominioni 1928].
Esattamente come Bartolini anche Caccia Dominioni sentiva che mani sacrileghe stavano violando il “sacrario all’aria aperta” rappresentato dalle vestigia di guerra sul Carso e, piuttosto che lasciare che la natura e gli abitanti locali lo modificassero definitivamente, profanandolo, preferì asportare ricordi e conservarli a proprio modo. Il campo di battaglia era di proprietà dei reduci, i soli che sapessero e che potessero capire.
Oltre ai già citati illustri Salsa, Bartolini, Caccia Dominioni e Stuparich, anche un emiliano-romagnolo ha voluto ricordare, nel proprio libro di memorie, il suo ritorno da pellegrino sui campi di battaglia del Carso. Si tratta di Arnaldo Calori, reduce del 74° reggimento fanteria della brigata Lombardia, veterano della guerra sul Carso. Anche in questo caso, come per Trincee di Carlo Salsa, il capitolo finale del libro è dedicato a questo ritorno sui luoghi, come giusta chiosa di riflessione dopo il racconto della propria esperienza di guerra. Calori, bolognese di nascita e romagnolo di adozione, tornò tre volte sul Carso, o almeno tre sono i pellegrinaggi di cui fa menzione nel suo libro L’ora K. Anch’egli non è solo in questi suoi viaggi: è con altri commilitoni coi quali ha organizzato, privatamente, un ritrovo sui luoghi della memoria. Anche Calori, come Bartolini, tornò sul Carso di Comeno, usando come base della propria esplorazione Castagnevizza. I luoghi e i nomi dei paesani incontrati dai due reduci sono incredibilmente gli stessi: la stessa osteria, probabilmente l’unica del paese, li ospitò entrambi. Racconta Calori: «Ordinammo il pranzo per mezzodì, poi giù, a piedi, in cerca dei nostri luoghi, quelli dove facemmo voto di tornare se fossimo scampati» [Calori 2016]. Anche qui la componente del ritorno per rendere omaggio ai compagni caduti, ricordare, rivivere con trasporto in forma privata, quindi, appare quella predominante fra le motivazioni che spinsero, in questo caso, il bolognese Calori a rivisitare il Carso su cui aveva combattuto. Anche quest’ultimo, come Salsa, visita i cimiteri di guerra di Monfalcone. Ne fa cenno nel ricordo del suo terzo pellegrinaggio sul Carso, «dopo quattordici anni da che l’ho lasciato» [Calori 2016]. È quasi per caso che si imbatte in uno dei cimiteri di guerra ancora presenti fra le case della distrutta Monfalcone, semplicemente affacciandosi dalla finestra del proprio albergo:
Apro la finestra della piccola camera per dare un po’ d’aria e m’appare, di fronte, tutta sventrata, proprio come in quel tempo, la filanda e, lì presso, qualche altra casa senza tetto coi muri picchiettati di pallottole. Più sotto, a sinistra, un cimitero di guerra. Al vederlo un sussulto. Lì seppellimmo, nel diciassette, un soldato che fu ucciso da una granata. Mi sovviene la forma della lapide che ponemmo su quella sepoltura, e confusamente, l’epigrafe. […] Chissà se la lapide ci sia ancora, dopo tanto tempo… Avranno bombardato, qui, dopo il marzo del diciassette? La famiglia l’avrà voluto al paese il suo figliuolo? Il dubbio mi tormenta: scendo, esco, sono al cancello del cimitero. […] Giro fila per fila e cerco lapide per lapide. Quanta tristezza. Oramai sono alle ultime file e già penso che non troverò nulla, quando, ecco, laggiù, da uno spiraglio tra il verde, la lapide, la più bianca, la sola di marmo, fra tante: la tua, Z., mio caro soldato [Calori 2016].
I ricordi di Calori sembrano concentrare tutti i dubbi e le incertezze vissute dai reduci al loro ritorno sui vecchi campi di battaglia. Anche lui stenta a riconoscere i luoghi: la guerra ha mutato l’aspetto dei monti su cui ha combattuto: «Sotto il Nad-Logem, tutto un bosco di castagni quando vi giungemmo nel sedici, poi denudato e biancheggiante. Tra i sassi, ora, cominciano a spuntare i primi ciuffi d’erba» racconta a proposito del piccolo valico di Devetaki. E ancora:
Ecco, qui c’era, in questo po’ di caverna, il comando di reggimento. Andiamo più avanti; … ecco il camminamento… è tutto sconvolto. Lo seguiamo di fuori, sempre più adagio. Voglio riconoscere i luoghi, i ricoveri, ahimè ormai tutti scomparsi, e i sassi… e la lapide in cemento dei cavalleggeri. Era proprio qui, ma non c’è più. Sì, c’è ancora: eccola a terra, a pezzi e frantumi. Quale mano maledetta compì il sacrilegio? [Calori 2016].
Anche lui si rende conto che la vita, in questi luoghi, è ricominciata, travolgendo quanto la guerra aveva lasciato, quasi profanandone le tracce. In maniera meno estrema di Bartolini, anche Calori constata con rammarico che la popolazione che abita questi luoghi non riesce a percepire la sacralità del vecchio campo di battaglia, frutto delle tante sofferenze patite da soldati. Solo l’occhio attento del reduce vede quanto questi luoghi custodiscono; solo il suo orecchio sente ancora le urla dei feriti e degli uomini gettati all’assalto, o il leggero sussurrio dei soldati, in prima linea e nelle doline, che parlavano sottovoce per non farsi captare dagli austriaci, appostati a pochi metri di distanza. I luoghi sono mutati: la natura e la mano dell’uomo li ha modificati una volta per sempre:
È molto difficile riconoscerli: i nomi delle doline non sono più quelli di guerra: qui ogni cosa viene chiamata, come una volta, in islavo; i reticolati sono scomparsi, le trincee e i camminamenti sconvolti. La gente quassù, tutti slavi, hanno dovuto sconvolgere il suolo per necessità. Essi vivono ancora coi rimasugli, ormai gli ultimi, dei relitti di guerra. Da molti anni esplorano, minutamente il terreno e lo scavano e lo rivoltano per cercare patrone, che sono poi le cartucce, e schegge ed elmetti, ed ogni altri, pur che sia ferro. Così duriamo fatica a trovare la dolina Giardino. È tutta sossopra, irriconoscibile, quasi, e vi cerchiamo invano la lapide in tedesco dedicata al mulo. C’è ancora il camminamento che va alla dolina Conigli, alla dolina Sora, alla dolina Muraglione, alla dolina Grano, laggiù, verso Hudi Log, che spunta coi tetti nuovi e il campaniletto sottile. Anche alla dolina Aosta siamo voluti tornare e l’abbiamo trovata, con la sua grande caverna dove si ricoverò per qualche giorno il nostro battaglione e un altro, poco dopo la nostra partenza, subì un lungo bombardamento con proiettili a gas. Lì fuori, presso l’imbocco, al sole che incominciava a scottare, tibie e costole, dissepolte forse da cercatori di patrone, forse dai soldati che periodicamente vengono a raccogliere i resti dei cadaveri dei caduti per ricomporli nella penombra degli ossari [Calori 2016].
Calori, come Bartolini, non riesce a sopportare la leggerezza delle persone che incontra nella Monfalcone nuovamente popolata e viva: «Qui c’è troppo chiasso; questo luogo non fa per me. Domattina all’alba, via, per le tue mulattiere, o vecchio Carso» [Calori 2016].
Un’altra illustre penna emiliano-romagnola che dedicò molti dei propri scritti alla propria esperienza di ritorno sui luoghi della guerra fu il bolognese Carlo Felice Zanelli. Di professione medico, fu scrittore prolifico di memorie, spesso sotto forma di romanzo. Anche Zanelli, come Bartolini, sceglie di raccontare la propria esperienza di guerra attraverso i ricordi che scaturirono durante i suoi pellegrinaggi sui luoghi che lo avevano visto combattente in grigioverde. Il suo libro, dal titolo Lassù, il cui sottotitolo, fra parentesi, è proprio Ritorno alla fronte, fu stampato presso l’Officina grafica combattenti come numero speciale delle Edizioni della Rassegna dei combattenti in Bologna nel 1932. Il legame, quindi, con un ente combattentistico è forte e palese. Zanelli, del resto, ne faceva parte fin dal primissimo dopoguerra e partecipava alle varie iniziative promosse, fra le quali spiccavano i viaggi sul vecchio fronte del 1915-18. Zanelli esordisce raccontando:
La prima volta che rividi le vecchie zone fu nel settembre 1919, essendo diretto al confine carnico con un treno di ufficiali galiziani reduci dalla prigionia in Italia. Tutto ancora parlava di guerra, e la vittoria era vivente ancora. […] Tra sole e ghiaieti, i costoni dei monti fasciati d’azzurro, il vetro liquido del fiume: e qua e là ospedaletti abbandonati con le croci dipinte sul tetto, depositi di munizioni, pile di reticolati divelti, parchi di barche, baracche disfatte. […] Il Piave l’ho ripassato nel 1921. Già tutto vi parlava d’antica pace, benché le cose che apparivano intatte non avessero più di tre anni. […] La terra aveva già scordato il tallone austriaco, e rialzava il verde dei suoi platani, schiudeva ancora i suoi fiori sui prati. Tutto era rinato. O forse non era morto mai” [Zanelli 1932].
Si tratta, in questi casi, di passaggi più o meno casuali sulla vecchia linea del fronte, non di viaggi organizzati. Come Calori, anche Zanelli torna più volte sui luoghi della propria guerra. Dopo due pellegrinaggi “privati”, la terza volta vi torna invece con un viaggio organizzato. Ma, come vedremo fra breve, questo tipo di pellegrinaggio non lo appaga nel suo percorso intimo di ricostruzione della memoria dei fatti che furono: su questo tema torneremo fra poco. Intanto seguiamo Zanelli attraverso le sue parole:
Un’altra volta fu nel 1925 con il pellegrinaggio che la nostra Federazione bolognese dei Combattenti fece sul medio e sul basso Isonzo. Ottimi amici, scambio di rievocazioni, solidarietà di ricordi, che fanno dei vecchi un’anima sola e li rendono più uniti, quasi spavaldi di fronte a qualsiasi avvenire: ma troppa gente, troppe bandiere, troppe fanfare, troppi discorsi, troppo vino. Ciò vieta ogni meditazione, disperde l’intimità religiosa del sentimento, che richiede silenzio e solitudine per toccare le radici dell’essere e salire nel cielo [Zanelli 1932].
Non potevamo leggere parole migliori per rivivere quanto provato da molti reduci, disturbati dall’inquinamento pomposo e propagandistico che questi viaggi imponevano ai vecchi luoghi di sofferenza. Come Calori e come Bartolini, anche Zanelli quasi non tollera che in questi luoghi si rida, si parli, ignorando quello che fu. Sembra quasi che la morte e la distruzione, che qui albergarono, vi risiedano ancora mal sopportando i nuovi coinquilini, rappresentati dai vecchi abitanti che ritornati a popolare le loro case, i loro pascoli e i loro campi, e i nuovi visitatori, ridanciani, che non percorrono le vecchie strade e mulattiere con il silenzio e il rispetto che sarebbero necessari. Solo pochi sembrano captare il vecchio messaggio che questi luoghi conservano e raccontano.
Zanelli fu autore molto prolifico. Abbiamo letto delle sue memorie di guerra in Lassù, dove ripercorre attraverso il ritorno sui luoghi della sua guerra la propria vicenda personale. In un altro suo libro, Sciabole, scritto nel 1965, Zanelli scrive del suo ultimo pellegrinaggio sulla vecchia linea del fronte, proprio di quell’anno. Il tono è diverso. La vecchiaia, ma soprattutto il peso degli eventi, che lo videro combattente anche della Seconda guerra mondiale, hanno profondamente cambiato il suo animo e la sua predisposizione mentale verso quei ricordi oramai lontani. La pomposità e l’ampollosità dei primi viaggi di gruppo con l’Associazione reduci di Bologna è oramai alle spalle.
Nella piazza centrale della città, sotto la veneranda basilica, l’autocorriera attende i suoi viaggiatori. Vi convengono l’un dopo l’altro, pacatamente, dignitosi vecchietti, hanno l’aria spigliata, quasi giuliva di chi si rechi a compiere un piacevole dovere. […] Or è quasi mezzo secolo tal gruppo di gente faceva parte d’un baldanzoso reggimento di cavalleria, spedito al fronte nei primi giorni di guerra. […] E c’erano i vent’anni, le canzoni spavalde, l’orgoglio dell’arma, la fiducia di galoppar domani verso Trieste. In una parola, la beata incoscienza della giovinezza. Oggi questi signori ignorano certo l’ammonimento di Goethe che disse: – Non ritornate mai nei luoghi dove una volta foste felici –. Ma se anche lo conoscessero, non lo seguirebbero, tanto può in loro la forza del sentimento. E poi, furono davvero felici lassù? O è il tempo che fa scordare agevolmente gli affanni per dar rilievo alle ore liete? Fatto è che cotesti scampati alla guerra e all’età, si trovano oggi a viaggiare su morbide poltrone, nello scarabattolo che li condurrà lontano non tanto di chilometri quanto nel tempo, verso i luoghi e gli anni di allora [Zanelli 1965].
C’è amarezza, rassegnazione e un po’ di nostalgia in queste parole. I pellegrinaggi dei reduci oramai sembrano perdere sempre più anche quel significato intimo che avevano assunto fin da subito. Il tempo ha lenito le ferite e sfuocato i ricordi dei vecchi soldati. Davvero significativo come Zanelli sceglie di concludere questo capitolo di Sciabole, dedicato a questo pellegrinaggio del 1965. Siamo a Conca Paradiso, dove la mattina del 4 novembre 1918 una colonna di cavalleria italiana attaccò un reparto austriaco in ritirata: l’ultimo attacco della guerra, gli ultimi, inutili, morti di un conflitto il cui esito era già stato scritto. Di lì a poche ore sarebbe entrato in vigore il cessate il fuoco. La comitiva di anziani sosta davanti alla lapide che ricorda i caduti in quello scontro: «Gli ultimi caduti per l’unità d’Italia. Che non oggi ma nel 2018 forse potrà celebrare il suo vero centenario» [Zanelli 1965].
Ma il pellegrinaggio intimo, spesso solitario, riflessivo dei singoli reduci non è che uno degli esempi di quei “ritorni sui luoghi che furono” di cui fu caratterizzato il primo dopoguerra. Come abbiamo visto, però, questo sincero viaggio della memoria sopravvisse anche al tipo di pellegrinaggio organizzato e strumentalizzato dal regime che analizzeremo fra breve. Lo abbiamo letto nelle parole di Mario Rigoni Stern, guida occasionale di anziani reduci nel secondo dopoguerra. Pochi di coloro dei quali abbiamo letto le memorie avrebbero probabilmente gradito la spettacolarizzazione e l’eco mediatica innescata dalla macchina propagandistica del regime attorno ai pellegrinaggi sui vecchi campi di battaglia.
3. Strumenti del regime: viaggi organizzati e pellegrinaggi durante il fascismo
Come già accennato nella breve introduzione a questo articolo, la visita ai campi di battaglia fu uno dei pilastri fondanti della propaganda fascista legata alla Grande guerra durante il Ventennio. Accontentare e celebrare i vecchi reduci e combattenti, coinvolgendoli in celebrazioni dense di retorica, fu uno degli strumenti principali per ottenerne il consenso. Un’intera generazione aveva partecipato alla guerra e viveva, fin dai primi mesi successivi alla fine del conflitto, la sensazione di non aver ottenuto tutto quanto le era stato promesso. La “vittoria mutilata”, come venne definita, fu percepita non solo riguardo alla mancata annessione della Dalmazia, ma anche per i mancati vantaggi economici e politici promessi ai combattenti durante gli anni delle spallate sull’Isonzo, o nei paurosi mesi di disperata difesa sulla linea del Piave e del Grappa. Per un regime che si diceva forgiato nelle trincee della Grande guerra, conservare e valorizzare le varie associazioni reducistiche, d’arma e dei mutilati, era un passaggio fondamentale per il proprio consenso. Architettare una liturgia vera e propria per esaltare il sacrificio dei caduti e dei reduci fu un vero e proprio passaggio chiave della macchina propagandistica fascista. L’era della costruzione dei grandi sacrari, lunga quasi un decennio, dal 1928 – anno di approvazione del Programma generale per la sistemazione definitiva delle sepolture militari italiane – al 1938 – anno di inaugurazione del più grande fra questi, Redipuglia – fu il culmine di un processo che fin da subito il regime prese in mano con attenzione.
Far tornare i reduci in pellegrinaggio sui vecchi campi di battaglia fu, oltre al livello meramente propagandistico, una parte fondamentale del progetto di rivitalizzazione di aree che la guerra aveva profondamente impoverito. La bonifica dalle vestigia belliche, fra le quali molte anche pericolose, fu il primo passo per il ritorno delle popolazioni che un tempo abitavano questi luoghi di confine. Spesso veniva inteso come un atto di benevolenza verso i “fratelli italiani liberati” che avevano diritto di vivere nei luoghi così duramente strappati al nemico. Le trincee e i camminamenti vennero interrati, bombe e granate vennero asportate, i reticolati rimossi e i cadaveri ancora presenti così numerosi sui vecchi campi di battaglia vennero inumati nei piccoli cimiteri di guerra che furono così parzialmente risistemati, riordinati e ridotti di numero.
Ma oltre alla risistemazione per favorire il ritorno delle popolazioni scacciate dalla guerra, non si trascurò la possibilità di far fiorire sui vecchi campi di battaglia della guerra italo-austriaca anche una nuova forma di turismo. Riportare reduci, magari con familiari appresso, a visitare i campi di battaglia faceva parte di un progetto molto articolato con molteplici scopi. In primis, come già accennato, quello di celebrare i caduti e tutto il mondo combattentistico e reducistico: uno scopo precipuamente politico. Unitamente a questo appariva altrettanto importante ai fini del “controllo delle menti degli italiani” anche la possibilità di esorcizzare, attraverso una precisa liturgia e celebrazione, l’enorme lutto provocato dal conflitto. La risistemazione dei cimiteri di guerra, la cura del decoro delle tombe e delle sepolture nonché, in seguito, la costruzione dei grandi sacrari, va ovviamente in questo senso. A tal proposito fiorì quella che viene spesso definita come la “monumentomania” [Levra 1992]: l’erezione di monumenti, cippi, lapidi, iscrizioni nelle città e nei paesi della Penisola, nonché sulla stessa linea del fronte. I pellegrinaggi e i viaggi lungo le vecchie trincee della Grande guerra facevano parte di questa liturgia. Spesso si coniugava a questa prima fase di ritorni sulla linea del fuoco con la ricerca, da parte dei parenti, delle tombe dei propri cari caduti, coadiuvati in questo dalle associazioni d’arma e combattentistiche. Anche negli altri paesi europei si stava sviluppando un fenomeno del tutto simile, in particolar modo in Inghilterra, dove ad aiutare in questa pietosa ricerca i cittadini inglesi che ne facevano richiesta era sorta, fin dal 1917, un’associazione come la Gold Star Mother, o la Royal British Legion nel 1920.
Non furono però solo le associazioni d’arma, combattentistiche o reducistiche a frequentare la vecchia linea del fronte: vi furono anche scuole, dopolavori, associazioni culturali e turistiche e, soprattutto, gruppi organizzati di orfani, vedove di guerra e mutilati. Ma su questo torneremo fra poco.
Altri scopi importanti di questa politica che favoriva la visita ai campi di battaglia sui quali da poco si era diradato il fumo delle esplosioni erano di natura prettamente economica e pedagogica. Coniugare la celebrazione e la commemorazione dei caduti con il turismo fu una trovata importante per contribuire alla rinascita di quei territori, come ad esempio l’Altopiano di Asiago, dove la guerra aveva sostato ininterrottamente dal 1915 al 1918. Sono sempre i racconti di Mario Rigoni Stern a raccontare quanto il ritorno delle popolazioni e la ripartenza delle semplici attività di pastorizia e di agricoltura degli abitanti dell’antica Reggenza dei Sette Comuni furono duri e faticosi. In questo quadro, il turismo sui campi di battaglia ben presto iniziò ad occupare un ruolo importante nel rilanciare l’economia postbellica, caratterizzandosi sia come un fenomeno culturale sia politico in grado di catalizzare sentimenti collettivi, idealità nazionali, sofferenze, speranze della società europea che la guerra tanto dolorosamente aveva segnato, e capace di contribuire alla costruzione di una memoria sociale del conflitto [Capuzzo 2020].
Questa nuova generazione di pellegrinaggi si sarebbe inserita perfettamente nella scia di una tradizione pluridecennale che aveva portato da Calatafimi a San Martino, da Caprera a Curtatone e Montanara, migliaia di italiani, reduci delle cosiddette “patrie battaglie” con le loro famiglie, scolaresche cresciute sul solco dell’epopea risorgimentale, a calcare la terra dei vecchi campi di battaglia. Tutto questo aveva portato il turismo locale a fiorire: la ricezione alberghiera, i punti di ristoro, i ristoranti ed in generale il commercio locale avevano certamente beneficiato di questo “turismo di guerra” dei luoghi nei quali “si era fatta l’Italia”. Le proporzioni enormi della Grande guerra, che aveva coinvolto quattro regioni, e la natura stessa del conflitto, stanziale, ingombrante e permanente avrebbero senza alcun dubbio amplificato questo fenomeno. Favorire il turismo nei luoghi in cui si era combattuto, andando ad effettuare quindi iniezioni di liquidità di denaro in territori che, obiettivamente, ne necessitavano enormemente dopo le devastazioni e il depauperamento generale imposto dal conflitto, avrebbe favorito la ripresa economica. A latere di questo obiettivo economico si affiancava quello pedagogico. Una celebrazione motivata del “bottino” territoriale ottenuto con 41 mesi di guerra e 650.000 morti faceva apparire il sacrificio profuso come giustificato e giusto e, al contempo, istruiva gli italiani a proposito di queste nuove terre “liberate”, da conoscere e inglobare culturalmente nella “nuova” Italia. I primi a recepire questa nuova opportunità data dal turismo di guerra, con il suo duplice scopo economico e pedagogico, furono i soci del Touring club italiano (Tci) che organizzarono già nel 1919 un primo tour delle terre redente.
La mattina del 14 luglio 1919 un treno speciale con un migliaio di persone è in partenza da Milano alla volta di Riva del Garda, poi verso il Trentino e l’Alto Adige. Sono i soci del Tci, protagonisti di quella che il corrispondente del “Corriere della Sera”, al seguito della carovana, definì «la più grande manifestazione turistica italiana, per numero di partecipanti, per l’ampiezza del viaggio, per le finalità». L’anno successivo si andrà nella Venezia Giulia e in Istria. Il viaggio era stato programmato dal consiglio direttivo del Touring, con un certo ottimismo, già nel 1915, allo scopo di far conoscere le regioni divenute finalmente italiane. Fin dalla sua prima ideazione, l’escursione assunse una connotazione marcatamente patriottica: occorreva visitare le nuove regioni guadagnate alla patria, secondo il compito supremo dell’associazione, tante volte dichiarato, di «far conoscere l’Italia agli Italiani» [Papa 2011]. Secondo il Touring, infatti, la pratica del turismo e del viaggio portava con sé la superiore finalità di radicare il senso di italianità, contribuendo in modo decisivo a far conoscere la Penisola e a guardarla in maniera non oleografica. La formazione del sentimento di appartenenza passava anche dalla visita a luoghi simbolici legati alle guerre d’indipendenza [Senna 2014]. Siamo nel 1919: non ci sono ancora le pressanti ingerenze di un regime ancora di là da venire dietro ad iniziative di questo tipo. Non ci sono ancora liturgie di massa da eseguire in questi luoghi “sacri alla patria”. Si tratta di iniziative sull’onda delle tante parole spese durante il conflitto, per alimentare la combattività dei soldati e per rabbonire le famiglie con un figlio, un padre o un marito caduto o ancora stanziato al fronte.
Ma la politica del Touring non si fermava qui. A fianco di questi primi viaggi turistici lungo la vecchia linea del fronte si era già, come abbiamo visto, sviluppato un naturale ritorno dei reduci sui campi di battaglia, per rivivere le emozioni provate, commemorare i commilitoni caduti e rielaborare intimamente quanto vissuto. Era già chiaro che molti di questi reduci non avrebbero apprezzato, come abbiamo visto negli scritti di Bartolini, Calori e Zanelli, le carovane chiassose. Ma il Touring era attrezzato anche per loro. Chi voleva poteva rivolgersi alle varie sedi locali dell’associazione per richiedere informazioni dettagliate sui sentieri, i punti d’appoggio ecc. Molti reduci stessi, soci del Touring, si erano messi a loro volta a disposizione per fare da guide. In particolar modo a semplici curiosi, o a loro volta a ex combattenti che volevano tornare sui luoghi della guerra del massiccio del Monte Grappa e del Pasubio, il Touring offriva un pacchetto turistico completo comprensivo di informazioni, visite guidate, carte con indicati i punti di appoggio, i punti di ristoro convenzionati, servizi di accompagnamento su autovetture e, addirittura, a dorso di mulo. Nella sola Gorizia esistevano due agenzie automobilistiche, promosse dal Touring, che offrivano escursioni a pagamento per reduci.
A fianco delle varie attività sul campo, sempre il Tci promosse anche un’intensa campagna editoriale per promuovere queste iniziative turistiche così mirate e così importanti. Sulla rivista “Le vie d’Italia” ad esempio, organo ufficiale dell’associazione, non c’era numero in cui non si accennasse al turismo di guerra e nelle zone che avevano visto passare la linea del fronte. La rivista vide in breve tempo quasi raddoppiare la propria tiratura: se nel 1921 veniva stampata in 75.000 copie, nel 1927 era già arrivata a 180.000. Vi si potevano trovare articoli quali quello del colonnello Italo Gariboldi, che in ben due numeri consecutivi, quello di dicembre 1924 e quello del gennaio 1925, scrisse due lunghi articoli su Le grotte di guerra, per venire incontro sia al pubblico dei reduci che a quello degli speleologi. L’articolo, molto dettagliato, spesso riporta anche le mappe di molte di queste cavità, con foto e indicazioni. Ancora più mirato era l’articolo dell’ingegner Giuseppe Cobòl: In pellegrinaggio ai cimiteri di guerra, del numero de “Le vie d’Italia” del novembre 1922, dove si descriveva il viaggio dell’autore nei vari campisanti militari presenti nella zona di Gorizia. Per anni questo articolo fu uno dei pochi punti di riferimento per le famiglie dei caduti per la ricerca delle tombe e delle sepolture dei propri cari. Non erano ancora avvenuti la parziale risistemazione dei cimiteri di guerra, il censimento dei caduti e, soprattutto, negli anni Trenta, la creazione dei grandi sacrari. Sulla stessa linea editoriale andava il pezzo di Gino Damerini Cimiteri di guerra in montagna, dell’aprile 1922, che descriveva il viaggio dell’autore nelle Dolomiti ampezzane, fra cimiteri, rinvenimenti di cadaveri nei ghiaioni, sepolture singole ecc… E questi non sono che alcuni esempi di articoli di questo tipo. Ma l’iniziativa che divenne il vero e proprio fiore all’occhiello del Tci riguardo al turismo di guerra fu la realizzazione della collana di libri Sui campi di battaglia, inaugurata nel 1927 con il primo numero. La collana si componeva di sei volumi: un primo di introduzione, il secondo dedicato al Medio e Basso Isonzo, il terzo al Monte Grappa, il quarto al Cadore, la Carnia e l’Alto Isonzo, il quinto al Piave e al Montello, il sesto e ultimo al Trentino, al Pasubio e agli Altipiani. Il successo ottenuto da questa iniziativa editoriale fece sì che di questa collana fossero fatte più edizioni e ristampe, con aggiornamenti e aggiunte successive.
Dopo questa prima tappa di “naturale” ritorno sui luoghi di guerra, già incentivata dai governi del primo dopoguerra, cominciò, con l’avvento del fascismo, la costruzione della celebrazione artefatta della Grande guerra tramite una precisa liturgia propagandistica, studiata a tavolino e atta, in particolar modo, a generare consenso per un regime che, come è noto, si diceva nato nelle trincee del fronte. È quindi dalla metà degli anni Venti e fino alla fine degli anni Trenta, che assistiamo ad un turismo di guerra a ciclo continuo sui vecchi campi di battaglia, promosso, per conto del regime, dalle associazioni patriottiche, di ex combattenti, ma anche dalle scuole e dai dopolavori.
Particolarmente simbolico è il famoso “Pellegrinaggio degli Orfani di Guerra ai Campi di Battaglia del Medio e Basso Isonzo” che si svolse fra il 31 agosto e il 2 settembre 1931. Di questo pellegrinaggio esiste anche un dettagliato reportage cinematografico dell’Istituto Luce. Tale era l’importanza propagandistica di questa iniziativa che fu realizzato addirittura un lungo servizio che comprese tutti e tre i giorni di durata. Base logistica del raduno fu Gorizia, la “Santa”, dove si inaugurò il pellegrinaggio con una tipica orazione dal balcone da parte di varie figure politiche dell’epoca e di appartenenti ad associazioni combattentistiche, come il colonnello, medaglia d’oro, mutilato di guerra, nonché onorevole, Achille Martelli, rappresentante dei mutilati di guerra. Il pellegrinaggio toccò il Monte Calvario, con omaggio alla tomba di Scipio Slataper alla presenza della vedova e del figlio, al Cimitero degli eroi di Gorizia, con posa di corone, alle tre cime del Monte San Michele, ad Oslavia e ai suoi cimiteri di guerra, dove un orfano ritrovò addirittura la tomba del proprio padre, al baluardo del Sabotino, a Redipuglia e al cimitero del Colle di Sant’Elia, antesignano del grande e futuro sacrario, dove si tenne una messa solenne, ed infine a Trieste, la “liberata”. Alla grande manifestazione presenziarono orfani appartenenti alle relative sezioni di tutta Italia tra le quali, ovviamente, alcune provenienti dall’Emilia-Romagna, la regione d’origine di Mussolini.
4. Viaggi collettivi di emiliano-romagnoli al fronte
L’ingombrante caratteristica di essere la regione natale del duce fece sì che, ovviamente, in Emilia-Romagna, quasi più che in altre regioni italiane, ci si sentisse in dovere di partecipare attivamente alle iniziative del regime, come da dover sembrare “la prima della classe”.
Non esiste purtroppo uno studio dettagliato sul caso emiliano-romagnolo in connessione al fenomeno dei pellegrinaggi, ai viaggi della memoria e al turismo di guerra: le memorie sono sparse, sepolte e dimenticate, ma il seppur scarno materiale rinvenuto ha permesso di fare una luce, con alcuni brevi esempi, sulla portata di queste iniziative nella nostra regione. Punto di riferimento per questa breve disamina è il pellegrinaggio organizzato sui campi di battaglia dalle associazioni cosiddette “di guerra”, reducistiche, combattentistiche e dei mutilati della provincia di Forlì per il 4-5-6-7 maggio 1934. Si trattò di un’iniziativa molto estesa e articolata che coinvolse oltre un migliaio di persone: un pellegrinaggio davvero imponente. Se la regione di origine di Mussolini doveva dimostrare di meritare un “figlio” di tal fatta, ancor di più doveva prodigarsi per dimostrare il proprio lustro la provincia in cui era nato. L’organizzazione messa in piedi dagli organizzatori fu importante. Per l’occasione fu distribuito ai partecipanti un piccolo opuscolo con il programma. Ma non fu tutto. Fu stampato anche il numero unico “La tradotta forlivese”, che fin dal titolo si rifaceva palesemente alla rivista dei soldati promossa, stampata e distribuita all’interno della 3ª armata: “La tradotta”. Completamente dedicato al pellegrinaggio verso i campi di battaglia della 3ª armata; 16 pagine in folio con addirittura un allegato di ulteriori quattro pagine con gli sponsor che finanziarono l’edizione. Il giornale riporta la cronaca, più faceta che seria, del pellegrinaggio. Sembra proprio che il clima ridanciano, annaffiato da diverse bottiglie di vino, che tanto aveva dato fastidio a Zanelli, fosse all’ordine del giorno. A confermarlo sono le stesse righe del pezzo principale sul pellegrinaggio, Noterelle di viaggio che recitano:
Se volessimo accennare ai gruppi simpatici ed allegri che abbiamo trovato durante le frequenti corse lungo il treno non finiremmo più, ché il nostro taccuino è pieno di appunti, di nomi, di accenni. […] Ma come dimenticare la carrozza di Riccione che pareva un manicomio in attività di servizio e che non riusciva a calmarsi nemmeno quando appariva la gentile figura della contessa Pasquini, madrina di quei combattenti, venuta da Roma con tutta la famiglia per seguire i turbolenti figliocci? Ed il numeroso gruppo di Santa Sofia che per l’occasione si era portato alcuni commilitoni capaci di suonare un… piffero di loro invenzione che intonava con una… soavità tutta sua i canti di guerra, mentre Ravaglioli di Dovadola, ritto su una panca, gridava e cantava all’ombra dell’enorme cappello? E quella carrozza che alcuni Forlivesi avevano ornata di festoni di fischi i quali, ahimè, venivano vuotati con una rapidità favolosa lasciando imperturbati e… schietti i portentosi bevitori?
A dare ancora più colore alle pagine della rivista sono le vignette e le caricature di Ettore Nadiani, ingaggiato appositamente per l’occasione.
A far parte del comitato organizzatore erano alcuni esponenti del mondo associazionistico, politico e culturale forlivese, molti dei quali di spiccata provenienza repubblicana. Fra questi è d’uopo citare in particolare Aurelio Lolli, Agostino Biondi e Antenore Colonelli. Quest’ultimo, che non poté partecipare al pellegrinaggio a causa di un’indisposizione dell’ultimo minuto, era reduce e mutilato di guerra: aveva addirittura tentato di far parte di quel nucleo di repubblicani che, in concomitanza con la legione garibaldina dei fratelli Garibaldi, avevano tentato di costituire un reparto autonomo, la compagnia Mazzini, per combattere già nel 1914 a fianco dei francesi sul fronte occidentale. Il gruppo fu disciolto ancora prima di potersi costituire. Ma Colonelli, con la dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria-Ungheria del 24 maggio 1915, si arruolò volontario e venne gravemente ferito sul Sabotino, rimanendo mutilato e quindi esonerato dal servizio militare. Ma fra i partecipanti citati dagli articoli troviamo anche altri nomi di personaggi forlivesi decisamente noti. Mario Miserocchi, ex combattente dei reparti d’assalto, aveva realizzato sulla locomotiva del treno che trasportava la grande comitiva un grande elmetto Adrian, quello delle truppe italiane. Un altro noto artista dal nome d’arte Silìn, al secolo Aurelio Melandri, reduce di guerra, partecipò al pellegrinaggio, insistendo per fare una escursione, anche se fuori programma, alla Sella di San Martino, dove aveva combattuto e vissuto la tragica esperienza della guerra sul fronte del Monte San Michele.
Il programma offerto ai partecipanti era ricco di iniziative collettive: visite di dovere, pose di corone di alloro a vari monumenti, ma soprattutto una solenne cerimonia per uno scambio simbolico di “pietre” fra la comitiva romagnola e il Carso che aveva visto molti dei partecipanti come combattenti. Sul treno speciale che era partito in notturna da Rimini alla volta di Gorizia, la sera del 4 maggio 1934, con sosta in svariate stazioni e un apposito rallentamento al momento del passaggio del Piave, per favorire un «lancio nel Fiume Sacro di una corona di alloro» c’era una pietra «divelta dall’appennino della Rocca delle Caminate», la residenza forlivese di Mussolini, «recata dai combattenti forlivesi» per essere posta, con rito solenne, all’interno del cimitero del Colle di Sant’Elia. Oltre a questi momenti di ritrovo di gruppo, ai singoli fu permesso di avere due mezze giornate di libertà, per poter effettuare brevi gite a piacimento.
Si trattò a tutti gli effetti di una classica visita ai campi di battaglia degli anni Trenta se paragonata ad altre esperienze del tutto similari come programma e come ritualità. Di certo il numero dei partecipanti così cospicuo e l’eco mediatica dell’avvenimento ne fecero uno dei pellegrinaggi più noti e seguiti fra quelli effettuati da associazioni reducistiche e combattentistiche dell’Emilia-Romagna. In ricordo della gita a tutti i partecipanti fu consegnata una medaglietta commemorativa, ancora oggi facilmente rintracciabile sui vari mercatini dell’antiquariato.
Un altro esempio documentato di pellegrinaggio ai campi di battaglia di un gruppo organizzato emiliano-romagnolo è quello del 1932 della sezione di Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza, dell’Associazione nazionale combattenti. Anche questo pellegrinaggio si svolse su più giorni: dal 23 al 27 maggio. In questa occasione si scelse come meta l’Alto Vicentino e il Trentino. Sebbene il Carso e la zona di Redipuglia, soprattutto dopo la costruzione del grande sacrario, fossero diventate le mete predilette di questi viaggi di reduci per l’alta carica simbolica dei luoghi, anche il fronte veneto e trentino divenne punto di ritrovo frequente di questi “pellegrinaggi sociali”. Del resto il grande sacrario del Pasubio fu il primo ad essere costruito: a seguito di una iniziativa privata e non statale. L’ossario venne edificato a quota 1.217, a Colle Bellavista, a picco sulla pianura veneta, tra il 1920 e il 1926, per iniziativa della Fondazione 3 novembre 1918 pro combattenti della 1ª armata. Dopo anni di lavori, finanziati anche da donazioni private, in particolar modo da parte del generale Guglielmo Pecori Giraldi, venne finalmente inaugurato il 29 agosto 1926, ben prima della grande stagione dei sacrari degli anni Trenta. Si voleva chiaramente fare di questo luogo un punto di ritrovo per i reduci, per ricordare, commemorare e rivitalizzare la memoria dei sacrifici profusi sulle balze del massiccio del Pasubio.
Il pellegrinaggio dei reduci borgonovesi fu in scala alquanto ridotta rispetto alla grande massa di forlivesi che si sarebbe accalcata sul treno speciale due anni dopo. Per l’occasione fu organizzato un autobus. La grande adesione, ed evidentemente anche la cattiva organizzazione, fece sì che al ritrovo fra Borgonovo e Piacenza ci si accorgesse che i partecipanti superavano i posti disponibili sull’autobus. Fu così che venne noleggiata a parte una Bianchi a quattro posti per permettere ai più alti in grado fra i partecipanti (due generali, il podestà di Borgonovo e il presidente della sezione dell’Associazione nazionale combattenti) di stare più comodi. Vari guasti incorsi, in particolar modo alla Bianchi, fecero sì che l’intera gita partisse con ritardo, mancando la prima tappa in quel di Vicenza, dove inutilmente aspettavano i camerati della locale Federazione provinciale dei combattenti. Prima tappa il 24 maggio 1932 fu, per l’appunto, l’ossario del Pasubio. Successivamente il gruppo si spostò in quel di Rovereto per visitare il Museo storico italiano della guerra, inaugurato nel 1921. Terza tappa Trento, dove non mancò una visita al Castello del Buonconsiglio e ai luoghi del martirio di Cesare Battisti, Fabio Filzi e Damiano Chiesa. Quarta tappa, sulla via del ritorno da Trento per rientrare a Thiene, dove la comitiva aveva il proprio alloggio, fu Lavarone. A proposito di questa visita, nell’opuscolo dedicato al pellegrinaggio, si ritrova un amaro commento che stona un po’ con la pomposità ridondante che caratterizzava queste celebrazioni:
A Lavarone sono italiani di nome, ma non di sentimento. Nel piccolo caffè in cui entrammo ci rivolsero a tutta prima la parola in tedesco, a malgrado le nostre automobili portassero le bandiere italiane e la scritta A.N.C. Sezione di Borgonovo Val Tidone, ma notata la nostra sorpresa fecero presto a parlare in italiano.
Davvero un’affermazione audace per un’iniziativa che doveva invece mettere in luce e celebrare l’annessione di territori legittimamente italiani. Il 25 maggio la gita si spostò sull’Altipiano di Asiago. Prima sosta nella zona di Cesuna con visita ai cimiteri della Val Magnaboschi e ad un luogo altamente simbolico: la colonna romana, reperto archeologico, donata dal Comune di Roma, per simboleggiare il punto di massima avanzata raggiunto dagli austriaci durante la Strafexpedition, rintracciabile proprio in Val Magnaboschi non lontano dai due grandi cimiteri. Se ne possono vedere diverse sparse per la linea del fronte: ad esempio una anche sul Monte Grappa, in Val San Lorenzo, altra nota meta di pellegrinaggi. Qui, in Val Magnaboschi «per bocca di un camerata che ivi aveva combattuto, vivemmo le fasi, or favorevoli ora contrarie, di quella giornata che nella storia della guerra ricorda le epiche gesta della Brigata Forlì». La comitiva poi si sposta ad Asiago dove è in costruzione il sacrario del Leiten:
Sarà con quello del Pasubio e del Grappa il terzo ossario che permetterà di eliminare a poco per volta tutti i piccoli cimiteri di guerra che, pur tenuti con cura ed amore, soffrono le intemperie invernali, e croci, iscrizioni e targhe metalliche, piccoli ricordi marmorei sono danneggiati per i lunghi periodi in cui restano sepolti sotto le nevi.
Anche qui si lasciava tempo ai partecipanti di intraprendere escursioni in solitaria, per rispetto del momento di ricordo privato ed intimo che ogni reduce, per quanto ridanciano e di compagnia, necessitava non appena ritornato in quei luoghi:
Dopo la colazione una parte dei componenti il pellegrinaggio volle recarsi all’Ortigara, calvario degli alpini, ma la fitta nebbia, la neve ed il freddo intenso la fece retrocedere da Campo Mulo non senza aver fatto raccolta di elmetti tedeschi, rottami di granate, spolette e perfino di una gavetta alpina. […] Dopo la visita ai cimiteri ciascuno raggiunse la località che desiderava. Parte si diresse al Sisemol, altri a Monte Valbella, caratteristico colla sua gigantesca croce di legno, altri ancora alle Melette di Gallio. […] Vivemmo così la nostra seconda giornata di grandi emozioni, di rievocazioni, di superbi ricordi, superba pagina della vita vissuta su quelle alture dai nostri valorosi camerati che col loro sangue santificarono quelle zolle che, per noi italiani, sono e saranno sacre in eterno.
Il giorno successivo visita al massiccio del Grappa: anche qui non mancarono il momento di ricordo dei reduci, l’incontro con altre comitive (in coincidenza della giornata festiva del Corpus Domini), e un sopralluogo ai lavori di costruzione del futuro sacrario di cima Grappa.
L’opuscolo dedicato al pellegrinaggio termina con parole di soddisfazione, tanto che si accenna già all’idea di riproporre lo stesso formato organizzativo per una gita sul Basso Carso e al fronte dell’Isonzo nel 1933.
Sebbene questa gita “piacentina” non riproponga se non in minima parte i passaggi “obbligati” della liturgia consolidata delle visite delle associazioni combattentistiche durante il Ventennio (uno dei quali, il saluto alle locali associazioni, era saltato per il guasto occorso alla Bianchi!), merita di essere riproposta e analizzata proprio per la sua portata minore e per la sua forma più raccolta. Un’ulteriore testimonianza di una prassi schematica che si riproponeva dalle grandi adunate da migliaia di persone, a quelle di piccoli gruppi.
5. Sulla scia della tradizione, con alcune naturali “intromissioni”: i pellegrinaggi della sezione bolognese dell’Anvrg
Un caso di studio interessante per vedere come questa nuova riproposizione dei pellegrinaggi sui luoghi della Grande guerra, così tanto fortemente voluta dai governi del dopoguerra ed in particolare dal regime, si fosse inserita sulla scia di una tradizione già consolidata, è quello delle sezioni dell’Associazione nazionale volontari e reduci garibaldini (d’ora in avanti Anvrg), la principale associazione combattentistica nella quale si riconoscevano e alla quale si iscrivevano centinaia di uomini coinvolti, ognuno nella maniera più disparata, nell’epopea garibaldina.
Questa breve analisi si basa in particolar modo sulle carte della sezione bolognese dell’Anvrg, comprendendo a pieno titolo anche quelle della Federazione nazionale volontari garibaldini (la Fnvg) [1], l’ente fondato da Ezio Garibaldi durante il fascismo.
Come già accennato in precedenza l’abitudine di ritornare sui vecchi campi di battaglia fiorì in Italia proprio verso fine Ottocento, quando si gettavano le basi politiche del patriottismo italiano anche tramite la celebrazione degli scontri armati che avevano costellato il percorso unitario nazionale e, con essi, logicamente, anche i combattenti che vi avevano preso parte. I reduci delle cosiddette “patrie battaglie” erano orgogliosi di ritornare sui luoghi nei quali avevano combattuto, da veri e propri protagonisti della tanto celebrata unità. Fra questi, ovviamente, in prima fila c’erano i garibaldini, il cui spirito di corpo e di appartenenza ai reparti che avevano combattuto in camicia rossa era ben evidente e tangibile. Non c’era occasione fra le varie feste nazionali, gli anniversari e le ricorrenze di storia patria in cui fra la folla non spiccassero le camicie rosse dei veterani e reduci garibaldini, sempre presenti e sempre pronti a sfoggiare con orgoglio la propria tipica divisa.
Gli stessi reduci garibaldini furono fra i primi ad avere una propria liturgia per la celebrazione delle proprie ricorrenze e del ricordo dei propri caduti. In primis non mancava mai nel calendario delle iniziative annuali di ogni sezione dell’Anvrg la consueta gita a Caprera a rendere omaggio alla tomba del capostipite della tradizione che li animava. Del resto il pellegrinaggio a Caprera era stata una prassi consueta per tutti coloro i quali si sentivano di appartenere alla grande famiglia garibaldina quando ancora l’eroe dei due mondi si trovava in vita.
Il garibaldinismo, come scrisse la camicia rossa di Grecia nel 1912 e delle Argonne nel 1914 Camillo Marabini «È febbre che, quando vi ha ghermito, più non vi abbandona» [Marabini, 1915]. E del garibaldinismo la liturgia era una parte fondamentale e fondante.
Anche nelle carte della sezione bolognese c’è traccia di questa ricorrenza e della rituale gita annuale: appelli, controappelli di verifica per le presenze, spesso stanziamenti di piccoli fondi da parte della sezione per aiutare un venerando reduce poco abbiente per poter partecipare a questa importantissima tappa della liturgia garibaldina; sono questi i temi ricorrenti di buona parte dei carteggi relativi ai pellegrinaggi a Caprera. Con la morte di Giuseppe Garibaldi e con l’ascesa di Ricciotti, suo figlio, come erede della tradizione paterna, i combattimenti delle camicie rosse proseguirono incessanti. Spesso scomodi da raggiungere, i luoghi in cui avvennero gli scontri a cui parteciparono le camicie rosse, non furono mete di pellegrinaggi organizzati. Si pensi solo alla sperduta Domokos, sui monti della Tessaglia, dove si combatté nel 1897 o a Dryskos, vicino a Giannina, nell’Epiro, dove avvenne lo sfortunato scontro coi Turchi del 1912. Rimaneva comunque un fortissimo legame della comunità garibaldina con i luoghi in cui le camicie rosse avevano combattuto: tappe fondamentali, ai loro occhi e non solo, sia della tradizione di un corpo militare volontario del tutto particolare come quello, sia della storia nazionale italiana.
L’importanza della comunità garibaldina, da sempre una rappresentanza numerosa ed ascoltata all’interno delle strutture politiche italiane, si evince però da un altro importantissimo passo fondamentale del panorama generale dell’interventismo italiano nel cosiddetto “maggio radioso”. Fu proprio il 5 maggio 1915, alla tradizionale cerimonia garibaldina presso lo scoglio di Quarto, punto di partenza della spedizione dei Mille che avvenne probabilmente la più famosa manifestazione interventista del Regno. In occasione del 55° anniversario della partenza delle due navi che portarono i Mille in Sicilia, e dell’inaugurazione del monumento bronzeo commemorativo dello scultore Eugenio Baroni, fu organizzato un enorme raduno sul solco del tradizionale ritrovo garibaldino. Alla presenza di oltre 20.000 convenuti Gabriele D’Annunzio pronunciò il famoso “discorso di Quarto” che incitava il governo e la monarchia a prendere parte alla guerra. Pochi sapevano che già il 26 aprile era stato firmato il patto di Londra che sanciva l’entrata in guerra del Regno d’Italia entro un mese dalla stipula. La coincidenza e la sovrapposizione di questo evento interventista con una tappa fondamentale della liturgia garibaldina sono, come si può vedere, altamente simboliche e non casuali, sul solco del prosieguo di una tradizione di celebrazioni di momenti chiave della storia patria.
Se Domokos e Dryskos rappresentavano luoghi quasi irraggiungibili dai garibaldini in pellegrinaggio, certamente si rivelarono più vicini e fruibili i luoghi degli scontri che coinvolsero i garibaldini durante la Grande guerra. I combattimenti nelle Argonne, avvenuti a cavallo fra il 1914 e il 1915, a cui parteciparono gli uomini della legione garibaldina al comando di Peppino Garibaldi, entrarono a pieno titolo all’interno dei pellegrinaggi ciclici della tradizione dell’Anvrg, nonché di quelli delle altre associazioni combattentistiche impegnate in questi viaggi della memoria sul primo conflitto mondiale. Dopo l’esperienza bellica nella legione garibaldina in Francia, molte delle camicie rosse, all’entrata in guerra del Regno d’Italia, si arruolarono nel regio esercito. Ci sono diversi casi di vecchi reduci garibaldini, spesso anche ultrasettantenni, che si arruolarono in grigioverde per proseguire la loro lotta contro l’Impero austro-ungarico che aveva caratterizzato molte delle loro battaglie nell’Ottocento. Alcuni di questi caddero, come ad esempio Giulio Lavezzari, classe 1849, originario di Vigevano ma residente a Bologna. Questo reduce di Bezzecca cadde nel luglio 1915 sul monte Podgora, di fronte a Gorizia, con le mostrine del 35° reggimento fanteria della brigata Pistoia. Il luogo della sua morte, riconoscibile da un piccolo obelisco che lo ricorda, fu tappa fissa dei pellegrinaggi dei reduci alla vecchia linea del fronte della testa di ponte di Gorizia. Ma molti dei vecchi reduci garibaldini, in particolare quelli recenti provenienti dalle Argonne, chiesero a gran voce di essere destinati alla brigata Alpi (51° e 52° fanteria), reparto erede dei vecchi Cacciatori delle Alpi, comandato da Giuseppe Garibaldi nella Seconda e Terza guerra d’indipendenza. Sul solco di questa tradizione, i comandi del regio esercito misero al comando dei reparti della Alpi proprio i fratelli Garibaldi, figli di Ricciotti, per sfruttare l’onda entusiastica che si stava generando intorno a questa storica unità. La Alpi combatté duramente fra il 1915 e il 1917 sul fronte dolomitico, legando una volta per sempre luoghi come il Col di Lana e la Marmolada alla tradizione garibaldina. Anche in questi luoghi furono soventi i ritorni dei reduci in camicia rossa, in particolare dopo la costruzione del grande sacrario di Pian di Salesei, che raccoglieva molti dei caduti della Alpi in questo settore.
Ma a coniugare in pieno la tradizione garibaldina e quella nascente legata alle celebrazioni della Grande guerra fu il trasferimento della brigata Alpi, e con lei quello di diverse altre brigate e reparti, sul fronte francese nel 1918, in uno scambio di aiuti reciproci fra esercito italiano e francese, stretti da alleanza. Il corpo d’armata italiano del generale Albricci che combatté in Francia fu stanziato a breve distanza dai luoghi in cui la legione garibaldina aveva combattuto fra il dicembre 1914 e il gennaio 1915. Per molti soldati della Alpi fu un vero e proprio ritorno sui luoghi che tre anni prima li avevano visti protagonisti degli sfortunati scontri in divisa francese, con la camicia rossa sotto il pastrano blu regolamentare delle truppe transalpine.
Fu così che si coniugò, grazie a questa sovrapposizione, la tradizione garibaldina con quella della Grande guerra. Quando anche in Francia si procedette allo smantellamento dei piccoli cimiteri di guerra, i morti garibaldini fra il 1914 e il 1915 e quelli del corpo di Albricci, vennero composti in un unico grande sacrario, nei pressi di Bligny. Fra le 5.418 sepolture presenti a Bligny, 66 sono quelle appartenenti ai garibaldini del 1914-15.
Il sacrario di Bligny venne inaugurato ufficialmente il 27 giugno 1937 in contemporanea al sacrario transalpino di Pederobba, in provincia di Treviso, che ospita i circa 1.000 caduti di nazionalità francese del fronte italiano, a simboleggiare la interconnessione e la fratellanza del popolo italiano e francese nel primo conflitto mondiale. Da quel momento il pellegrinaggio a Bligny divenne tappa obbligata di ogni tipo di pellegrinaggio di associazioni combattentistiche italiane, comprese quelle garibaldine. Lo confermano le carte dell’Anvrg della sezione di Bologna e diversi scritti provenienti dalla rivista ufficiale dell’associazione (compresa la parentesi Fnvg di Ezio Garibaldi), “Camicia Rossa”. Già nel 1934, quindi prima dell’inaugurazione di Bligny, i “campi di Borgogna” erano stati meta di un grande pellegrinaggio garibaldino a tappe. Una folta rappresentanza di reduci, capeggiati da Ezio Garibaldi, fu ospite per diversi giorni in Francia seguendo un preciso itinerario condito di diversi momenti collettivi della liturgia celebrativa tipica di quegli anni. In primis venne concessa nel cortile degli Invalides, a Parigi, la medaille militaire a tutti i garibaldini presenti, fra i quali anche alcuni emiliano-romagnoli. Seguì una visita all’Hotel de Ville e una sfilata sugli Champs Elysées con passaggio obbligato sotto l’arco di trionfo. Successivamente la cerimonia si postò al cimitero del Père Lachaise, per una visita al monumento ai caduti delle Argonne ivi presente. Il 27 maggio ci si spostò verso la vecchia linea del fronte, a Verdun, luogo simbolo della guerra sul fronte occidentale. Anche qui «entusiastiche accoglienze» e una visita al municipio, al vecchio forte di Douaumount e alla trincea delle baionette: tappe obbligate, tutt’oggi, dei pellegrinaggi francesi al vecchio campo di battaglia. Da Verdun la comitiva si spostò a La Chalade, un piccolo crocevia fra i boschi delle Argonne che funse da epicentro per le operazioni che videro impegnata la legione garibaldina nei tre scontri a cui prese parte (Bois de Bolante, Courte-Chausse e Four de Paris). Qui venne inaugurato il monumento ai garibaldini italiani, riportante le effigi dei due fratelli Garibaldi, Bruno e Costante, che persero la vita nei durissimi combattimenti della legione. Qui avvenne la cerimonia ufficiale, con deposizione di corone e discorsi. Il giorno successivo il gruppo si spostò a Reims e da lì toccò Bligny, luogo già altamente simbolico per la presenza di un cimitero, forma embrionale del futuro sacrario. Il 29 maggio la comitiva riprese la via del ritorno:
Il viaggio di ritorno è avvenuto fra la più viva allegria ed il più sincero cameratismo. I canti garibaldini hanno echeggiato a lungo. Molti camerati rievocavano episodi della guerra indimenticata ed indimenticabile. A tarda notte, canti e conversazioni hanno avuto una sosta. L’adunata delle Camicie Rosse si è sciolta a Torino nella mattinata del 30 maggio [Le Camicie Rosse a Parigi 1934].
Sembra di leggere i resoconti sul pellegrinaggio dei forlivesi al Basso Isonzo. La liturgia dell’evento assomiglia molto, sebbene ci si trovasse in terra di Francia, a quella dei corrispettivi italiani: momenti collettivi, visite a monumenti, scambi di cortesie con le autorità e i gruppi reducistici locali, discorsi accalorati nei quali non mancavano mai i riferimenti alla “più grande Italia” forgiata dal fascismo e da Mussolini.
Anche le manifestazioni garibaldine, quindi, rientrarono all’interno del più grande fenomeno dei pellegrinaggi di guerra architettati e voluti fortemente dal regime, come celebrazione di uno dei momenti fondanti della “nuova Italia fascista”. Spesso poi la presenza dei reduci garibaldini era una costante fissa anche in altri luoghi del fronte dove si svolgevano dette cerimonie. Un esempio su tutti è quello del Podgora. Ve ne sono ampie evidenze ancora una volta nelle carte dell’Anvrg di Bologna. Fra il 10 giugno e il 19 luglio di ogni anno, su questo basso colle di fronte a Gorizia, si svolgevano diversi ritrovi di associazioni reducistiche e combattentistiche per ricordare le battaglie del 1915 che videro impegnata, in particolar modo, la brigata Pistoia (35° e 36° fanteria). Si trattava di battaglie sanguinose, tipiche del primo anno di guerra in cui gli italiani attaccavano ancora con tattiche vetuste ed improprie alla guerra moderna: in sintesi, due veri e propri bagni di sangue. In particolar modo lo scontro del 19 luglio 1915 vide fra i soldati lanciati all’assalto le due compagnie di volontari del distretto di Bologna, comprendenti molti studenti triestini, che si trovavano a Bologna poiché iscritti all’Alma Mater Studiorum, e molti “vecchi” reduci delle patrie battaglie: il già citato Giulio Lavezzari, reduce di Bezzecca, ma anche Ercole Ercolani, reduce addirittura della spedizione dei Mille (con la spedizione Medici, che raggiunse la Sicilia poco dopo lo sbarco di Marsala e i primi scontri), ma anche Ferdinando De Cinque, reduce della campagna garibaldina di Grecia del 1897. Quest’ultimo, sopravvissuto alla Grande guerra, noto avvocato del foro bolognese, dotato di uno splendido eloquio, nonché delle tessere di partito giuste in tasca, fu oratore fisso in quel del Podgora e in molte altre occasioni. Un’altra occasione in cui la tradizione garibaldina si coniugò in pieno con le liturgie fasciste a proposito della celebrazione della Grande guerra tramite i pellegrinaggi sui vecchi campi di battaglia.
Nel secondo dopoguerra, e dopo il conseguente ostracismo verso i pellegrinaggi sui luoghi della Grande guerra, i garibaldini si riappropriarono lentamente di una consuetudine che aveva caratterizzato le loro iniziative da sempre, senza alcuna ingerenza politica. Anche in seno alle varie sezioni si erano con gli anni sedimentate e dimenticate le vecchie fratture. Uno dei più begli esempi di ritorno alla tradizione del pellegrinaggio garibaldino come momento fondante di un corpo militare fra i più singolari e unici del mondo fu quello del 1965, in terra francese, nel cinquantesimo anniversario degli scontri delle Argonne. Vi parteciparono in massa molti dei reduci sopravvissuti, fra i quali anche molti delle sezioni emiliano-romagnole: solo per citarne alcuni, Alfredo Mangano e Guido Bauer di Bologna, Robespierre Capponi e Umberto Danti di Rimini.
L’iniziativa fu a cura dei Vétérans garibaldiens, della Confédération des combattants interallies e della Fraternité garibaldienne, in unione con l’Anvrg. Luogo di ritrovo fu Digione, città carica di ricordi garibaldini relativi anche alla campagna del 1871, con conseguente visita al monumento già citato di La Chalade e al sacrario di Bligny. Sulla via del ritorno tappa anche a Nizza, città natale di Garibaldi e altro punto di raccolta di molti dei volontari repubblicani e garibaldini che erano accorsi in Francia nel 1914 per schierarsi a fianco dei soldati francesi nella guerra contro la Germania.
A fianco di questo imponente ritrovo francese, si riprese con cadenza annuale fin dai primi anni del secondo dopoguerra il consueto viaggio in quel di Caprera, vero e proprio passaggio obbligato della liturgia della memoria garibaldina [2].
Bibliografia
- Associazione Nazionale Combattenti, Sezione di Borgonovo Val Tidone 1932
Pellegrinaggio Sociale ai Campi di Battaglia dell’Alto Vicentino e Trentino, Pasubio, Rovereto, Trento, Altopiano dei Sette Comuni, Monte Grappa, effettuato nei giorni 23-24-25-26-27 maggio 1932 X, Genova-Voltri: Edizioni Giavino - Bagnaresi D. 2011
I pellegrinaggi patriottici nell’Italia liberale. Linguaggi e luoghi, “Storicamente”, 7, 31 DOI: 10.1473/stor110 - Bartolini L. 1930
Il ritorno sul Carso, Milano: Mondadori - Caccia Dominioni P. 1928
La fine del Carso, Alessandria d’Egitto: Tipografia A. Procaccia - Calori A. 2016
L’ora K, Bologna: Edizioni Comitato Memorie di Pietra della Grande Guerra - Capuzzo E. 2018
Turismo sui campi di battaglia in Italia e in Spagna. Due esperienze a confronto (1919-1939), “Eunomia”, VII, n.s., 1 - Capuzzo E. 2019
Non solo pianto e fiori. Turismo sui campi di battaglia della prima guerra mondiale, “Eunomia”, VIII n.s., 2 - Cecchinato E. 2011
Camicie rosse, Roma-Bari: Laterza - Cobòl G. 1922
In pellegrinaggio ai cimiteri di guerra,“Le vie d’Italia”, novembre - Damerini G. 1922
Cimiteri di guerra in montagna, “Le vie d’Italia”, aprile - De Rosa E.M. 2016
La normativa storica tra il 1919 e il 1942: i monumenti ai caduti, ossari e sacrari di guerra, Roma: Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo, Istituto Centrale per il catalogo e documentazione - Flury Nencini B. 1932
Pellegrinaggio degli Orfani di Guerra ai Campi di Battaglia del Medio e Basso Isonzo. 31 Agosto – 1 e 2 Settembre 1931-IX, Livorno: Stabilimento di Arti Grafiche S. Belforte & C. - Gariboldi I. 1924
Le grotte di guerra. Parte I, “Le vie d’Italia”, dicembre - Gariboldi I. 1925
Le grotte di guerra. Parte II, “Le vie d’Italia”, gennaio - Geary P. 2009
Il mito delle nazioni, Roma: Carocci - Isnenghi M. 2010
I luoghi della memoria, Roma-Bari: Laterza - Le Camicie Rosse a Parigi e sui campi delle Argonne e di Bligny 1934
“Camicia Rossa” novembre - Levra U. 1992
Fare gli italiani. Memoria e celebrazione del Risorgimento, Torino: s.n - Marabini C. 1915
La rossa avanguardia dell’Argonna, Milano: Ravà e C. editori - Michelesi R. 1939
Dove riposano gli eroi della Grande Guerra, “Le vie d’Italia”, novembre - Mosse G. 2005
Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Roma-Bari: Laterza - Papa C. 2011
L’Italia giovane, Roma-Bari: Laterza - Rigoni Stern M. 1980
Dove anche l’erba stenta a crescere, “La Stampa”, 17 agosto - Rigoni Stern M. 2006
I racconti di guerra, Torino: Einaudi - Salsa C. 1936
Trincee, Milano: Sonzogno - Senna L. s.d.
Sui campi di battaglia. Il Touring e il turismo di guerra, www.digitouring.it - Stuparich G. 1960
Sull’Altipiano di Asiago, in “Il Tempo”, 6 marzo - Tizzoni E. 2015
Turismo di guerra, turismo di pace: sguardi incrociati su Italia e Francia, “Diacronie. Studi di Storia Contemporanea”, 15, 3 - “Tradotta Forlivese” 1934
numero unico maggio - Winter J. 2014
Il lutto e la memoria. La Grande Guerra nella storia culturale europea, Bologna: il Mulino - Zanelli C.F. 1932
Lassù, Bologna: Edizioni della Rassegna dei combattenti in Bologna - Zanelli C.F. 1965
Sciabole, Milano: Casa editrice Ceschina
Note
1. Il fondo dell’Associazione è conservato presso il Museo civico del Risorgimento di Bologna. In particolare sono stati presi in visione: b. 8, ff. 2, 3; b. 9, f.1; b. 11, ff. 3, 5; b. 20, f. 2.
2. Sui pellegrinaggi del secondo dopoguerra è interessante il materiale conservato nel fondo privato Alfredo Mangano, b. 1, f. Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini (1947-1967) e fondo fotografico, f. 1, sf. 10, Associazione Nazionale veterani e reduci Garibaldini (1958-1965).