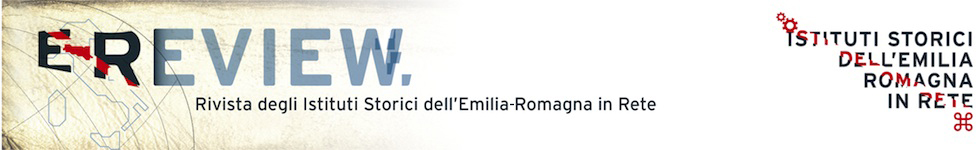Nell’ambito del programma Colonialismo Italiano. Memorie consapevoli [1], al Museo Civico di Modena si è organizzata una visita guidata di cui il presente contributo riprende il titolo, finalizzata a ripercorrere la formazione della raccolta etnologica attraverso la presentazione di oggetti, opere d’arte e d’artigianato riconducibili alla prima espansione coloniale italiana in Africa orientale. Alla visione diretta dei materiali esposti e, tramite un video, di quelli conservati in deposito, l’incontro ha affiancato inquadramenti storici e letture di documenti d’epoca, così da offrire uno spaccato nazionale e locale degli ultimi decenni dell’800, ma anche del dibattito scientifico che ha contribuito a delineare l’identità stessa del Museo Civico, fondato da Carlo Boni nel 1871 con l’intento di accogliere e conservare «tutto quanto interessi l’intera popolazione» [Boni 1879, 2].
Le raccolte che andavano a costituire la nuova istituzione, a partire dalle migliaia di reperti preistorici rinvenuti nel territorio modenese e dalle più significative testimonianze d’arte e d’artigianato, rispondevano a un disegno di fondo unitario che si rifletteva nelle scelte museografiche realizzate da Boni. Esponente della colta borghesia cittadina, risponde alla sua indole liberale e progressista l’adesione alle innovative e rivoluzionarie idee positivistiche ed evoluzionistiche, queste ultime diffuse localmente fin dal 1862 da Giovanni Canestrini, direttore del Museo di Storia Naturale dell’Università di Modena, nonché autore con Leonardo Salimbeni della prima traduzione italiana de L’Origine delle specie di Charles Darwin [Darwin 1864] [2]. Il nuovo pensiero permeava il V Congresso internazionale di Antropologia e Archeologia preistoriche tenutosi a Bologna nel 1871, al quale presero parte antropologi, archeologi, geologi, scienziati e naturalisti di tutta Europa, compreso lo stesso Boni e tramite lui il Museo Civico, con una selezione di materiali delle Terramare. Conferma del suo aggiornamento scientifico, l’apertura al comparativismo, metodo di confronto tra manufatti preistorici e di popolazioni indigene contemporanee, nei cui elementi comuni ritrovare la prova tangibile del cosiddetto «cammino della civiltà».
Nel 1875, lo stesso anno in cui a Roma apre il Museo Nazionale preistorico-etnografico diretto da Luigi Pigorini, Boni inaugura la sezione etnologica che negli anni arriverà a comprendere oggetti provenienti da Nuova Guinea, Africa equatoriale e orientale, Amazzonia e dalla necropoli precolombiana di Ancón in Perù [3]. La formazione di questa raccolta risponde al metodo comparativo abbracciato da Boni, risultando di «somma importanza per noi, che abbiamo la fortuna di possedere tanta ricchezza dalle raccolte preistoriche delle terramare, alle quali con molti legami di intima analogia si avvincono gli oggetti di popoli selvaggi ed i simulacri delle costumanze in uso presso i popoli semi-inciviliti» [Boni 1883, 5-6]. Durante la visita guidata, questo aspetto è stato ritrovato confrontando due gruppi di asce in pietra levigata esposti in Sala 8: le prime appartenenti a popolazioni “primitive” ancora viventi, raccolte da Lamberto Loria in Nuova Guinea tra il 1889 e il 1890, le seconde di età neolitica, provenienti dalla Svizzera e acquistate da Carlo Boni nel 1879.
Per quanto un approccio di tipo positivistico ed evoluzionistico potesse dare adito ad una visione gerarchica di civiltà (Boni parla di popoli selvaggi o semi-inciviliti rispetto alla società occidentale tecnologicamente avanzata), la raccolta etnologica del Museo cresceva all’interno di un pensiero espressamente scientifico, per nulla volto a sostenere o addirittura ad esaltare la coeva politica coloniale italiana. Scrive in proposito Ilaria Pulini:
i criteri dell’esposizione museale si attenevano [...] strettamente ai canoni del museo tradizionale di etnografia: un museo dove, coerentemente con la visione della storia in chiave evoluzionistica, si doveva innanzitutto rendere conto della varietà delle culture umane e del loro livello di progresso sociale e tecnologico […]. Al pubblico che numeroso accorreva a conoscere le novità della sezione africana non si proponevano dunque trofei di guerra, esibizione di una trionfalistica volontà di sopraffazione, ma semplicemente oggetti che raccontavano i modi di vita delle diverse etnie [Pulini 2007, 32].
In merito a questo, la posizione di Boni sulla politica coloniale italiana è in linea con quella dello schieramento liberal-progressista cittadino di cui faceva parte, favorevole ad una espansione economica pacifica e non sostenuta dalla conquista armata [Ruggeri 2007, 11].
Col trasferimento del Museo Civico al Palazzo dei Musei nel 1886, Boni assegnava alle collezioni archeologiche ed etnologiche due sale fra loro contigue. Le poche fotografie d’epoca raffiguranti la sala occupata da queste ultime e i materiali esposti mostrano la medesima tipologia di vetrina che ancora oggi caratterizza l’allestimento museale e il criterio espositivo seriale e classificatorio che si ritrova in diverse raccolte tra cui quella archeologica e quella tessile donata da Luigi Alberto Gandini. Al di là dell’ambiente scientifico, la raccolta etnologica non mancava poi di soddisfare la curiosità dei cittadini, stimolata dalle cronache giornalistiche delle vicende coloniali, oggetto anche a Modena di incontri pubblici e forme di spettacolo popolare [Ruggeri 2007, 22]. Testimonianze della più stretta attualità erano ad esempio l’esposizione della copia autografa di una lettera di Teclà Haimanòt, ras dell’Impero abissino, con cui esprimeva riconoscenza all’ingegnere modenese Augusto Salimbeni per la costruzione di un ponte sul Temcià [Pulini 2007, 29], la documentazione fotografica di luoghi e indigeni abissini donata nel 1887 da Ruggero Valisi [Pulini 2007, 31], ma anche manufatti d’alto artigianato artistico concessi al Museo dal re Umberto I provenienti dai doni di un’ambasciata etiope venuta in Italia nel 1889 per la ratifica del Trattato di Uccialli. Giunti privi di informazioni etnografiche, una selezione di questi doni occupa oggi la vetrina dedicata all’Africa orientale, assieme ad oggetti di fattura povera e di uso comune, ma ricchi di notizie sul loro contesto di provenienza, impiego e denominazioni nelle lingue locali, pervenuti dalla collezione Robecchi Bricchetti attraverso scambi fra Carlo Boni e Luigi Pigorini [Pulini, Zanasi 2008, 103].
Nell’anno in cui Menelik denunciava il Trattato di Uccialli, il 1893, il Museo Civico acquisiva un primo gruppo di steli funerarie incise provenienti dalla necropoli islamica di Dahlak Kebir, sull’omonima isola dell’Eritrea sul Mar Rosso [Oman 1976]. Da lì a pochi anni a queste se ne sarebbero aggiunte altre per un totale di 61 steli, alcune delle quali caratterizzate da suggestive preghiere, lette durante la visita guidata.
Al riordino e ampliamento della raccolta etnologica da parte del successivo direttore Arsenio Crespellani (1897), seguirà un lungo periodo di stasi culminato alla metà degli anni Sessanta del Novecento con la chiusura delle sale ad essa dedicate, mantenutesi tali fino al 1990 quando furono riallestite e aperte nuovamente al pubblico [Pulini, Zanasi 2008, 12]. Nonostante ciò, alla direzione di Matteo Campori si deve l’importante acquisto, nel 1914, di 158 pezzi tra disegni, schizzi e bozzetti realizzati dal giovane pittore concittadino Augusto Valli durante quattro viaggi in Eritrea, Somalia e Etiopia compresi tra il 1885 e il 1896. Numerosi sono i bozzetti, oggi esposti in parte di fronte alla vetrina dell’Africa orientale, che trovano riscontro negli appunti manoscritti dello stesso Valli durante i suoi viaggi, alcuni dei quali letti nel corso della visita guidata. Il suo sguardo su molteplici aspetti della realtà africana sia locale che coloniale, registrati con spirito documentario, non manca di testimoniare l’inasprimento dei rapporti tra l’Etiopia e il Regno d’Italia, degenerati nei tentativi di occupazione da parte di quest’ultimo, tutti tragicamente falliti [Rivi 1984].
A conclusione della visita guidata, si è riflettuto sulle ragioni soprattutto ideologiche, che nei primi decenni del Novecento hanno portato all’acquisizione di manufatti e documenti provenienti dalla successiva espansione coloniale italiana. Emblematici diventano in questo senso i materiali pervenuti non al Museo Civico ma al Museo del Risorgimento, attinenti alla guerra italo-turca, tra cui un manifesto che presenta l’Italia come «trionfatrice e civilizzatrice».
I due istituti, ancora accomunati dalla stessa direzione e continuità espositiva, verranno separati a metà degli anni Venti, così da far progressivamente scivolare il Museo del Risorgimento, riallestito al piano terra del Palazzo dei Musei, nell’orbita della propaganda fascista. L’espansione coloniale in Libia e la guerra d’Etiopia diverranno parte integrante di un percorso espositivo che andava «felicemente incontro non solo a un desiderio di moltissimi cittadini maggiormente attratti verso gli avvenimenti più recenti della storia nazionale, ma anche allo spirito delle ultime direttive del Regime» [4]. Nella vetrina dedicata alla prima stagione del colonialismo italiano, un posto d’eccellenza era occupato dai ricordi del «pioniere modenese», giornalista e scrittore Gustavo Chiesi, morto «nella capitale del negus Menelik il 29 aprile 1909», la cui tomba «rimase ad Addis Abeba – dove essa ancora si trova – segno della fede italiana e presagio d’un luminoso avvenire» [5].
Bibliografia
- Baioni 2011
Massimo Baioni, La città e la memoria patria. Un secolo di storia del Museo del Risorgimento di Modena, in Il Museo del Risorgimento di Modena, a cura di Lorenzo Lorenzini, Francesca Piccinini, Bologna, BUP, 2011, pp. 7-56. - Boni 1879
Carlo Boni, Rapporto biennale sull’andamento del Museo Civico di Modena per gli anni 1877 e 1878, Modena, Tipografia di Paolo Toschi e compagni, 1879. - Boni 1883
Carlo Boni, Rapporto Biennale del Museo Civico di Modena per gli anni 1881 e 1882, Modena, Tipografia di Paolo Toschi, 1883, - Cardarelli, Pellacani, Zanasi 2022
Andrea Cardarelli, Gianluca Pellacani, Cristiana Zanasi, Gli anni modenesi di Giovanni Canestrini, in Sulle tracce di un evoluzionista. Le “cose” di Giovanni Canestrini, a cura di Elena Canedelli, Elisa Dalla Longa, Milano, Editrice Bibliografica, 2022. - Darwin 1864
Carlo Darwin, Sull’origine delle specie per elezione naturale, ovvero conservazione delle razze perfezionate nella lotta per l’esistenza, Modena, Zanichelli, 1864 [traduzione di Giovanni Canestrini e Lorenzo Salimbeni]. - Oman 1976
Le epigrafi del Museo Civico di Modena, a cura di Giovanni Oman, Napoli, Istituto universitario orientale, Dipartimento di studi e ricerche su Africa e paesi arabi, 1976. - Pulini 2007
Ilaria Pulini, Memorie dell’Africa orientale nei musei modenesi, in Modena-Addis Abeba andata e ritorno, catalogo della mostra, a cura di Paolo Bertella Farnetti, Chiara Dall’Olio, Ilaria Pulini, Modena, 2007, pp. 25-38. - Pulini, Zanasi 2008
Guida al Museo Civico Archeologico Etnologico, a cura di Ilaria Pulini, Cristiana Zanasi, Modena, Comune di Modena, 2008, p. 103. - Rivi 1984
Luciano Rivi, Valli pittore africanista, in Augusto Valli (1867-1945), catalogo della mostra, a cura di Enrica Pagella, Modena, Cooptip, 1984, pp. 15-24. - Ruggeri 2007
Rossella Ruggeri, L’Africa orientale nell’opinione pubblica modenese, in Modena-Addis Abeba andata e ritorno, catalogo della mostra, a cura di Paolo Bertella Farnetti, Chiara Dall’Olio, Ilaria Pulini, Modena, 2007, pp. 11-24.
Note
1. Il progetto Colonialismo italiano. Memorie consapevoli è promosso dal Comitato per la storia e le memorie del Novecento del Comune di Modena, Moxa - Modena per gli altri, Centro documentazione Memorie coloniali, Istituto storico di Modena, Museo Civico di Modena e Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e vuole contribuire a non dimenticare i crimini e i costi umani del nostro colonialismo e affrontare un aspetto molto trascurato dalle ricerche storiche: la Resistenza dei patrioti africani agli occupanti italiani. Le visite guidate al Museo Civico realizzate da chi scrive con la collaborazione di Elena Righi sono state svolte sabato 23 marzo con replica sabato 6 aprile 2024.
2. Circa l’adesione di Boni all’evoluzionismo si veda: Cardarelli, Pellacani, Zanasi 2022, 36-37.
3. La sede del Museo Civico in cui si è avviata la raccolta etnologica era presso l’ex convento di San Bartolomeo in via dei Servi.
4. Lettera di Alfonso Morselli, sopraintendente del Museo del Risorgimento di Modena, del 12 febbraio 1937, cit. in Baioni 2011, 43.
5. Il passaggio proviene dalla didascalia della vetrina dedicata a Gustavo Chiesi, nota attraverso una fotografia (Museo Civico di Modena, raccolta del Risorgimento). Nel mutato clima politico del secondo dopoguerra, i materiali d’epoca fascista e delle relative imprese coloniali, assunti a dimostrare la continuità col periodo risorgimentale, vennero rimossi dal Museo [Baioni 2011, 49].