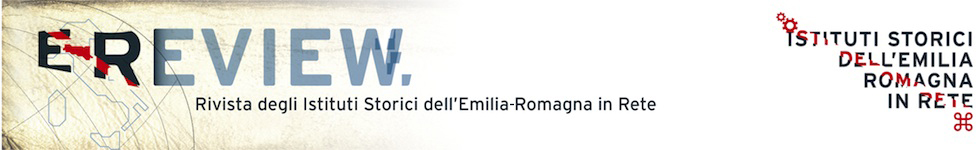Negli ultimi giorni di agosto 2013 si è tenuto a Pievebovigliana, nell'alto maceratese, lo stage estivo dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione delle Marche. Giunto ormai alla VII edizione, lo stage si è trasformato in un appuntamento per studiosi, giovani ricercatori o semplici appassionati: un momento di riflessione comune e un'occasione di ascolto e dibattito.
[[figure width="450px" align="left" caption="Visita al Castello di Beldiletto (Pievebovigliana)"]]./figure/2013/donati/donati_2013_01.jpg[[/figure]] Pur nella loro varietà, i temi trattati in questi anni appaiono legati insieme da un filo rosso: nascondono una continuità di fondo che è ravvisabile nell'attenzione rivolta alla storia della cultura e della musica italiana negli anni successivi al secondo dopoguerra. L’edizione organizzata ad Apiro nel 2003 è stata dedicata a La canzone d’autore e altri generi letterari: nel contesto della cultura degli anni Settanta si discuteva di Pasolini e di Volponi, di De Andrè e degli Stormy Six. Assieme a Massimo Bubola, fra i relatori erano intervenuti il critico letterario Massimo Raffaeli, il poeta anconetano Francesco Scarabicchi e Franco Fabbri, ex Stormy Six e docente di Popular music presso l’Università di Torino. I tre esperti sono stati presenti anche all'appuntamento su Canzone d'autore e Canzone politica del 2010, nel quale i due filoni musicali sono stati ripercorsi attraverso i linguaggi della poesia, della critica letteraria, della critica musicale, della storia e della canzone. L’incontro del 2012 è stato dedicato a Bob Dylan e l'America degli anni '60: oltre a fornire una contestualizzazione del biennio magico del rock (1965-1966), sono stati affrontati la relazione che legò Dylan alla Band, il gruppo che l'accompagnò in importanti progetti musicali, il suo rapporto con Bertolt Brecht, con il beat italiano, con la giustizia, con il movimento pacifista, con la Factory di Andy Warhol e quello tra Dylan e la Bibbia.
[[figure width="450px" align="right" caption="Concerto dei 'Dreamers'"]]./figure/2013/donati/donati_2013_02.jpg[[/figure]]
The dream is over (John Lennon). 1976-1980: la fine dei "lunghi" anni Sessanta è invece il titolo dello stage appena conclusosi. Alla base, la convinzione che il chiudersi degli anni Settanta abbia rappresentato per la storia del nostro paese la fine di un periodo storico contrassegnato da una generale speranza di cambiamento. Si affida alle arti, alla letteratura, alla musica e al cinema l'incarico di raccontare, come le tessere di un mosaico, le trasformazioni vissute dalla società italiana nel corso di un ventennio: dai sogni rivoluzionari culminati nel '68 agli anni di piombo e alla "fine di ogni illusione", di cui i tempi attuali sono ancora eredi.
Attraverso i contributi degli esperti è emersa l'identità collettiva di un paese segnato dall'alternarsi di speranze, traumi e tensioni: lo spaccato di un'Italia repubblicana e del suo continuo costruirsi come nazione, nei quali la storia politica e sociale si legano indissolubilmente alla cultura, che a sua volta si fa storia. Oltre ad essere parte integrante del processo storico e essere a tutti gli effetti agenti di storia, la musica, il cinema, la letteratura e la poesia costituiscono infatti fonti preziose e perfino innovative per la ricerca storica del Novecento. Per molto tempo considerate documenti minori, negli ultimi anni stanno iniziando a trovare il loro modo di "essere mezzo" per la storia. Anzi, al di là delle questioni metodologiche, è ormai avvalorata l'incredibile forza testimoniale che le contraddistingue nella ricostruzione del tessuto sociale, ideologico ma anche politico degli anni Settanta: un periodo storico talmente ricco di documentazione di genere diverso da renderne ardua la percezione complessiva.
1. La Grande storia
A Massimo Papini (direttore dell'Istituto storia Marche) il compito di aprire la riflessione con un contributo sulla contestualizzazione del ventennio 1960-1980 dal punto di vista politico: "Eravamo comunisti". Enrico Berlinguer e la crisi della democrazia. Papini ha voluto fissare la propria attenzione sulla figura di Enrico Berlinguer quale ultimo grande rivoluzionario del Novecento. Formatosi alla scuola marxista, in particolare a quella gramsciana-togliattiana, divenne in poco tempo vice-segretario del Pci, eppure ciò che lo rende un rivoluzionario - nonostante tutti i compromessi e le mediazioni politiche incontrate lungo il percorso - sta nel non aver mai abbandonato fino al chiudersi degli anni Settanta la convinzione che la classe operaia dovesse perseguire come obiettivo storico il superamento del sistema capitalistico. Proprio questa convinzione lo porterà inizialmente a rifiutare con decisione la via della socialdemocrazia, nella quale il compito dei partiti della sinistra rischiava di divenire puramente sindacale e corporativo: migliorare le condizioni d’impiego degli operai all'interno di un sistema del lavoro accettato e non più superabile. È con questa riserva che Berlinguer non ruppe così presto i rapporti con l'Unione Sovietica, come altri appartenenti del partito avrebbero voluto. La conservazione di un equilibrio mondiale, per quanto criticabile, garantiva infatti che almeno in Occidente si potesse mantenere viva la prospettiva di un governo comunista della democrazia. Ma i grandi fermenti e le aspettative degli anni Sessanta, culminati con il '68 e il '69 operaio vengono a poco a poco frenati dal contesto nazionale e internazionale degli anni Settanta: l’attentato di piazza Fontana, la crisi petrolifera, il golpe cileno di Pinochet, ecc. L’opzione di Berlinguer e del suo partito è quella di operare una nuova proposta politica che, pur seguendo la strategia delineata, si adatti alla realtà del nuovo decennio. Da qui la scelta del compromesso storico, inteso come strategia da adottare affinché la classe operaia possa affrontare una serie di nodi irrisolti: primo fra tutti il rapporto tra democrazia e rivoluzione, tra democrazia e socialismo. Berlinguer abbraccia la visione di una democrazia come momento di trasformazione della società. Fonde i concetti gramsciani di unità e di egemonia. Si apre allora una fase esaltante – seppur rischiosa – in cui la classe operaia necessita di alleanze con altri ceti sociali basate sulla comunione di valori (che, nel caso del movimento cattolico, possono essere la pace o la solidarietà). La democrazia progressiva è una fase verso il socialismo, in cui la classe operaia deve lavorare per conquistare il consenso non solo al proprio interno, ma soprattutto all'esterno. La risposta di Berlinguer, geniale ma al tempo stesso molto criticata, è l'austerità. In contrapposizione al sistema capitalistico e alle sue pratiche, il leader del Pci propone un modello di sviluppo che suggerisca alternative concrete allo sperpero e al consumismo individuale, anche in risposta all'emergere della questione ecologica.
Alla fine del 1977 diversi elementi fanno presagire l'imminente ingresso del Pci al governo. Una serie di eventi evidenziano dinamiche di reazione: Bettino Craxi diventa segretario del Psi, le elezioni inglesi sono vinte dalla Lady di ferro, Margaret Thatcher, e Ronald Wilson Reagan diventa il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America. Una nuova emergenza storica è alle porte, mentre il sogno comunista sembra ormai al tramonto.
2. Una generazione in movimento
Dalla Grande storia, per usare le parole di Silvia Casilio (Università di Macerata), si passa alla “piccola storia”: quella del movimento del '77. Il suo contributo, "Piove all'insù". Giovani, movimento e riflusso propone un'originale mappatura – per concetti chiave – dei giovani che militarono nel movimento di quegli anni: la generazione che sembrava avere l'intenzione di rompere definitivamente con tutto ciò che era stato detto durante e dopo il '68.
Il movimento prende le mosse da un'iniziativa del ministro Franco Maria Malfatti, che il 3 dicembre del 1976 emana una circolare che nei fatti smantella la liberalizzazione dei piani di studio, in vigore dal '68. La protesta si diffonde a macchia d'olio coinvolgendo la maggior parte delle università italiane. Accanto agli studenti si schierano gli insegnanti precari, i ricercatori e i borsisti. In poco tempo si mette in moto un processo di ritorno all'università da parte di ex studenti, lavoratori, precari, donne ed emarginati. Le occupazioni si trasformano in gigantesche feste. Ad occupare non sono più i figli di papà di pasolinana memoria, ma una generazione il cui connotato fondamentale sembra essere la precarietà, sia da un punto di vista occupazionale che esistenziale, visto che anche in quegli anni la disoccupazione appare dilagante fra i giovani dai 15 ai 25 anni. Si tratta del cosiddetto «fronte del rifiuto»: agli studenti che protestavano per la riforma si aggiungono i freak, i disperati, tutti quelli che la città aveva spinto ai margini.
La continuità è ravvisabile, più che con la generazione del '68, con i “capelloni” che tra il '66 e il '67 animavano la scena politica, sociale e contro culturale italiana. Definiti con disprezzo dalla stampa dell'epoca "zazzeruti" o "barbudos", in realtà si proponevano come magma di soggetti diversi uniti dalla comune opposizione all'establishment e al sistema costituito. Si presentavano come movimento svincolato da ogni forma di controllo, impossibile da irreggimentare all'interno di un partito e incompatibile con qualsiasi regolamentazione della conflittualità. Gli strumenti di cui affermavano si sarebbero serviti erano le feste, l'assunzione orgogliosa delle devianze e la riscoperta del corpo – tematiche care anche al movimento femminista di quegli anni. Fuggendo da disquisizioni erudite, si proponevano di coniugare partecipazione politica e vissuto quotidiano. Sessualità, riappropriazione del tempo libero, antipsichiatria e rifiuto del lavoro erano alcune delle tante questioni della scena politica e contro culturale italiana in cui si mossero i cosiddetti soggetti "non garantiti".
Fu un movimento contraddittorio che, a detta di Casilio, si espresse parallelamente in «festa e azione, ansia di fare e violenza, gioco e morte». Altre parole chiave che lo rappresentano sono: il silenzio assordante, la rottura con il '68 e la sperimentazione. Quello del '77 era difatti un movimento che non voleva far parlare di sé. Non a caso, anonimi estensori di Bologna nel marzo di quell’anno scrivevano: «Non esisterà uno storico, non tollereremo che esista uno storico». Nonostante ciò il movimento del '77 fece parlare enormemente di sé storici, sociologi e politologi. Alberto Asor Rosa sostenne che quei giovani, "la seconda società", si stessero semplicemente preparando a sferrare un colpo mortale contro "la prima società", quella dei padri. Genitori produttivi e garantiti, ma incapaci di estendere ai propri figli i diritti di cui loro stessi avevano goduto. La difficoltà di raccontare il '77 – secondo Casilio – sta proprio nella criticità di rapporti instaurati con il Pci, che non tardò a bollare il movimento come anticomunista, quando la sua natura era in realtà violentemente e radicalmente antipartitica.
Il movimento del '77 segna una frattura, parte dal '68 e rompe con il '68, segna la fine della teoria del soggetto rivoluzionario per lasciare posto ai "mille soggetti", segna la crisi pratica della "forma partito" come forma di organizzazione; dalla crisi dei "gruppi" riaffiora la povertà della politica e la ricchezza della vita, dalla fine della militanza emerge l'iniziativa autonoma su pratiche specifiche. Mille gruppi, mille forme di organizzazione adeguate alle pratiche di appropriazione e, tra queste, un terreno della riappropriazione, quello dell'informazione. Sul terreno dell'informazione il movimento scopre la possibilità di approfondire la crisi della forma partito e inventa nuove funzioni di organizzazione [da un volantino del novembre 1977].
3. Con gli occhi degli italiani
Rispetto alla "piccola storia" appena ripercorsa, quella che ha proposto Annacarla Valeriano (Università di Teramo) può essere invece definita una microstoria per immagini. Con Gli anni '70 degli "altri". Gli home movies raccontano la relatrice ha, infatti, condotto il pubblico all’interno della vita privata delle famiglie dell'entroterra teramano degli anni Settanta. Davanti a noi il video di un tipico matrimonio abruzzese il cui racconto si dispiega attraverso filmini famigliari alternati a immagini pubbliche. In primo piano molti elementi della tradizione: in particolar modo l'esposizione dei regali di nozze, nella loro varietà e ricchezza. Spiccano i volti delle persone, volti antichi segnati dal tempo e dal lavoro. Le continuità con un passato immutabile sono evidenti, soprattutto rispetto ai pochi elementi di trasformazione: le acconciature dei capelli, i pantaloni a zampa d'elefante e il corteo di auto che accompagna gli sposi. I protagonisti del filmato hanno alle proprie spalle il contesto politico e sociale descritto in precedenza: il protagonismo dei giovani, una società che stava cambiando e in parte era già cambiata grazie all'affermarsi dei movimenti, uno spirito di innovazione che vedeva la permanenza di elementi arcaici in determinati contesti nazionali quale simbolo di arretratezza sociale e culturale. Eppure le immagini mostrano con chiarezza che in alcuni ambienti le istanze di cambiamento provenienti dalla società vengono assorbite molto lentamente: le rivoluzioni esterne entrano nelle case senza scalfire del tutto le pratiche preesistenti.
Secondo Valeriano c'è un elemento che accomuna i protagonisti dei movimenti collettivi e i protagonisti delle riprese famigliari: la volontà di legittimare la propria presenza sulla scena. I primi lo fanno aderendo ai movimenti, agendo in prima persona, impegnandosi direttamente per cambiare le cose, conquistando il diritto di parola grazie al proprio impegno sulla scena pubblica. Allo stesso modo, i secondi legittimano la propria presenza all'interno della memoria della famiglia mostrandosi alla cinepresa che, di fatto, si trasforma in uno strumento di reificazione dei valori famigliari.
La compresenza di tradizione e innovazione nelle rappresentazioni private sembra connotare gli interi anni Settanta. I filmati presentati mostrano la vita di piccoli paesi in cui il tempo sembra essersi fermato: si susseguono immagini di raduni in piazza o intorno al fontanile pubblico, di lavori agricoli o artigianali e di processioni religiose. Al contrario, l'adesione al progresso e alle trasformazioni è testimoniata soprattutto dagli interni domestici, dove l'interesse viene rivolto ai segni del benessere: televisione, apparecchio telefonico, complementi d'arredo.
4. Cinema e società
Dagli home movies al cinema italiano. Ad affrontare l’argomento è Luisa Cigognetti (Università di Bologna) con un contributo dal titolo Il cinema italiano finisce con gli anni '70? Da Ecce bombo a Ginger e Fred, che descrive la seconda metà degli anni Settanta come momento cruciale anche nel rapporto tra cinema e società italiana.
Dal dopoguerra al 1970 l'industria cinematografica italiana ha costituito, infatti, un sistema ineguagliabile a livello mondiale, composto da professionalità sorprendenti: registi, montatori, cameraman, musicisti, doppiatori. La grandezza dei film prodotti trova gradimento non solo all'estero, ma soprattutto in patria, dove fino alla metà degli anni Settanta ci si reca al cinema in media più di dieci volte l'anno. Tuttavia nell'arco di un decennio il numero di spettatori diminuisce sorprendentemente di circa due terzi. Mentre nel 1982 l’Italia perde la prerogativa - fin ad allora mantenuta - di occupare almeno uno dei primi posti della top ten internazionale: a sfondare il mercato, per la prima volta, è un film americano (E.T.). Dieci anni dopo solo quattro produzioni italiane entreranno tra i primi venti film più visti dell'anno e il mercato apparirà ormai completamente cambiato.
Il neorealismo aveva a lungo rappresentato un modello a livello internazionale e gli autori cinematografici degli anni Cinquanta e Sessanta – De Sica, Antonioni, Rossellini, Visconti, Pasolini – erano celebrati in tutto il mondo. Ad unire la loro arte, un sogno comune: fare del cinema lo strumento per raccontare la società, con le sue amarezze, speranze e fallimenti. Con la fine degli anni Settanta questa formula sembra, però, non bastare più al pubblico italiano. Troppo semplice attribuire la responsabilità del cambiamento esclusivamente all'entrata in scena della macchina televisiva. Tanto più che, diffusasi nelle case degli italiani dagli anni Cinquanta, non influisce sul cinema fino almeno al '75. Le radici della crisi sono più complesse: tra il '74 e il '76 le frequenze televisive vengono liberalizzate e nascono le tv private. Nel settembre del 1974 viene fondata da Giacomo Proporzi Tele Milano Cavo, che comprata due anni dopo da Silvio Berlusconi già nel 1980 assumerà il nuovo nome di Canale 5. Con la nascita della tv commerciale ci si trova di fronte a una vera e propria "rivoluzione estetica": la cura dell'immagine perde significato mentre l'attenzione risulta completamente assorbita dalle storie da raccontare, mortificando l’eredità della tecnica cinematografica neorealista che aveva negli anni precedenti reso grande l'Italia nel mondo.
5. Riflessi di letteratura
La crisi degli anni Settanta, una crisi morale ed esistenziale oltre che economica e politica, è anticipata e trova voce nel mondo della letteratura. L’intervento di Francesco Scarabicchi (poeta) su L'ultimo Pasolini ha messo in luce l’importanza dell’analisi della figura di Pier Paolo Pasolini quale snodo fondamentale per "abbracciare" fino in fondo il trapasso dagli anni Sessanta agli anni Settanta. Trasumanar e organizzar è la sua ultima raccolta di poesie, uscita nel 1971: in quei versi traspare una sofferente e al tempo stesso aggressiva denuncia rispetto alla contemporanea difficoltà di "trasumanar", cioè di uscire dalle condizioni umane date. Il suo sguardo è quello di un bambino ingenuo e innocente che guarda il fondo della voragine e non ne vede la fine. Non è un veggente, né un visionario. Ma come tutti i classici coglie le costanti della vita sociale ed esistenziale, politica e civile. Che cosa vede rispetto al presente? Tutta la linea del passato, senza il quale quel presente non sarebbe e tutta la linea del futuro, cioè quello che quel presente sarà. Nell'ultima intervista rilasciata prima di morire, Pasolini non si dilunga in disquisizioni letterarie, ma racconta la realtà, nuda e cruda, come da anni faceva sulle pagine del “Corriere della Sera” e di altri periodici. Conclude con una frase dura e incontrovertibile: «Io scendo all'inferno tutte le sere e so che l'inferno sta salendo tra voi». Era il 4 ottobre del 1975.
Le parole di Pasolini si legano a quanto affermato da Calvino, attraverso il personaggio di Marco Polo, nelle ultime righe di Le città invisibili: «L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio».
Pubblicato nel 1972, è uno dei grandi capolavori di Calvino affrontato da Michela Meschini (Università di Macerata) nel suo contributo su Letteratura e postmodernità.
Il postmodernismo non si presenta come un movimento o una scuola unitaria, bensì un dibattito a più voci, a volte simili, a volte contrastanti. L'oggetto della discussione è la contemporaneità, la società moderna, il mondo degli ultimi 50 anni. Nato in Europa, ma sviluppatosi nell'ambito accademico statunitense, nel corso degli anni si è arricchito di prospettive spaziando in tutti i campi del sapere. Fra i suoi teorici più famosi, il filosofo francese Jean-François Lyotard per il quale la postmodernità è una condizione postuma, che ha trovato ragione d'essere dopo la fine delle grandi narrazioni, dei grandi racconti: marxismo, socialismo, liberalismo. Nel suo La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere (1979), pietra miliare del dibattito, Lyotard dichiara che i metaracconti sono l'emancipazione progressiva della ragione e della libertà. Essi hanno una pretesa di validità universale e promuovono in genere un progetto politico, sociale, economico che ruota attorno a degli ideali (uguaglianza, giustizia, lavoro, libertà, ragione, ricchezza), dando senso alla nostra vita. Legittimano la fiducia nel progresso, nella crescita, nell'emancipazione e nel miglioramento dell'uomo, salvo poi disattendere tutto questo, perché non è l'assenza di progresso ma lo sviluppo tecnico, scientifico, artistico, economico e politico che ha reso possibile le guerre mondiali, i totalitarismi, la disoccupazione, la “deculturazione” generale. La fine dei metaracconti è segnata da un evento preciso: la progettazione e la realizzazione di un non-luogo come Auschwitz. La fiducia in un progresso lineare e illimitato viene definitivamente meno.
Nel postmoderno domina al contrario il senso del limite, della complessità, della molteplicità e della relatività delle conoscenze.
Le città invisibili (1972), Il castello dei destini incrociati (1973), Se una notte d'inverno un viaggiatore (1979), Palomar (1983), Lezioni americane (pubblicato postumo nel 1988) sono tutte opere la cui struttura si basa sulla «rete dei possibili»: l'idea della molteplicità si traduce in scrittura come «rete di connessione tra i fatti, le persone e le cose del mondo». Le città invisibili sono costituite da 55 frammenti di città, corrispondenti ciascuno a un'immagine di città fantastica. Non c'è un vero ordine di lettura, non c'è una cronologia, un rapporto logico fra di esse. Il lettore si trova a viaggiare in uno spazio che i teorici della postmodernità definiscono "eterotopico", cioè senza margini e senza centro. Uno spazio percorribile in direzioni multiple, dove nulla è certo e dove le verità diventano delle semplici interpretazioni, senza nessuna validità. A regnare è la dialettica degli opposti: dentro e fuori, bene e male, felicità e infelicità, desiderio e paura. Quello che potrebbe sembrare un ozioso gioco linguistico, uno sperimentalismo fine a se stesso, a un esame più approfondito nasconde invece molto di più. Dietro alla formalizzazione astratta di città-labirinto, città concentriche o filiformi, in cui l'elemento umano sembra scomparso, si cela una forte tensione etica, diretta proprio a valorizzare l'esperienza umana dell'essere nel mondo, dell'essere nella storia.
6. La disillusione si fa musica
L'ultimo contributo di Emanuele Mochi (Istituto storia Marche) è dedicato al mondo della musica: "E a un Dio a lieto fine non credere mai". De Andrè e Gaber alla fine del sogno.
Entrambi gli artisti hanno vissuto personalmente le aspirazioni e le speranze di una generazione che credeva di poter cambiare il mondo, di trasformarlo in un luogo in cui fossero promosse le differenze e al tempo stesso riconosciute le uguaglianze. La disillusione scaturita dal fallimento di queste aspettative, a loro volta risucchiate da una dilagante omologazione al modello capitalista americano, rivive nelle loro canzoni.
Alla fine degli anni Sessanta Gaber lascia il mondo televisivo e porta la canzone nei teatri di tutta Italia. Nel 1976 – insieme all’amico pittore e coautore Sandro Luporini – dà vita ad uno spettacolo completamente nuovo, in cui il genere del "teatro canzone" tocca il suo apice: Libertà obbligatoria.
Al centro il tema del rapporto tra individuo e società: il sistema capitalistico si è talmente infiltrato nella quotidianità da modificare nell'individuo la coscienza del proprio corpo e dei propri bisogni. Nelle note di copertina, la denuncia verso la dilagante crisi culturale e sociale appare inequivocabile: «Quello che sembrava fosse un inarrestabile processo rivoluzionario sul piano delle coscienze, prima che su quello storico e politico, comincia a mostrare i suoi limiti, le sue incertezze, i suoi tentativi un po' patetici di nascondere contraddizioni sempre più evidenti. L'appiattimento dell'individuo preconizzato dai vari Adorno e Marcuse è qui presentissimo. Si comincia ad avvertire un senso di impotenza, di incapacità a contrapporre istanze diverse al modello americano e alla sua trionfale avanzata. Si percepisce il disagio di una sconfitta collettiva che ci ostiniamo ancora a non voler riconoscere come tale».
La presa d'atto più dolorosa è quella di vedere il fallimento allo specchio, riflesso nella propria immagine, che suscita l’amarezza e l’incredulità descritta ad esempio nel testo di Quando lo vedi anche. Anche l’album Rimini, cui De Andrè lavora insieme al suo coautore Massimo Bubola, nasce dalla delusione politica per le vicende degli ultimi anni Settanta. La città romagnola è la meta estiva della medio-piccola borghesia di quegli anni: uomini e donne il cui status sociale appariva garantire popolarità e rispetto, ma anche divertimento e frivolezza. Tutte le canzoni del disco – per prima quella di apertura – ripercorrono infatti la medesima struttura narrativa: fiducia nel futuro, impatto con la storia, fine del sogno, dando voce alla storia di un'intera generazione.
In definitiva le rappresentazioni presentate nel corso dell’incontro – ognuna specchio di un diverso universo artistico e culturale, seppur parziale e frammentario – hanno saputo disegnare nel loro insieme un affresco della società degli anni Settanta, permettendo al pubblico di assaporare un’immagine vivida del nostro “passato prossimo”.
Programma Stage estivo 2013 – Istituto storia Marche (.pdf)
Risorse
- Storia Marche Novecento – Video dello stage estivo 2013 (versione integrale)
- http://www.storiamarche900.it/main?pp=Stage_Thedreamisover
- Radio Alice
- http://www.radioalice.org
http://www.raistoria.rai.it/categorie/speciale-radio-alice/303/1/default.aspx
http://radio.rcdc.it/programmi/radio-alice-archivi-audio - Home Movies – Archivio nazionale dei film di famiglia
- http://www.memoriadelleimmagini.it/homemovies
- Quando lo vedi anche (1976) – Giorgio Gaber
- http://www.youtube.com/watch?v=NsQ3j4GU9ZY
- Rimini (1978) – Fabrizio De Andrè
- http://www.youtube.com/watch?v=_ctTDpIOh7c
- Riprese e montaggio video a cura di Chiara Donati.