1. Introduzione
In quest’ora carica di eventi, mentre col pretesto della pace in Africa si semina la guerra in Europa; mentre si tenta di soffocare colla violenza le giuste aspirazioni che, a parole, si riconoscono al nostro Paese, l’iniqua unione di tutti gli Stati contro l’Italia ha rinsaldato e deve sempre più rinsaldare l’incrollabile unione di tutti gli Italiani col loro Governo [1].
Con queste parole il vescovo di Parma, monsignor Evasio Colli, nel novembre 1935 incitava i fedeli della diocesi a rimanere saldi nella lotta per le «giuste aspirazioni» della patria, contro «l’iniqua unione» degli stati che avevano posto l’Italia sotto “assedio”. Quello di Colli era un appello ufficiale, intitolato Il dovere dell’ora attuale e pubblicato su «L’Eco», il bollettino ufficiale della curia parmense, ma dato alle stampe in anticipo sul «Corriere Emiliano», il principale organo d’informazione della provincia.
Il breve estratto (sull’appello si tornerà nelle prossime pagine) mette ben in luce la piena assonanza del linguaggio del vescovo con quello della propaganda di regime, soprattutto nel definire la guerra d’Etiopia un conflitto giusto e necessario, ma anche nel sottolineare la fondamentale occasione per «rinsaldare l’incrollabile unione» del popolo con il governo. Un appello che rimane espressione emblematica di quella fusione lessicale nazionalista cattolica e fascista, che segnò molte diocesi italiane nel 1935-1936.
L’obiettivo di questo contributo è quello di analizzare come il vescovo Colli diventò un elemento cardine del meccanismo di legittimazione della guerra d’Etiopia nella provincia, partecipando attivamente alle cerimonie politiche organizzate dagli organi locali del regime. In particolare, si tratterà del periodo compreso tra il maggio 1935, quando partirono due battaglioni di camicie nere in Africa orientale, e l’agosto 1936, quando quegli stessi legionari fecero ritorno in città, accolti trionfalmente dalla popolazione e dalle autorità. Al centro di questo arco temporale trovano spazio gli eventi del conflitto, come la mobilitazione generale (2 ottobre 1935), l’inizio delle sanzioni (18 novembre 1935), la Giornata della Fede (18 dicembre 1935), la conquista di Addis Abeba (5 maggio 1936) e la proclamazione dell’Impero (9 maggio 1936) [Del Boca 2010; Labanca 2015].
Per quanto concerne le fonti si concentrerà lo sguardo sul «Corriere Emiliano», il mezzo di comunicazione principale per la provincia durante tutto il Ventennio e che fornisce un punto di vista privilegiato per comprendere in quale modo il vescovo venne inglobato nella propaganda di regime. Inoltre, i documenti ufficiali della diocesi, come il già citato «L’Eco» e le lettere pastorali, sono fondamentali per focalizzare al meglio il pensiero di Colli, ma anche gli atteggiamenti delle diverse comunità parrocchiali. Non sono mancate incursioni all’Archivio apostolico Vaticano, all’Archivio di Stato di Parma e all’Archivio storico diocesano.
Come si tenterà di dimostrare, il legame tra vescovo e propaganda fu un processo complesso, non riducibile alle mere (e disagevoli) categorie di “filofascismo”, “clerico-fascismo” e “consenso” [Riccardi 1981; Corner 2015]. Esso affondava le proprie radici nei complicati rapporti tra cattolicesimo italiano e Stato [Moro 2020], ma anche nell’onda lunga dell’entusiasmo suscitato dal Concordato, nel contesto dei più ampi atteggiamenti del mondo cattolico [Canavero 1991; Dau Novelli 1994; Preziosi 1996] e negli stilemi pastorali tipici delle gerarchie ecclesiastiche di inizio Novecento [Battelli 1986; Cremonesi 1999, 68-75].
Osservare quale postura assunse il vescovo verso le sanzioni economiche, la Giornata della Fede e la proclamazione dell’Impero si rivela di notevole interesse per l’analisi dei miti posti alla base dell’esperienza etiopica, non solo in chiave nazionale, ma anche locale. I combattenti in partenza per l’Africa, ad esempio, vennero più volte definiti dai gerarchi e dallo stesso Colli come i degni eredi di Alessandro Farnese. La figura del terzo duca di Parma che partecipò alla battaglia di Lepanto assurse a vero e proprio mito legittimante della campagna d’Etiopia, uno strumento utilizzato scientemente e costantemente per enfatizzare ed eroicizzare, in chiave nazionalistica e cattolica, il ruolo delle camicie nere della 180° legione, non a caso, appunto, intitolata al condottiero farnesiano. L’intreccio sincratico del linguaggio religioso e politico segnò profondamente non solo l’approccio dei fedeli alla guerra, ma costituì anche un tornante decisivo per il sostegno al regime da parte del clero locale e delle stesse comunità parrocchiali che pochi anni dopo avrebbero dovuto far fronte al secondo conflitto mondiale.
2. Monsignor Evasio Colli e la Diocesi di Parma nel 1932-1935
Nato a Lu (Alessandria) nel 1883, Evasio Colli fu ordinato sacerdote nel 1905, nella cattedrale di Casale Monferrato. Per diversi anni insegnò al seminario della sua diocesi, mettendo a frutto la laurea in diritto canonico e civile conseguita a Roma e, dal 1915 al 1927, fu prevosto e vicario forense di Occimiano [Cocconi 2020, 9]. Pertanto, il futuro vescovo di Parma si formò integralmente all’ombra del seminario, un’istituzione segnata da una forte identità claustrale e che doveva preparare i sacerdoti alla consacrazione all’altare all’insegna dell’obbedienza verso l’autorità costituita e alla gerarchia, senza concessioni al “modernismo” della società contemporanea [Boggio Tomasaz 1998, 106], in un clima antiliberale più vicino agli stilemi di antico regime che a quello di inizio Novecento [Scoppola 1978, 205]. Oltre a ciò, negli ambienti formativi ecclesiastici la carità era declinata prima di tutto come un percorso di perfezione spirituale personale e non tanto come un’apertura ai bisogni materiali della comunità [Arnold, Vian 2010]. In altre parole, Colli era ben lontano da quegli ambienti in cui, sulla spinta della Rerum Novarum (1891) di Leone XIII, stavano maturando le istanze del cristianesimo democratico e sociale e che avrebbero segnato il pensiero, per limitarsi a due esempi, di don Romolo Murri e di don Luigi Sturzo [Guccione 2019]. Così come era lontano dalla sensibilità verso la questione sociale che proprio in quegli anni stava definendosi, per citare un altro esempio, nell’operato di monsignor Guido Maria Conforti, dal 1907 a capo della Diocesi di Parma [Bonardi 1997].
Tuttavia, Colli dimostrò doti intellettuali e capacità pastorali non comuni: diresse il giornale diocesano, riorganizzò l’Azione cattolica (Ac) locale e fu decorato con la medaglia d’argento dei benemeriti della Pubblica istruzione. Nel 1923 divenne presidente della Giunta diocesana e nel 1926 ricevette il titolo onorifico di cameriere segreto soprannumerario di Pio XI. In questo senso non sorprende che, dopo 12 anni di servizio ad Occimiano, Colli venne eletto vescovo di Acireale (Catania), dove avrebbe lasciato un ricordo indelebile per l’aiuto fornito alla popolazione dopo l’eruzione dell’Etna del novembre 1928 [Patanè 2015]. Rimase al vertice della Diocesi siciliana sino al 1932 quando venne trasferito a Parma, in seguito alla morte di Conforti [2].
La Diocesi emiliana contava circa 290.000 abitanti, 338 sacerdoti secolari, 308 parrocchie e 222 alunni in seminario (minore e maggiore) [3]. Nei primi vent’anni del Novecento gli ambienti ecclesiastici parmensi avevano vissuto una considerevole vivacità pastorale e politica, grazie all’opera di una parte del clero e dello stesso Conforti [Campanini 1995]. Inoltre, vi era un laicato in gran parte vicino alle istanze del cristianesimo sociale, e che era stato in grado di esprimere una figura del Partito popolare italiano (Ppi) di primo piano a livello nazionale, come il deputato e ministro Giuseppe Micheli [Truffelli, Vecchio 2002]. Dopo dieci anni di regime certamente la Chiesa cattolica rimaneva in provincia l’unica istituzione “alternativa” al regime, ma di quella vivacità conosciuta a inizio secolo rimaneva poco: i popolari erano ridotti al silenzio (in parte attivi nell’Azione cattolica) [Trionfini 1998], mentre nel clero non si registrava la presenza di elementi di particolare vivacità intellettuale, eccezion fatta per don Giuseppe Cavalli [Bonardi 2004].
Quando Colli fece il suo ingresso in città, si approcciò ai fedeli e ai sacerdoti in maniera del tutto tradizionale, in linea di continuità con quei valori che ne avevano segnato la formazione e gli anni di ministero. Nella sua prima lettera pastorale, scritta prima dell’arrivo a Parma, Colli affermò che era «nell’ombra e nel silenzio dell’ubbidienza e della preghiera – ammonisce Pio X – che maturano le opere meravigliose di Dio» [Colli 1932; Colli 1956, 18]. L’obbedienza, intesa come la sottomissione alla gerarchia e il rispetto della disciplina verso l’autorità costituita, insieme alla preghiera, definita come l’aspetto più alto della carità, sarebbe stata richiamata costantemente durante tutto il suo episcopato e, come si avrà modo di vedere, avrebbe costituito uno dei pilastri del lessico utilizzato nel 1935-1936 [Riccardi 1996, 523-524].
Guardando al versante fascista, la stampa locale diede ampio spazio all’arrivo del nuovo ordinario. Se il solenne ingresso avvenne l’11 settembre 1932 [4], già dal maggio precedente il «Corriere Emiliano» aveva tessuto le lodi del presule, utilizzando una retorica del tutto in linea con la trionfalistica propaganda seguita al Concordato del 1929 [Moro 2020, 133-168]. Stando al quotidiano, Colli era un autentico eroe dell’antisocialismo, avendo vissuto a lungo nelle comunità contadine piemontesi. In particolare, prendendo a pretesto la descrizione dei suoi primi anni di sacerdozio, svolti nella parrocchia di San Germano di Casale Monferrato, così si espresse il quotidiano parmigiano:
Egli scende in mezzo alle masse rurali, attossicate dal socialismo invadente, a prodigarvi con generosità, le doti e i tesori della sua mente e del suo cuore.
[…] Benvenuto egli sia dunque a capo della nostra illustre Diocesi, due volte millenaria; benvenuto in questa nostra città cristiana e patriottica, fiera ed ospitale, cui il Fascismo rinnovatore, guidato dal Suo Grande Capo, ha additato – fusione perfetta d’ogni dovere cristiano e civile, – l’indissolubile binomio: Dio e Patria [5].
L’articolo mette bene in luce quanto fosse in atto il processo di nazionalizzazione del cattolicesimo italiano anche nella stampa locale. Il Concordato aveva messo fine a 70 anni di difficile convivenza tra Santa sede e Regno d’Italia e il generale entusiasmo da esso suscitato, a poco più di tre anni di distanza, era ben lungi dall’essere dimenticato ed era funzionale a costruire l’immagine di un regime totalmente sostenuto anche dal clero, soprattutto nella lotta al comunismo, alla massoneria e al liberalismo [Moro 2020]. Accostare, inoltre, l’operato dei vescovi a quello del «Grande Capo» era parte di quel sincretismo del linguaggio religioso e politico che era sostanziale all’ideologia fascista [Gentile 2008].
Lo stesso Colli, già nei primi giorni d’insediamento, non esitò ad utilizzare gli artifici retorici fatti propri dal regime. Già quando era arciprete di Occimiano aveva prestato molta cura nell’organizzazione dell’Ac e l’unico incidente diplomatico avvenuto con il Partito durante il suo episcopato ad Acireale si verificò nel 1931, proprio in seguito al tentativo del regime di chiuderne i circoli [Patanè 2012]. Non sorprende, dunque, che già l’8 ottobre Colli indirizzò alla Diocesi un messaggio sull’importanza dell’Ac nelle parrocchie:
La diocesi che mi vede andare nelle parrocchie a fare la propaganda dell’Azione Cattolica non si meraviglierà se, anche da questo foglio, bandisco la santa Crociata della Milizia volontaria di Cristo Re. Non amare l’Azione Cattolica significa essere egoisti – e quindi di spirito non cristiano – significa non amare il Papa che la vuole; significa disinteressarsi dell’avvenire religioso della nostre parrocchie. Ostacolare l’Azione Cattolica significa ostacolare l’opera di rinnovamento spirituale del Governo Nazionale che l’Azione Cattolica solennemente riconosce [6].
Certamente il linguaggio “militarista” in ambito cattolico non era un aspetto inaugurato nel corso del Ventennio [De Giorgi 2002] e già nel 1929 (prima del Concordato) Colli aveva definito l’Ac un «esercito», parlando dei suoi membri come dei «militi» e i mancati iscritti come dei «disertori» e «imboscati» [Triani 1981, 34-44].
I riferimenti alla «santa Crociata» e all’Ac come una «Milizia» erano anche un chiaro riferimento all’antico frasario legato agli ordini monastico cavallereschi. Certo è che nello scritto di Colli è evidente il salto di qualità avvenuto dopo il 1929: l’assonanza della «Milizia volontaria di Cristo Re» con la milizia volontaria per la sicurezza nazionale non poteva essere casuale e, poche righe dopo, venne reso esplicito che militare nell’Ac significava concorrere all’opera di «rinnovamento spirituale del Governo Nazionale». Essendo quella di Colli una lettera aperta, pubblicata su «Vita Nuova», non è da escludere che quelle parole fossero più indirizzate alle autorità locali che ai fedeli. Dopo i duri scontri tra Chiesa e regime nel 1931, per Colli presentare l’Azione cattolica come un elemento d’ordine, in tutto e per tutto allineato agli obiettivi del governo, poteva tornare certamente utile per costruire un ambiente a sé favorevole, ma anche per disambiguare la propria spiccata predilezione verso l’associazionismo laico che avrebbe segnato tutto il suo episcopato, specialmente nella fase critica d’inizio insediamento, quando era bene che tutto contribuisse a generare un clima disteso con i vertici della vita amministrativa e politica locale.
Oltre a ciò, poco prima del suo ingresso in città, Colli aveva fatto pervenire un’offerta personale di 4.000 lire a diverse organizzazioni caritative della Diocesi, premurandosi di destinare altre 1.000 lire all’Ente opere assistenziali della Federazione provinciale fascista, un gesto che non passò inosservato alla stampa [7]. Era evidente il tentativo, da parte del nuovo vescovo, di aprire e mantenere pacifici canali comunicativi con le altre autorità, testimoniato sia dalle donazioni personali, che indicavano quanta considerazione egli avesse per gli enti del Partito, sia dal definire l’Ac come uno strumento di quel «rinnovamento spirituale» promosso dal duce. Non era un gesto di sottomissione del vescovo verso il regime: la lettera su «Vita Nuova» era anche espressione della volontà di difendere le proprie prerogative da ingerenze esterne. Con ogni probabilità Colli riteneva i gesti di apertura verso le altre autorità come parte del suo dovere da ordinario, soprattutto dopo che “l’uomo della Provvidenza” aveva sanato i rapporti del Regno con la Chiesa cattolica: è noto quanto il giuramento di fedeltà allo Stato (non più laico) da parte dei vescovi previsto dai Patti lateranensi rafforzò il senso di obbedienza dei presuli all’autorità costituita [Nobili 2008, 267]. In quello stesso 1932 l’arcivescovo di Bologna, cardinale Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano, al pranzo con le autorità in occasione del concilio plenario emiliano-romagnolo aveva affermato l’esistenza della «perfetta armonia» tra potere civile ed ecclesiastico, dovuta alla condivisione di ideali con il regime [Menozzi 1997, 343-347]. In altre parole, la posizione di Colli e di gran parte dell’episcopato metteva in luce quello che Giorgio Campanini ha definito il «vizio di fondo» di parte del cattolicesimo italiano novecentesco: ragionare dalle istanze della religione in direzione della politica, secondo una pratica propria all’antico regime, rendeva impossibile utilizzare strumenti adatti per comprendere la complessità del fascismo [Campanini 2016].
Le parole e i gesti di Colli erano anche espressione di un genuino desiderio di apparire un interlocutore affidabile agli occhi delle altre autorità, motivato dalla sincera convinzione che l’opera del regime concorresse a costruire un’Italia cattolica. Anche quest’ultimo era un punto di vista non raro negli ordinari degli anni Venti e Trenta [Battelli 1987, 837-846] e che si concretizzò in buona parte dell’attività di Colli nel 1932-1934, con le benedizioni alle infrastrutture civili, come le nuove sedi municipali [8] e le scuole [9], oltre alla presenza, insieme ad altre autorità, ad eventi caritativi [10] e istituzionali [11]. Per questo intreccio di motivi diventa fondamentale sottolineare che, nel caso parmense, la stampa fascista e il nuovo vescovo stessero muovendosi in sintonia lungo direttrici retoriche se non coincidenti certamente pienamente convergenti, ben prima dell’autunno 1935 [Bonardi 1987, 7-10].
3. «Il momento è grave!». La guerra d’Etiopia a Parma e il ruolo di Colli
Fu dal dicembre 1934, in seguito all’incidente di Ual Ual, che la propaganda di regime iniziò una campagna martellante sulla questione etiopica per indirizzare l’opinione popolare verso la necessità della guerra, intesa come una legittima risposta alle ingiustizie perpetrate dal barbaro nemico. Anche sul «Corriere Emiliano» fecero la loro comparsa numerosi articoli sulla crisi africana, concentratisi sulla cattiveria degli etiopi, sulle dubbie manovre diplomatiche occidentali e sui decisi provvedimenti del governo, come l’invio di numerosi reparti armati in Africa orientale per la difesa delle colonie [12].
Una parte dei circa 3.000 combattenti della provincia di Parma che avrebbero preso parte al conflitto [Sicuri 2017, 131-132] partirono per l’addestramento a Formia il 17 maggio 1935, organizzati in due battaglioni e inquadrati nella 180° legione Alessandro Farnese camicie nere [Vitale 2024]. Per l’occasione si radunarono nel piazzale della stazione, presso il monumento a Vittorio Bottego, i due battaglioni, le autorità (presente il ministro dei Lavori pubblici, Luigi Razza) e numerosi cittadini. L’evento catalizzò per giorni l’attenzione del territorio provinciale e la stampa locale descrisse la partenza delle camicie nere con toni trionfalistici. Tutta la prima pagina del «Corriere Emiliano» del 18 maggio fu dedicata all’evento, sotto il titolo Parma interventista e diciannovista offre alla Patria due battaglioni di volontari e il Labaro dell’80° Legione.
Unendo l’interventismo delle radiose giornate del maggio 1915 alla fede fascista della città, la narrazione concorreva a fare dell’evento un episodio cardine della storia nazionale e parmigiana: furono richiamate le figure di Filippo Corridoni, elemento cruciale per la memoria interventista, e anche quella di Vittorio Bottego, dalla seconda metà degli anni Venti trasformato dalla propaganda in un popolare eroe fascista, funzionale a richiamare l’attenzione sulle vicende delle esplorazioni in Africa [13] [Taddei, Vitale 2021-2022]. Per dimostrare quanto l’ardimentoso patriottismo della città fosse generato da una storia plurisecolare, il console comandante della legione, richiamò l’attenzione dei legionari su Alessandro Farnese, il cui nome era impresso sul labaro dell’unità: «un glorioso capitano che onorò con le sue gesta e con la sua mente Parma e l’Italia e che passò alla storia come uno dei più intrepidi guerrieri del suo secolo» [14].
Fu proprio in questo contesto che Colli attuò il suo primo intervento di appoggio alla risposta italiana contro l’Etiopia. Benedicendo la fiamma dei battaglioni insieme al cappellano della milizia, don Arnaldo Furlotti, si spinse oltre la mera funzione religiosa, specialmente nel momento in cui rivolse alcune parole alle camicie nere. Il suo discorso fu così riportato dal «Corriere Emiliano»:
E fiamma di fede nella Patria e in Dio, egli dice, fiamma d’amore. Fiamma d’amore con cui Parma vi segue e vi accompagna verso la terra consacrata da un Principe Sabaudo, da Vittorio Bottego, dal sacrificio dei nostri missionari. Parma vi dice il suo saluto e il suo arrivederci e sia vicino il giorno in cui voi, con l’aiuto di Dio, ritornerete su questa piazza per cantare l’inno di gloria e della riconoscenza [15].
È doveroso sottolineare che l’unica traccia rimasta delle parole di Colli pronunciate in quell’occasione è proprio quanto riportato dal «Corriere Emiliano» e sono da mettere in conto eventuali distorsioni attuate scientemente dall’autore dell’articolo, al fine di far apparire il vescovo come pienamente allineato alla retorica di regime. Tuttavia, la breve allocuzione è del tutto coerente con le successive prese di posizione di Colli.
In un momento in cui la guerra non era ancora scoppiata il vescovo si attestò sull’ambiguo auspicio del finale «inno di gloria e della riconoscenza», non dunque alla vittoria bellica, ma nemmeno alla pace. L’aspetto più interessante delle brevi parole rivolte ai legionari è la cornice in cui le camicie nere vennero inserite, ovvero quella della militanza religiosa. Infatti, se la figura dei legionari venne fusa con quella dei protagonisti della storia della patria e della città, essi furono anche identificati come gli eredi dei missionari. Ciò dimostra quanto Colli avesse introiettato il linguaggio cattolico nazionalista di inizio Novecento, che faceva della diffusione del Vangelo in Africa l’opera non tanto di milites Christi, quanto di missionari patrioti, che agivano nel contesto degli imperi coloniali e la cui opera era inscindibilmente legata alla civilizzazione delle popolazioni “inferiori” da parte delle grandi potenze [Ganapini 1970, 52-62]. Come avrebbero dimostrato i mesi successivi, gran parte del clero italiano sembrava aver dimenticato i messaggi contenuti nella lettera apostolica di Benedetto XV, Maximum Illud (1919), e nell’enciclica Rerum Ecclesiae (1926) di Pio XI, che esplicitavano il rifiuto dell’identificazione degli Stati nazionali con le missioni cattoliche, subordinandoli all’entusiasmo patriottico della conquista dell’Impero [Ceci 2008a, 123-124]. La “radiosa” giornata del 17 maggio, dunque, dimostrava quanto il vescovo fosse in sintonia con la narrazione del regime sulla questione etiopica, una sintonia che sarebbe sfociata nella mobilitazione dell’autunno 1935. Sino ad ottobre, infatti, se la propaganda continuava ad insistere sulla crisi africana, la città non visse altri episodi significativi e Colli si ritirò a Berceto per il periodo estivo, per poi presiedere, ad agosto, il pellegrinaggio diocesano a Lourdes [16].
Come è noto, gli eventi precipitarono rapidamente a inizio autunno. I soldati italiani varcarono i confini dell’Etiopia il 3 ottobre 1935, mentre dal giorno precedente era cominciata la mobilitazione generale. Anche a Parma le parole del duce che segnarono l’inizio della guerra furono accolte con grande entusiasmo dalla stampa che non mancò di sottolineare Il superbo, compatto, fierissimo atto di fede di Parma volontarista e squadrista [17].
Colli si rivolse alla diocesi due settimane dopo, il 17 ottobre. Con un messaggio pubblicato su «L’Eco», invitò clero e fedeli alla preghiera e alla penitenza. L’aspetto più rilevante di quello che può essere definito il secondo atto del sostegno del presule allo sforzo bellico, è che esso non fu un appello alla pace o alla mesta rassegnazione, bensì un vero e proprio richiamo alla “mobilitazione” religiosa per il conseguimento della vittoria:
Nell’ora grave e solenne che attraversa la Patria nostra, è dovere di tutti dare il proprio contributo per il bene e per la vittoria della medesima. Tutti (anche i più poveri e i più deboli) possono almeno dare il contributo della preghiera e della mortificazione [18].
Nella stessa occasione invitò a tralasciare tutti quei comportamenti che contrastavano con l’«austerità doverosa nei momenti gravi e che sarebbero un’offesa a chi più si sacrifica per il bene della Patria, cioè per il bene di tutti». Di conseguenza quello di Colli era un richiamo alla compattezza e all’unità di intenti nella difficile ora che la patria stava attraversando, secondo quanto lo stesso Mussolini aveva indicato nel suo discorso del 2 ottobre e che era stato interamente riportato sul «Corriere Emiliano» [19].
Tuttavia, il definitivo ed entusiastico allineamento del vescovo allo sforzo bellico sarebbe avvenuto a metà di novembre, a ridosso dell’inizio delle sanzioni economiche promosso dalla Società delle Nazioni. Si tratta del già citato appello intitolato Il dovere dell’ora attuale, pubblicato sul «Corriere Emiliano» il 17 novembre:
Il momento è grave!
La Patria è assediata: ogni cittadino diventa soldato. Ieri forse poteva ancora alcuno credere di discutere, oggi dobbiamo tutti ubbidire. Le Nazioni che dall’Italia ebbero la civiltà oggi le tolgono il pane; gli Stati che si impinguarono di ricche Colonie nell’ultima guerra col sacrificio dei nostri soldati, oggi tagliano a noi la via per cui non cerchiamo che pane e lavoro.
La Russia bolscevica e il Messico persecutore pretendono atteggiarsi a nostri maestri di vivere civile.
Almeno Vittorio Bottego cadde nel 1897 colpito dagli indigeni colle loro armi: oggi gli abissini ci assaltano con armi fornite dai nostri amici di Europa! [20]
Alcuni temi che si riscontrano in questa prima parte del testo erano già stati affrontati dal presule prima del 1935. Si pensi alla retorica militarista e all’obbedienza come valore fondante la società. Ciò che non si può non cogliere, tuttavia, è il significato prettamente politico dell’appello che qui ha la precedenza su quello religioso. Se nel 1932-1935 Colli, pur avvicinandosi al lessico fascista, era rimasto nella sfera ecclesiastica, nel novembre 1935 venne meno il diaframma tra discorso politico e discorso religioso. Il suo fu un vero atto d’accusa alla Società delle Nazioni e agli Stati occidentali che avevano tradito l’Italia e che le impedivano di ottenere «pane e lavoro». Oltre a ciò, Colli fece propria la teoria del complotto propagandata dal regime, secondo cui ad orchestrare l’«assedio» fossero le nazioni plutocratiche e il bolscevismo internazionale.
Certo è che il vescovo di Parma si inseriva in continuità con le parole che ben più importanti ordinari avevano già pronunciato in direzione della guerra d’Etiopia [Salvemini 1967, 754]. Il 28 ottobre 1935, tredicesimo anniversario della Marcia su Roma, l’arcivescovo di Milano, cardinale Ildefonso Schuster, dal pulpito del duomo si era dichiarato totalmente a favore del conflitto, che dal suo punto di vista era un’impresa prima di tutto missionaria. Inoltre, aveva indicato nella collaborazione tra Stato e Chiesa il fondamento della diffusione del Vangelo e nel fascismo lo strumento per la cattolicizzazione del Paese [Ceci 2010, 86]. Le parole di Schuster ebbero una risonanza nazionale e lo stesso «Corriere Emiliano» non esitò a riportarne ampi stralci [21]. Molti vescovi ne seguirono l’entusiastico esempio come in Lombardia [Nobili 2008, 268-269], ma anche nel resto della penisola, come a Venezia [Tramontin 1985, 454] e, appunto, nella stessa Emilia, nelle diocesi di Piacenza, Reggio Emilia e Guastalla [Mantelli 2011].
Erano diversi i fattori che concorrevano a spingere i vescovi a porsi in prima persona come autentici ed euforici sostenitori dello sforzo bellico [Moro 2020, 268-291]. Come già esposto in precedenza, vi era la sincera convinzione che il regime stesse fornendo un contributo decisivo alla costruzione di una società autoritaria e cattolica, in sintonia con le coordinate teologiche che avevano caratterizzato la formazione del clero di fine Ottocento e inizio Novecento e che intercettava anche la diffidenza provata dalle gerarchie ecclesiastiche verso il liberalismo e la paura ideologica verso il comunismo [Ceci 2010, 89].
Il Concordato, inoltre, aveva aperto le porte verso la piena collaborazione tra clero e Stato. Non pochi rivissero, nell’autunno 1935, lo stesso entusiasmo provato per l’ingresso dell’Italia nella Grande guerra, attuando un discorso di legittimazione del conflitto analogo a quello di vent’anni prima, sulla scia emotiva dell’anniversario del 4 novembre [Moro 2020, 46-60]. Non a caso il vescovo di Fidenza, monsignor Mario Vianello, partecipando all’inaugurazione del Sacrario dell’Asilo monumento dei caduti di Salsominore, legò la celebrazione dei caduti del primo conflitto mondiale con quelli dell’Etiopia [22]. Anche per questo aspetto si può affermare che non erano state recepite, o lo erano state solamente in parte, le parole espresse da Benedetto XV contro la guerra nelle encicliche Ad Beatissimi Apostolorum (1914) e Pacem, Dei Munus Pulcherrimum (1920), come pure quelle dei teologi francesi e tedeschi nella più recente e pacifista Dichiarazione di Friburgo (1931). All’universalismo cattolico, prevalse il nazionalismo, alla legittimità della Società delle Nazioni, gli interessi bellici dell’Italia [Ceci 2008a, 120-124]. A ciò si aggiunse la mitizzazione dei caduti in guerra, posti sullo stesso piano dei “martiri” [Franzinelli 2008, 253], incentivata da una parte della stessa stampa cattolica che, come fece il 19 ottobre «La Civiltà Cattolica», descrisse l’Etiopia come una terra barbara, eretica e scismatica, in virtù della diffusa fede cristiana monofisista [Ceci 2010, 178].
Se si prosegue la lettura dell’appello di Colli si comprende quanto egli considerasse il pacifismo uno strumento del «bolscevismo sovvertitore»:
È un’ora di estrema tensione per tutti; ma ai cattolici – cui l’amor patrio sgorga in cuore e si alimenta anche di fede religiosa – incombe un particolare dovere: quello di essere all’avanguardia dei migliori cittadini, aiutare la Patria colla preghiera, colla parola, coll’esempio, col braccio, coll’offerta di oro, d’argento e di quanto può essere utile, aiutarla con la disciplina perfetta colla austerità della vita, colla limitazione del necessario, coll’abolizione di ogni superfluo, nello stesso tempo un dovere di tutti è un comune interesse.
Quando il bene della Patria è in pericolo, quando centinaia di migliaia di giovani combattono al fronte, non si ha il diritto di essere egoisti, di sciupare, di godersi la vita.
Il danno della Patria sarebbe domani il danno di tutti: danno economico, danno morale, danno anche religioso.
Non dimentichiamo che, sotto la maschera del pacifismo internazionale scatenatosi in forma di guerra economica contro l’Italia da parte degli Stati più guerraioli, si nasconde ed opera il bolscevismo sovvertitore il quale ha lanciato la parola d’ordine ai suoi adepti “Per la pace in Africa, la guerra in Europa e la lotta finale nel mondo”.
Che ciascuno senta e prenda le sue responsabilità; che ciascuno compia il suo dovere!
Che Dio benedica l’Italia e ci salvi la civiltà! [23]
Con questo spirito Colli a fine novembre fece dono al segretario federale della sua collana pettorale e della moneta d’oro del peso complessivo di 47 grammi: «Offro alla Patria con i voti più fervidi il mio cuore di Vescovo e di italiano» [24], mentre il monsignor Vianello donò il proprio anello pastorale [25], come avrebbero fatto diversi altri presuli italiani [Soave 1995, 698].
A spingere la grande maggioranza di molti ordinari all’entusiastico appoggio della guerra in Africa vi era anche l’ambigua posizione assunta da Pio XI in quei mesi cruciali. Il clero non si sarebbe mai pronunciato così a favore dell’azione bellica se non avesse creduto che lo stesso pontefice stesse avallando le ambizioni dell’Italia, e i suoi silenzi sembravano proprio correre in tale direzione [Ceci 2010, 136, 141]. Come ha dimostrato Lucia Ceci, il papa era contrario alla guerra contro l’Etiopia, ma preferì tutelare i rapporti della Santa Sede con il governo italiano ed evitare ogni possibile attrito, piuttosto che esporsi alla condanna del conflitto, suscitando non pochi dubbi e polemiche tra gli antifascisti fuoriusciti, tra cui lo stesso don Sturzo. L’unica e chiara condanna del vescovo di Roma all’aggressione italiana avvenne nel discorso alle infermiere tenuto a Castelgandolfo il 27 agosto 1935. Tuttavia, i toni delle sue parole causarono un incidente diplomatico con Roma, e lo stesso Pio XI provvide a far sì che sull’«Osservatore Romano» ne comparisse una versione mitigata, poi distorta dalla propaganda di regime che concorse a far apparire il pontefice a favore della guerra, strumentalizzando anche il successivo intervento tenuto di fronte ai reduci cattolici (7 settembre 1935) [Ceci 2008a, 130-131; Ceci 2010, 46, 54].
In provincia, del discorso del 27 agosto si seppe ben poco e arrivò solamente la versione edulcorata dell’«Osservatore Romano». Ne seguì che gli ordinari interpretarono il silenzio del pontefice come un appoggio alle istanze di Mussolini, impegnandosi così in prima persona ad esprimere pubblicamente quel sostegno che il pontefice, per puro riserbo diplomatico, sembrava non poter fare. Inoltre, con l’avvio delle sanzioni, il sentimento psicologico dell’“assedio” nemico verso la patria rinforzò la convinzione di essere dalla parte giusta, e anche la Provvidenza non avrebbe potuto che manifestare la propria benevolenza verso un popolo che aveva necessità di nuove terre e risorse per moltiplicarsi e diventare prospero. Si spiegano così anche la prese di posizione di molti religiosi come padre Agostino Gemelli, rettore dell’Università cattolica del Sacro Cuore, monsignor Antonio Giordani, il “vescovo dei Balilla”, e di padre Renaldo Giuliani, caduto in Etiopia nel gennaio 1936 e poi mitizzato dallo stesso fascismo [Franzinelli 2008, 254, 262-265].
In questo senso non stupisce che molti ordinari indicarono ai propri fedeli il duce come il nuovo Mosè che, tramite l’esodo etiope, avrebbe condotto il popolo italiano verso la liberazione, come fece ad Amalfi monsignor Ercolano Marini [Franzinelli 2008, 257-258]. Ma per rimanere in territorio parmense, è possibile rimandare alle parole che monsignor Vianello utilizzò nel suo appello ai fedeli il 18 novembre e intitolato Il nostro dovere nell’ora presente:
La Patria ha il suo Re, il suo Duce, il suo Governo! Essi sono quel “Cesare” del Vangelo, a cui dobbiamo onore, rispetto ed obbedienza per la rappresentanza che hanno di Dio nel cu[r]are il benessere della Nazione e tutelarne i suoi diritti: la Loro azione non sia mai intralciata da soggettivi e particolari apprezzamenti!
[…] Voglia il Cielo, fratelli e figli dilettissimi, che ognuno di noi si renda conto di questi gravi doveri, e se ne formi la coscienza: sarà il miglior modo per addimostrare alla Patria che noi troviamo nuovi motivi per amarla e servirla, e per darle garanzia della nostra generosità pronta e [sic] spingersi fino al sacrificio. E il Signore ci sia prodigo dei Suoi lumi, largo di doni; e ci conceda di saper affermare in faccia al mondo una volta ancora la grandezza dell’Italia e la virtù degli Italiani [26].
4. «Dio me l’ha data, guai a chi la tocca!». La Giornata della Fede
Il momento più significativo della mobilitazione civile nel territorio nazionale per lo sforzo bellico fu la Giornata della Fede, durante la quale migliaia di cittadini donarono alla patria il proprio anello nuziale o altri beni in oro e argento. Già nel nome, la Giornata indicava la fusione del linguaggio religioso con quello civile. La “Fede” cui il regime faceva riferimento era, chiaramente, quella nell’Idea, ma la polisemia della parola era funzionale a rappresentare l’intreccio della liturgia fascista con quella cattolica, che caratterizzò la Giornata in molte diocesi, tra cui quella di Parma.
Nella città emiliana la cerimonia si tenne al Palazzo della Federazione dei fasci, nel Sacrario dei caduti fascisti. La scelta del luogo, la disposizione degli arredi, la presenza di tutte le autorità e la processione delle singole persone non erano lasciate al caso e tutto seguì una precisa liturgia:
Nel suggestivo luogo, entro cui piove, da due fari invisibili, una luce tenue e raccolta, sovra un enorme quadrato piedestallo, arde l’incenso e palpita la fiamma da una anfora bronzea. Innanzi ad essa sta un treppiedi, formato da mitragliatrici, su cui verrà collocato il glorioso artistico morione dell’eroico duca Alessandro Comandante in II. dei Fasci Giovanili, affiancato da una madre o vedove [sic] di Caduti in guerra, e da una moglie di un volontario in Africa [27].
Ai lati dell’elmo, invece, prestavano servizio ufficiali delle forze armate in congedo, della milizia e dei fasci giovanili; lo sfondo era dominato dal gagliardetto del Fascio di Parma e dei fasci rionali, mentre «Giovane [sic] Fasciste, parenti di caduti in guerra o volontari in Africa, alimentano la fiamma e spargono grani d’incenso». Dopo la benedizione del «tempio» e dell’«ara» da parte di Colli, la moglie del prefetto fece cadere la prima fede d’oro nel morione: «L’elmo tintinna, sotto il getto ininterrotto, come animato da un gioioso fremito». La cerimonia proseguì nel salone “2 Ottobre”, dove il vescovo benedisse gli anelli di ferro affermando:
L’anello nuziale è il simbolo più prezioso del vincolo familiare. Offrirlo significa riconoscere nella Patria una seconda famiglia e promettere ad essa lo stesso amore, la stessa fedeltà, lo stesso spirito di sacrificio che si hanno per le proprie famiglie. Sono rudi anelli di ferro: ma in Italia, ricordiamolo, abbiamo una corona regale che è la più antica e gloriosa corona d’Italia: la corona ferrea.
Napoleone che l’aveva violentemente conquistata, togliendola dalle mani del Papa e ponendosela sul capo, disse: «Dio me l’ha data, guai a chi la tocca!».Le donne d’Italia, mettendosi oggi al dito l’anello di ferro, e sposandosi misticamente con la Patria, possono dire, alla lor volta: «Dio me l’ha data, guai a chi la tocca!» [28].
Dopo aver offerto la fede di sua madre fu lo stesso Colli, insieme al prefetto e al segretario federale, a consegnare gli anelli di ferro, per lasciare poi lo spazio ai congiunti dei caduti o dei volontari.
Quanto accadde al Palazzo della Federazione fu la sacralizzazione del sacrificio dei civili, che doveva essere in tutto e per tutto complementare a quello dei soldati, assumendo la fisionomia di un matrimonio con la patria [Terhoeven 2006], proprio per rappresentare la sacralità della guerra stessa, intrapresa per conquistare terra e lavoro, per acquisire il diritto all’impero e per compiere una missione civilizzatrice e cattolica [Ceci 2010, 25-26]. Le donne italiane diventavano, esattamente come i soldati, il simbolo della Patria combattente, accettando di scambiare «ferro per fede» [29].
Anche la scelta dell’elmo di Alessandro Farnese come scrigno degli anelli d’oro fu in linea con la simbologia che fino a quel momento aveva accompagnato la guerra. Era esplicito il richiamo alla 180° Legione, che veniva pienamente inserita nella storia militare di Parma e nelle guerre cattoliche contro i “barbari infedeli” e il «Corriere Emiliano» non mancò di sottolinearne ai lettori il significato storico. La figura del condottiero simboleggiava
la continuità ideale, manifestazione di una volontà rettilinea e continuatrice della storia, nell’elmo di colui che in modo insuperabile rappresentò l’energia militare e il coraggio fisico della stirpe. Questo significato, questa continuità, questa presenza erano già stati intesi da coloro che avevano intitolato il nome del Duce magnanimo la ferrea 180° Legione che ora porta in Africa Orientale il nome di Parma glorioso tra le prime avanguardie. E così si realizza l’antica leggenda: «nomen sit omen», l’augurio è nel nome [30].
Queste parole, come si avrà modo di vedere, avrebbero riecheggiato anche nel discorso di Colli nella recita del Te Deum e nell’accoglienza dei legionari di ritorno a Parma, rispettivamente nel maggio e nel settembre 1936. Quell’elmo, in altre parole, non era solamente un simbolo retorico, ma una vera e propria rappresentazione plastica della fusione avvenuta tra linguaggio politico e religioso, della sovrapposizione delle liturgie fascista e cattolica che, nel contesto parmense, era espressione di una comunanza valoriale che non si fermò al mero artificio.
Durante il solo 18 dicembre in città furono consegnate 5.000 fedi e in provincia circa 20.000 [31]. Lo stesso Colli, dalle pagine dell’«Osservatore Romano della Domenica» incitò più volte i fedeli a donare i propri anelli, facendo sì che anche i parroci e singoli sacerdoti divenissero parte di quell’ingranaggio di raccolta di oro e argento [32]. Se si estende lo sguardo verso la provincia, infatti, si può osservare che la raccolta di materiale prezioso fu per il regime un pieno successo: a fine dicembre erano state raccolte 41.113 fedi nuziali [33] e in tutto sembra furono 63.937 i parmensi che donarono oro, 11.167 in città e 52.770 in provincia [Sicuri 2017, 132].
![Fig. 3. Articolo “Ferro per fede” in cui viene enunciato il significato dell’elmo di Alessandro Farnese [«Corriere Emiliano», 18 dicembre 1935].](./../../sites/default/images/articles/media/319/melegari_elmo_03.jpg)
Ma al di là dei dati numerici è interessante notare come i sacerdoti esercitarono un ruolo cruciale durante la Giornata, guidando le proprie comunità verso il sacrificio per la patria. Per esempio, a Sala Baganza furono raccolti 1,2 chilogrammi d’oro e nove d’argento. Tra gli altri la gioventù di Ac aveva offerto il proprio medagliere. Lo stesso gesto fu compiuto dai giovani di San Secondo, dove don Oreste Gorreri e don Leopoldo Buratti donarono 10,23 grammi d’oro e 139,60 grammi d’argento [34], mentre a Borgo Val di Taro le Donne cattoliche avevano consegnato 60 fedi [35] e a Fidenza, le Donne e la Gioventù femminile di Ac avevano fatto dono di una lampada votiva perché ardesse sino al giorno in cui le campane non avessero suonato per la vittoria [36].
Molti sacerdoti furono in prima fila per guidare i parrocchiani al “sacrificio”. A Bedonia «valido contributo di propaganda» fu svolto da don Paolo Checchi, «alla testa di tutti i Reverendi Parroci del suo vasto Vicariato» [37], mentre a Sorbolo fu monsignor Enrico Grassi ad esaltare «il nobile significato della patriottica offerta» [38] e a Palanzano furono don Igino Rubini e a Ranzano don Angelo Chierici a sottolineare la sacralità della Giornata [39] così come a Neviano Arduini don Altamara fu il primo a presentare in dono i propri gemelli d’oro [40].
Nel versante occidentale della provincia, a Fontanellato, monsignor Grassi consacrò una lampada votiva tricolore per i combattenti, per poi donare il suo anello dottorale [41], mentre nella zona di Busseto spettò ai parroci consegnare le fedi di ferro ai parrocchiani, insieme a monsignor Vianello [42]. Anche a Collecchio il clero, coordinato dal segretario del Fascio, diede il più ampio appoggio all’iniziativa, tanto che il «Corriere Emiliano» ne tessé pubblicamente le lodi [43], esattamente come il segretario federale Comingio Valdrè fece nei confronti della parrocchia di Fugazzolo, che aveva donato una spilla d’oro di tre grammi [44].
Le motivazioni dell’entusiasmo dei parroci e dei singoli sacerdoti verso le donazioni per la Patria erano le medesime di quelle dei vescovi, con la convinzione che l’Etiopia avrebbe costituito uno sbocco significativo per la manodopera, concedendo una crescita del popolo italiano [Franzinelli 2008, 256] e furono diverse le zone d’Italia in cui si riscontrò un’analoga adesione generalizzata, come ad esempio in Umbria [Boccetti 1978] e in Lazio [D’Angelo 1995, 114-115].
Vi è da sottolineare, però, che un conto era la descrizione che la stampa fascista presentava del sostegno del clero, un altro erano i reali sentimenti diffusi tra i parroci. Certamente vi erano genuini sostenitori dello sforzo bellico: si pensi al caso di don Giuseppe Violi, parroco di Santa Lucia di Medesano. Fratello del segretario del Fascio di Varano Marchesi e cappellano dei premilitari e dei balilla [45] fu molto attivo nella raccolta d’oro [46]. Allo stesso modo i padri cappuccini della città, che consegnarono alla federazione di Parma 25 grammi d’oro e 422 d’argento in monete, inviarono pure una lettera al federale in cui con cui lo pregavano di gradire la «mistica offerta» per combattere i nemici della patria [47]. Va tenuto conto, tuttavia, che anche laddove i parroci parteciparono alle donazioni non è detto lo fecero come strenui sostenitori dello sforzo bellico. Molti agirono probabilmente per conformismo. Sotto la pressione del clima generale d’esaltazione creato ad arte dalla propaganda era difficile sottrarsi all’impegno, soprattutto quando si era consapevoli di essere oggetto dell’attenzione delle autorità fasciste e dopo che lo stesso vescovo si era espresso a favore della guerra. Allo stesso modo vi poteva essere la volontà di compartecipare alle rinunce della propria comunità, interpretando il proprio ministero come inscindibilmente connesso con le privazioni sopportante del proprio “gregge”. In questo senso vi è da considerare che i nomi di coloro che compivano donazioni, in special luogo i parroci, ma anche i notabili e le personalità altolocate, erano pubblicati sul «Corriere Emiliano» e sarebbe errato sottostimare l’efficacia di quello che Paul Corner ha definito il «patriottismo coatto» [Corner 2015, 211-218]. Che in diocesi esistessero voci dissonanti, inoltre, è provato da quanto era accaduto a inizio 1935 a Calestano.
Don Cesare Bizzarri, classe 1881, era parroco del paese dal 1917. Vicino agli ambienti del Ppi, si era scontrato con i fascisti locali durante i primi anni Venti [Canali 1983, 72; Boggio Tomasaz 1998, 116-117; Sicuri 2015, 242], per poi subire violenze dagli squadristi nel corso del 1924 [Becchetti, La Fata 2004, 115-116]. Durante la messa di domenica 10 febbraio 1935, probabilmente dando voce ad un sentimento diffuso nella comunità dopo il recente richiamo alle armi di diversi appartenenti alla classe 1911, si espresse contrariamente alle possibili iniziative militari contro l’Etiopia.
Ho sentito vociferare [sembra disse don Bizzarri] che si sta preparando una nuova guerra. Non abbiamo ancora terminato di piangere i morti di ieri e già si sta preparando una nuova guerra. Non direte che saremo noi preti a volere questa nuova guerra [48].
Furono i carabinieri ad attivare le indagini e la questura lo denunciò secondo l’articolo 181 del Testo unico di Pubblica sicurezza, probabilmente anche dietro l’interessamento dei nemici personali di don Bizzarri, il podestà Guerino Calzolari e il segretario politico Angelo Cavatorta che non gli perdonavano le sue posizioni contrarie al regime [Mantelli 2012, 525]. Arrestato il 19 febbraio, fu condannato a cinque anni di confino a Cinquefrondi (Reggio Calabria) per “disfattismo” [49].
Sono molteplici gli aspetti di interesse in questa vicenda. In primo luogo, è evidente quanto la posizione assunta da Colli nei mesi successivi potesse anche non essere condivisa da una parte del clero della diocesi e che esistevano profondi dubbi sull’effettiva giustizia dell’aggressione all’Etiopia. In generale, a guardare con perplessità all’eccitazione dei vescovi nella promozione della guerra non erano pochi: si pensi alle note riportate da monsignor Domenico Tardini [Ceci 2008b, 343-344], all’atteggiamento del cardinale Elia Dalla Costa, arcivescovo di Firenze [Bocchini Camaiani 1983, 98-107], ma anche ad ambienti come la Fuci, il Movimento dei laureati cattolici e la Pontificia università gregoriana [Ceci 2010, 78-79]. Oltre a ciò, la vicenda di don Bizzarri mostra quanto fosse stringente il controllo delle autorità verso gli oppositori, anche sacerdoti. Al netto della conflittualità presente a Calestano tra parroco ed esponenti fascisti, il regime non poteva permettersi che i parroci diventassero lievito di “disfattismo” nel critico momento in cui si stava preparando la guerra.
Da ultimo la vicenda di don Bizzarri (unico sacerdote mandato al confino durante il Ventennio in provincia di Parma) è interessante per osservare la postura assunta da Colli verso le autorità, giacché la condanna del parroco di Calestano creò viva preoccupazione in curia. Sembra che in un primo tempo il vescovo abbia sondato il terreno delle autorità, da una parte deplorando le parole incriminate e dall’altro sperando che la questione si risolvesse con un nulla di fatto. Una volta concretizzatasi la pena, il presule, dietro suggerimento del questore, scrisse a Mussolini per intercedere a favore del sacerdote [50].
Le parole utilizzate da Colli nella lettera al duce sono emblematiche del tentativo di mantenere pacifici rapporti con le autorità e allo stesso tempo di mediare per difendere la propria sfera di competenza, quale era la disciplina del clero. Scrivendo a Mussolini, Colli definì don Bizzarri come un elemento del tutto allineato al Partito e chiese di concedere la grazia a causa della carenza di parroci e per far sì che il clero «ritrovi la tranquillità d’animo necessaria»:
L’atto di clemenza che invoco all’E.V. riporterà la tranquillità negli animi e specialmente nel Clero nostro, il quale non essendo mai venuto meno al rigido dovere di leale soggezione alle Autorità, ambisce di averne un autorevole riconoscimento dall’E.V. sia pure con un atto di clemenza che mentre liberi dal confino Don Bizzarri, tolga di mezzo una dolorosa eccezione, perché sia permesso di affermare con soddisfazione che il Clero di Parma, dal Vescovo all’ultimo Sacerdote sa ricordare nelle idee ed attuare nelle opere il perfetto accordo di Religione e Patria pel bene del popolo [51].
La posizione espressa da Colli con queste parole era del tutto in coerenza con quanto espresso finora, specialmente nell’additare il clero come un elemento che agiva in «perfetto accordo» del bene della patria. Nella lettera era chiaro l’intento giustificatorio, ma rimane indubbio che alla luce di quanto già espresso che il sentimento di Colli fosse sincero. Ciò traspare anche nella lettera pastorale del l’inizio del 1936, in cui si affermò che la «nostra [dei cattolici] lealtà patriottica trascende le contingenze del tempo e degli uomini e arriva fino a Dio» [52] [Colli 1936].
Non si può nemmeno escludere che l’episodio di don Bizzarri concorse, almeno in parte, a spingere il vescovo a mostrarsi perfettamente allineato alla propaganda fascista nei mesi successivi: mostrarsi in tutto e per tutto a favore degli sforzi messi in atto dal regime poteva essere un modo per fugare ogni dubbio sull’effettiva volontà della curia e del clero parmense di essere un elemento d’ordine. Si consideri che nello stesso periodo della condanna di don Bizzarri si erano verificate alcune violenze squadriste contro militanti di Ac a Basilicagoiano e Montechiarugolo, contro le quali Colli non aveva mancato di chiederne ragione alle autorità [Cocconi 2020, 29-30]. Una strategia, in parte remissiva, che da una parte era volta a difendere le proprie prerogative senza entrare in collisione con il regime (per nulla dissimile da quella attuata nello stesso arco di tempo dal Vaticano nei confronti del governo) [Ceci 2010, 183] e che dall’altra ben mette in mostra l’ambiguità delle posture assunte mano a mano dal vescovo verso il fascismo, data la difficoltà di interpretarne la modernità secondo coordinate a sé congeniali [Gentile 2010, 14].
Accolta la richiesta di Colli nel maggio 1936, l’ormai ex-parroco di Calestano venne inviato nella piccola e periferica parrocchia di Vigheffio, nella campagna alle porte meridionali della città [53]. La notizia del suo confino non era trapelata tra la popolazione e sembra che nessuno ne conoscesse il difficile trascorso, ma era chiaro per don Bizzarri che quella parrocchia segnava una sorta di prosieguo del suo confinamento [54]. Da quel momento in avanti l’ex-parroco di Calestano fu inserito in una sorta di processo riabilitativo, tenuto costantemente sotto sorveglianza dal vescovo e dalle autorità [55]. La condanna al confino e poi l’esilio dalla parrocchia furono un atto traumatico e violento per il sacerdote, strappato dalla sua comunità. Nel dopoguerra, don Bizzarri non avrebbe mai parlato della sua esperienza al confino e la sua figura rimase ai margini della memoria pubblica dell’antifascismo cattolico parmense.
5. La fine della guerra e la fine di un’epoca
La vittoria sull’Etiopia e i relativi pochi morti che essa aveva richiesto alla provincia (38 in tutto, secondo l’Albo d’oro) [Labanca 2008, 154] concorsero a rendere trionfale l’accoglimento dell’annuncio di Mussolini sul ritorno dell’Impero sui «colli fatali di Roma». In città le giornate successive al 5 maggio 1936 (conquista di Addis Abeba) e al 9 maggio (proclamazione dell’Impero) videro festeggiamenti entusiastici. Uno dei momenti più solenni fu la recita del Te Deum in cattedrale, quello stesso 9 maggio, che potrebbe definirsi la summa del pensiero di Colli sulla vicenda etiopica. Dal pulpito, in una cattedrale gremita, così si espresse:
Un gruppo di Nazioni si è messo contro di noi in nome di un patto che era un patto di ingiustizia. Noi ci uniamo una volta di più, noi, popolo italiano, con un patto che è un patto sacro, in nome di Dio e in nome della Patria.
Il nostro Capo del Governo, a proposito della grande guerra europea ebbe una espressione magnifica, disse: «Gli uomini hanno chiamato il diavolo in scena ed ora non riescono più a liberarsene». Ora noi diciamo: «L’Italia ha chiamato Dio ufficialmente in scena e non lo abbandonerà più e starà sempre con Dio e Dio starà sempre con Lei!».
Il nostro grande Alessandro Farnese, gloriosa e simpatica figura di condottiero e di uomo politico, aveva un grande stendardo che faceva sventolare dinnanzi ai suoi soldati; da una parte, questo stendardo aveva la figura di Cristo e sotto erano scritte queste parole: «In Te honor et gloria» (In Te onore e gloria); dall’altra parte la figura di Maria Santissima e sotto scritto: «Sub tuo patrocinio» (Sotto il Tuo patrocinio, sotto la tua protezione).
Noi italiani, noi parmigiani, in questo istante raccogliamo il grido di impresa del nostro grande Alessandro Farnese e diciamo in questa storica e meravigliosa Basilica, diciamo: «In Te o Dio, in Te o cristo, onore e gloria e ringraziamento e Tu o Vergine proteggi le armi della nostra Italia» [56].
Allo stesso modo, l’esaltazione dello sforzo patriottico in nome della patria e di Dio fu portata avanti da Colli il 28 agosto, quando rientrarono in città i reduci del Passo Uarieu, accolti trionfalmente da una folla festante [57] [Vitale 2024, 24-25]. Ancora una volta il vescovo prese la parola, additando i legionari come esempio di cristianità:
Ci fu un tempo in cui si disse che ogni italiano era cavaliere, oggi, conservando le nostre tradizioni cavalleresche, dobbiamo anche aggiungere che ogni italiano è degno soldato.
[…] Legionari, il Vescovo rinnova la benedizione di Dio sopra di voi e vi augura che siate degni di colui al cui nome glorioso si intitola la vostra Legione “Alessandro Farnese”, grande condottiero in guerra, grande artefice di opere di pace e grande cristiano. Siate così, sempre anche voi per la grandezza d’Italia, e nel nome della Patria, Iddio vi benedica come vi benediranno ora e sempre tutti gli Italiani [58].
Le parole del 28 agosto furono le ultime che Colli pronunciò in merito alla questione etiopica. Esse rappresentano l’esito ultimo di quel processo che lo aveva portato all’appassionato appoggio dell’impresa del regime, il momento più alto dell’allineamento del clero verso il fascismo.
Rappresentano, inoltre, l’inizio di una più sfumata e critica postura verso le decisioni internazionali del regime. Lo stesso 28 agosto Colli aveva additato la pace come l’obiettivo verso cui «noi, come Italiani e come cristiani dobbiamo disperatamente credere, anche quando le nazioni sembra che si trasformino in polveriere pronte ad esplodere» [59].
Se la creazione dell’Impero trasse consensi in quanto opportunità per la diffusione del cattolicesimo, era difficile fornire lo stesso sostegno alla volontà di modificare tutto l’assetto internazionale per mezzo della forza, verso cui l’Italia fascista si sarebbe mossa con sempre più convinzione nel corso della seconda metà degli anni Trenta, oltretutto in vicinanza con la Germania nazionalsocialista e “neopagana” [Moro 2020, 202-239]. La guerra di Spagna, anch’essa vista come un capitolo importante della lotta contro il bolscevismo, ottenne ancora vasti consensi nel clero italiano e nello stesso Colli, che l’additò come una guerra giusta [60], ma al contempo si allargava sempre più la lontananza tra nazionalismo fascista e patriottismo cattolico, così come era stato declinato nel 1935-1936 [Mantelli 2011].
Le leggi razziali del 1938, il venir meno del ruolo di Mussolini come garante della pace europea (1939) e il coinvolgimento dell’Italia nella Seconda guerra mondiale (1940) fecero capire a molti quanto le speranze della cattolicizzazione per mezzo del fascismo (e del fascismo stesso) fosse stata un’illusione [Gentile 2010]: lo Stato fascista era un modello che funzionava in maniera del tutto differente dallo Stato cattolico [Riccardi 1995, 147-148; Riccardi 1996, 532-536] e nell’ideologia fascista il cattolicesimo non era che una delle componenti funzionali alla creazione del totalitarismo [Gentile 2018, 43].
Nel 1940 l’Appello che Colli (nel frattempo diventato direttore generale dell’Ac) indirizzò al clero e ai fedeli fu completamente diverso da quello del 1935 ed era improntato sì all’obbedienza, ma in chiave di sopportazione, non di mobilitazione nazionalista [61]. E nel 1942-1943, quando le parrocchie dovettero consegnare parte delle loro campane allo Stato, i sentimenti dei fedeli e degli stessi parroci furono molto diversi rispetto a quelli dimostrati durante la Giornata della Fede.
Dopo le drammatiche esperienze del conflitto mondiale, dell’occupazione tedesca e della guerra civile, la lettera pastorale di Colli per la Quaresima 1949 portò il titolo La guerra è la grande nemica [Colli, 1949]. In essa il vescovo negò la possibilità dell’esistenza di una guerra giusta, prendendo atto della capacità distruttiva delle armi atomiche, ma anche del vissuto della diocesi nel 1940-1945. Erano passati 14 anni dal suo entusiastico appoggio alla guerra d’Etiopia. Le parole pronunciate di fronte all’elmo di Alessandro Farnese erano parte di un’epoca ormai finita e che aveva dimostrato il suo tragico portato.
Bibliografia
- Arnold, Vian 2010
La condanna del modernismo. Documenti, interpretazioni, conseguenze, a cura di Claus Arnold e Giovanni Vian, Roma, Viella, 2010. - Battelli 1986
Giuseppe Battelli, Santa Sede e vescovi nello Stato unitario. Dal secondo Ottocento ai primi anni della Repubblica, in Storia d’Italia. Annali, vol. IX, La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, a cura di Giorgio Chittolini, Giovanni Miccoli, Torino, Einaudi, 1986, pp. 809-854. - Becchetti, La Fata 2004
Margherita Becchetti, Ilaria La Fata, Lontani dal centro: gli antifascisti in provincia, in Nella rete del regime. Gli antifascisti del Parmense nelle carte di polizia (1922-1943), a cura di Massimo Giuffredi, Roma, Carocci, 2004, pp. 108-135. - Boccetti 1978
Erminio Boccetti, Momenti del consenso del clero al regime: l’impresa d’Etiopia, in Cattolici e fascisti in Umbria (1922-1945), a cura di Alberto Monticone, Bologna, il Mulino, 1978, pp. 333-340. - Bocchini Camaiani 1983
Bruna Bocchini Camaiani, La Chiesa del concordato, vol. II, Ricostruzione concordataria e processi di secolarizzazione. L’azione pastorale di Elia Dalla Costa, Bologna, il Mulino, 1983. - Boggio Tomasaz 1998
Cecilia Boggio Tomasaz, Cattolici e impegno politico a Parma 1900-1925, Parma, Circolo Culturale “Il Borgo”, 1998. - Bonardi 1987
Pietro Bonardi, La Chiesa di Parma e la guerra 1940-1945, Parma, Tipolitografia Benedettina Editrice, 1987. - Bonardi 1997
Pietro Bonardi, Il Beato Conforti per la gente della sua terra, Parma, Vita Nuova, 1997. - Bonardi 2004
Pietro Bonardi, Giuseppe Cavalli. Un ribelle per fede e per amore, Milano, Centro Ambrosiano, 2004. - Campanini 1995
Giorgio Campanini, Chiesa e Movimento cattolico a Parma tra Ottocento e Novecento. Studi e ricerche, Parma, Il Borgo, 1995. - Campanini 2016
Giorgio Campanini, I cattolici e il fascismo italiano, in «Bollettino dell’archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia», 2-3 (2016), pp. 178-189. - Canali 1983
Franco Canali, Parma, in Il partito popolare in Emilia Romagna (1919-1926), vol. I, Le esperienze provinciali, a cura di Alessandro Albertazzi, Giorgio Campanini, Roma, Cinque Lune, 1983, pp. 59-91. - Canavero 1991
Alfredo Canavero, I cattolici nella società italiana. Dalla metà dell’800 al Concilio Vaticano II, Brescia, La Scuola, 1991. - Ceci 2008a
Lucia Ceci, La guerra di Etiopia fuori dall’Italia: le posizioni dei vescovi cattolici europei, in L’impero fascista. Italia ed Etiopia (1935-1941), a cura di Riccardo Bottoni, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 117-143. - Ceci 2008b
Lucia Ceci, «Il Fascismo manda l’Italia in rovina». Le note inedite di monsignor Domenico Tardini (23 settembre – 13 dicembre 1935), in «Rivista storica italiana», 120 (2008), pp. 313-367. - Ceci 2010
Lucia Ceci, Il papa non deve parlare. Chiesa, fascismo e guerra d’Etiopia, Roma-Bari, Laterza, 2010. - Cocconi 2020
Umberto Cocconi, L’ultimo vescovo del Concilio Vaticano I. Evasio Colli vescovo di Parma (1932-1971), Brescia, Morcelliana, 2020. - Colli 1932
Evasio Colli, Prima lettera pastorale di S.E. Rev.ma Mons. Evasio Colli al clero e al popolo di Parma, Acireale, Stabilimento Tipografico Galatea-Sardella, 1932. - Colli 1936
Evasio Colli, I Cattolici e la Patria, Fidenza, Tipografia La Commerciale, 1936. - Colli 1949
Evasio Colli, La guerra è la grande nemica. Lettera pastorale per la Quaresima 1949, Società Editrice Internazionale, Parma, 1949. - Colli 1956
Evasio Colli, Lettere pastorali 1932-1956, a cura di Pietro Triani, Torino, SEI, 1956. - Corner 2015
Paul Corner, Italia fascista. Politica e opinione popolare sotto la dittatura, Roma, Carocci, 2015. - Cremonesi 1999
Giuseppe Cremonesi, Declino dello Stato cristiano. Da Luigi Sturzo a Giuseppe Dossetti, San Giovanni in Persiceto, Edizioni Aspasia, 1999. - D’Angelo 1995
Augusto D’Angelo, All’ombra di Roma. La diocesi tuscolana dal 1870 alla fine della seconda guerra mondiale, Roma, Studium, 1995. - Dau Novelli 1994
Cecilia Dau Novelli, Famiglia e modernizzazione in Italia tra le due guerre, Roma, Studium, 1994. - De Giorgi 2002
Fulvio De Giorgi, Linguaggi militari e mobilitazione cattolica nell’Italia fascista, in «Contemporanea», 2 (aprile 2002), pp. 253-286. - Del Boca 2010
Angelo Del Boca, La guerra d’Etiopia. L’ultima impresa del colonialismo, Milano, Longanesi, 2010. - Franzinelli 2008
Mimmo Franzinelli, Il clero italiano e la «grande mobilitazione», in L’impero fascista. Italia ed Etiopia (1935-1941), a cura di Riccardo Bottoni, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 251-265. - Ganapini 1970
Luigi Ganapini, Il nazionalismo cattolico. I cattolici e la politica estera in Italia dal 1871 al 1914, Roma-Bari, Laterza, 1970. - Gentile 2008
Emilio Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Roma-Bari, Laterza, 2008. - Gentile 2010
Emilio Gentile, Contro Cesare. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi, Milano, Feltrinelli, 2010. - Gentile 2018
Emilio Gentile, La vita italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista, Roma, Carocci, 2018 (ed. or. 2008). - Guccione 2019
Pensiero e azione in Luigi Sturzo prete e statista, Trapani, Edizioni Il Pozzo di Giacobbe, 2019. - Labanca 2008
Nicola Labanca, Morire per l’Impero. Su cifre e parole per i caduti italiani di una guerra coloniale fascista, in La morte per la patria. La celebrazione dei caduti dal Risorgimento alla Repubblica, a cura di Oliver Janz, Lutz Klinkhammer, Roma, Donzelli, 2008, pp. 119-156. - Labanca 2015
Nicola Labanca, La guerra d’Etiopia. 1935-1941, Bologna, il Mulino, 2015. - Mantelli 2011
Elena Mantelli, L’Episcopato emiliano e la guerra d’Etiopia, in «Ricerche Storiche», 112 (ottobre 2011), pp. 25-56. - Mantelli 2012
Elena Mantelli, Don Cesare Bizzarri: dal pulpito al confino. La “dolorosa eccezione” di un prete confinato per aver parlato in chiesa contro la guerra d’Etiopia, in «Archivio storico per le province parmensi», 44 (2012), pp. 517-545. - Menozzi 1997
Daniele Menozzi, La Chiesa nell’Emilia-Romagna contemporanea, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. L’Emilia-Romagna, a cura di Roberto Finzi, Torino, Einaudi, 1997, pp. 411-444. - Moro 2020
Renato Moro, Il mito dell’Italia cattolica. Nazione, religione e cattolicesimo negli anni del fascismo, Roma, Studium, 2020. - Nobili 2008
Elena Nobili, Vescovi lombardi e consenso alla guerra: il cardinale Schuster, in L’impero fascista. Italia ed Etiopia (1935-1941), a cura di Riccardo Bottoni, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 267-284. - Patanè 2012
Antonio Patanè, D. Evasio Colli, da parroco piemontese a Vescovo di Acireale, in «Memorie e rendiconti dell’Accademia di Scienze Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici», 1 (2012), pp. 145-192. - Patanè 2015
Antonio Patanè, Evasio Colli. V vescovo di Acireale. Tra pastorale e catechesi, eruzione dell’Etna, convegni diocesani, Patti Lateranensi, scontri istituzionali e vertenze sacerdotali (1927-1932), Viagrande, Algra, 2015. - Preziosi 1996
Ernesto Preziosi, Obbedienti in piedi. La vicenda dell’Azione Cattolica in Italia, Torino, SEI, 1996. - Riccardi 1981
Andrea Riccardi, I clerico-fascisti, in Giorgio Campanini, Francesco Traniello, Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860-1980, vol. I, tomo 1, I fatti e le idee, Torino, Marietti, 1981, pp. 79-84. - Riccardi 1995
Andrea Riccardi, I vescovi italiani e la seconda guerra mondiale, in «Anuario de historia de la Iglesia», 4 (1995), pp. 147-165. - Riccardi 1996
Andrea Riccardi, Vescovi, parroci, Azione cattolica, in Sulla crisi del regime fascista 1938-1943. La società italiana dal «consenso» alla Resistenza. Atti del convegno nazionale di studi. Padova, 4-6 novembre 1993, a cura di Angelo Ventura, Venezia, Marsilio, 1996, pp. 523-538. - Salvemini 1967
Gaetano Salvemini, Pio XI e la guerra etiopica, in Id., Preludio alla seconda guerra mondiale, a cura di Augusto Torre, Opere di Gaetano Salvemini, vol. III, Milano, Feltrinelli, 1967, pp. 741-763. - Scoppola 1978
I cattolici di fronte al fascismo e alla rinascita democratica, in «Fascismo Antifascismo e Resistenza». Seminario di studi storici, Trento, Comitato per il 30° Anniversario della Resistenza e della Liberazione, 1978, pp. 203-215. - Sicuri 2015
Fiorenzo Sicuri, Parma nell’età liberale. 1860-1925, Fidenza, Mattioli 1885, 2015. - Sicuri 2017
Fiorenzo Sicuri, Parma nel regime fascista. 1925-1940, in Storia di Parma, vol. VII, Il Novecento, tomo 1, La vita politica, a cura di Giorgio Vecchio, Parma, MUP, 2017, pp. 117-169. - Soave 1995
Sergio Soave, Fascismo, Resistenza, Regione, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. La Valle d’Aosta, a cura di Stuart J. Woolf, Torino, Einaudi, 1995, pp. 677-742. - Taddei, Vitale 2021-2022
Latino Taddei, Domenico Vitale, Il monumento a Vittorio Bottego a Parma. Uso pubblico e rimozione collettiva di un simbolo del colonialismo italiano, in Sul piedistallo della storia. Monumenti e statue in Emilia-Romagna dall’Ottocento a oggi, a cura di Sofia Nannini, Elena Pirazzoli, Roma, Viella, 2022, pp. 117-145 (pubblicato online in «E-Review», 8-9, 2021-2022, https://e-review.it/taddei_vitale_monumento_a_bottego). - Terhoeven 2006
Petra Terhoeven, Oro alla patria. Donne, guerra e propaganda nella giornata della Fede fascista, Bologna, il Mulino, 2006 (ed. or. 2003). - Tramontin 1985
Silvio Tramontin, La Chiesa veneziana dal 1938 al 1948, in La Resistenza nel Veneziano. La società veneziana tra fascismo, resistenza, repubblica, a cura di Giannantonio Paladini, Maurizio Reberschak, Venezia, Università di Venezia – Comune di Venezia – Istituto veneto per la storia della Resistenza, 1985, pp. 451-501. - Triani 1981
Altre lettere pastorali, scritti, documenti, discorsi raccolti nel 10. Anniversario della morte. Evasio colli. Testimonianze, a cura di Pietro Triani, Parma, Tipografia Benedettina, 1981. - Triofini 1998
Paolo Trionfini, Una storia lunga un secolo. L’Azione cattolica a Parma (1870-1982), Parma, Fiaccadori, 1998. - Truffelli, Vecchio 2002
Giuseppe Micheli nella storia d’Italia e nella storia di Parma, a cura di Matteo Truffelli, Giorgio Vecchio, Roma, Carocci, 2002. - Vitale 2024
Domenico Vitale, I “Leoni” di Passo Uarieu. Le camicie nere della 180° legione Farnese nella guerra d’Etiopia (1935-1936), in «E-Review», 11 (2024), https://e-review.it/vitale_legione.
Note
1. Un nobilissimo appello di S.E. il Vescovo, in «Corriere Emiliano», 17 novembre 1935.
2. Archivio Apostolico Vaticano (AAV), Archivio della Nunziatura d’Italia, b. 70, fasc. 1.
3. I dati sono relativi all’anno 1936: AAV, Congregazioni Concistoriali, Relationes Dioecesum, 606. Relatio de statu Dioecesis Parmensis facta anno 1936 ad normam codicis juris canonici (Can. 340).
4. Il solenne ingresso di S.E. Mons. Evasio Colli in Parma festante, in «Corriere Emiliano», 13 settembre 1932.
5. Saluto al nuovo vescovo di Parma, in «Corriere Emiliano», 11 settembre 1932. Cfr. S.E. Monsignor Evasio Colli nominato vescovo di Parma, in «Corriere Emiliano», 12 maggio 1932.
6. Lettera di S. Ecc. Rev.ma Mons. Nostro Vescovo, in «Vita Nuova», 8 ottobre 1932.
7. Mille lire di S.E. Mons. Colli all’Ente Opere Assistenziali. Altre cospicue elargizioni, in «Corriere Emiliano», 10 settembre 1932.
8. La rinascita dei nostri centri rurali. La nuova sede municipale di Neviano Arduini. S.E. il Vescovo di Parma benedice l’edificio dedicato ai Caduti, in «Corriere Emiliano», 8 novembre 1932.
9. Le scuole di Trecasali dedicate ai Caduti solennemente inaugurate da S.E. il Prefetto e dal Segretario Federale, in «Corriere Emiliano», 5 novembre 1932.
10. La distribuzione di 350 pacchi delle Dame della Carità di S. Vincenzo, in «Corriere Emiliano», 5 gennaio 1933; Fiera delle Dame della Carità, in «Corriere Emiliano», 4 aprile 1933.
11. Altre cospicue opere pubbliche inaugurate in Provincia alla presenza di S.E. il Prefetto e del Segretario Federale, in «Corriere Emiliano», 6 novembre 1934.
12. La responsabilità del governo etiopico nei tragici avvenimenti, in «Corriere Emiliano», 24 gennaio 1935; Continuano le partenze dei reparti per l’Africa Orientale, in «Corriere Emiliano», 27 febbraio 1935; Una pagina di eroismo italiano. “Adua”, in «Corriere Emiliano», 2 marzo 1935; Un aggressivo e minaccioso discorso del Negus Neghesti, in «Corriere Emiliano», 24 aprile 1935; In terra etiopica, in «Corriere Emiliano», 25 aprile 1935.
13. Tradizione romana e pionieri italiani in Etiopia, in «Corriere Emiliano», 23 aprile 1935.
14. L’ardente saluto delle Camicie Nere e del popolo. La consegna del Labaro dell’80° Legione, in «Corriere Emiliano», 18 maggio 1935.
15. L’ardente saluto delle Camicie Nere e del popolo. La benedizione della Fiamma, in «Corriere Emiliano», 18 maggio 1935.
16. Tutti a Lourdes, in «Corriere Emiliano», 3 agosto 1935.
17. Il superbo, compatto, fierissimo atto di fede di Parma volontarista e squadrista, in «Corriere Emiliano», 3 ottobre 1935.
18. Le parole, come la successiva citazione, sono tratte da «L’Eco», ottobre 1935.
19. Si veda la prima pagina del «Corriere Emiliano», 3 ottobre 1935.
20. Un nobilissimo appello di S.E. il Vescovo, in «Corriere Emiliano», 17 novembre 1935.
21. L’annuale della Marcia su Roma celebrato a Milano, in «Corriere Emiliano», 29 ottobre 1935.
22. La solenne inaugurazione del Sacrario dell’Asilo Monumento dei Caduti, in «Corriere Emiliano», 12 novembre 1935.
23. Un nobilissimo appello di S.E. il Vescovo, in «Corriere Emiliano», 17 novembre 1935.
24. Il Vescovo di Parma dona alla Patria la collana pettorale, in «Corriere Emiliano», 28 novembre 1935.
25. La nobile pastorale di S.E. il Vescovo, in «Corriere Emiliano», 29 novembre 1935.
26. “Il nostro dovere nell’ora presente”. Il nobile appello di S.E. il Vescovo, in «Corriere Emiliano», 19 novembre 1935.
27. Venticinquemila anelli nuziali offerti alla Patria. Magnifico spettacolo di fierezza, di entusiasmo, di disciplina, in «Corriere Emiliano», 19 dicembre 1935.
28. Venticinquemila anelli nuziali offerti alla Patria. Magnifico spettacolo di fierezza, di entusiasmo, di disciplina, in «Corriere Emiliano», 19 dicembre 1935.
29. Ferro per fede, in «Corriere Emiliano», 19 dicembre 1935.
30. Le “fedi” verranno deposte nell’elmo di battaglia Alessandro Farnese, in «Corriere Emiliano», 18 dicembre 1935.
31. Venticinquemila anelli nuziali offerti alla Patria. Magnifico spettacolo di fierezza, di entusiasmo, di disciplina, in «Corriere Emiliano», 19 dicembre 1935.
32. «Osservatore Romano della Domenica», 22 dicembre 1935, 29 dicembre 1935 e 26 gennaio 1936. Anche il vescovo di Fidenza benedisse le fedi e donò quella di sua madre: Oltre 1500 “fedi” donate dalle donne di Fidenza, in «Corriere Emiliano», 28 dicembre 1935.
33. 41.113 “fedi” nuziali offerte alla Patria dalla nostra Provincia, in «Corriere Emiliano», 28 dicembre 1935.
34. A S. Secondo, in «Corriere Emiliano», 24 dicembre 1935.
35. Vita e interessi della Provincia – Oro e argento alla Patria, in «Corriere Emiliano», 18 dicembre 1935.
36. La nobile pastorale di S.E. il Vescovo, in «Corriere Emiliano», 29 novembre 1935.
37. Vita e interessi della Provincia – Oro e argento alla Patria, in «Corriere Emiliano», 17 dicembre 1935.
38. Vita e interessi della Provincia – Oro e argento alla Patria, in «Corriere Emiliano», 18 dicembre 1935.
39. Oro e argento alla Patria – A Palanzano, in «Corriere Emiliano», 27 dicembre 1935.
40. Vita e interessi della Provincia – Oro e argento alla Patria, in «Corriere Emiliano», 20 dicembre 1935.
41. Da Fontanellato – La Lampada votiva, in «Corriere Emiliano», 19 dicembre 1935.
42. Vita e interessi della Provincia – Oro e argento alla Patria, in «Corriere Emiliano», 20 dicembre 1935.
43. Oro alla Patria – Collecchio, in «Corriere Emiliano», 21 dicembre 1935.
44. L’attestato è conservato presso l’Archivio Storico Diocesano di Parma (ASDPr), fondo diari parrocchiali, Fugazzolo (Berceto – San Ciriaco) n. 24.
45. ASDPr, Dizionario biografico del clero di Parma, a cura di don Enrico Dall’Olio, fasc. Violi don Giuseppe.
46. Varano Marchesi – Befana fascista, in «Corriere Emiliano», 25 gennaio 1935.
47. La lettera è riprodotta in Oro alla Patria, in «Corriere Emiliano», 21 dicembre 1935.
48. Archivio di Stato di Parma (ASPr), Gabinetto di Questura – fondo A8, fasc. Bizzarri don Cesare. Comunicazione della questura di Parma al prefetto. Parma, 19 febbraio 1935.
49. ASPr, Gabinetto di Questura – fondo A8, fasc. Bizzarri don Cesare. Richiesta di autorizzazione a procedere della compagnia dei carabinieri di Fidenza alla questura di Parma. Parma, 10 aprile 1935.
50. ASPr, Gabinetto di Questura – fondo A8, fasc. Bizzarri don Cesare. Lettera di monsignor Colli al questore di Parma. Parma, 10 aprile 1935.
51. ASPr, Gabinetto di Questura – fondo A8, fasc. Bizzarri don Cesare. Lettera di monsignor Colli a Mussolini. Parma, 10 aprile 1935.
52. «L’Eco», gennaio 1936.
53. ASPr, Gabinetto di Questura – fondo A8, fasc. Bizzarri don Cesare. Rapporto del maggiore Tommaso Acconcia, comandante della divisione di Parma, alla questura di Parma. Parma, 16 maggio 1935.
54. Si veda quanto riportato nel diario parrocchiale, conservato nell’Archivio Storico Parrocchiale di Vigheffio (ASPV).
55. Vi fu una visita pastorale nel 1937: ASPV, Diario parrocchiale. Cfr. Torrile – Nozze d’argento parrocchiali, in «Corriere Emiliano», 21 marzo 1939.
56. Il Te Deum di ringraziamento in Duomo. L’elevata parola del Presule alla presenza di tutte le autorità e di una enorme folla, in «Corriere Emiliano», 10 maggio 1936.
57. Archivio Istituto Luce, Giornale Luce B/B0953, I cittadini di Parma salutano il ritorno della 180° Legione Camicie Nere reduce dall’Africa, 9 settembre 1936.
58. La benedizione del Vescovo, in «Corriere Emiliano», 29 agosto 1936.
59. La benedizione del Vescovo, in «Corriere Emiliano», 29 agosto 1936.
60. «L’Eco», gennaio 1938.
61. «L’Eco», maggio-giugno 1940.
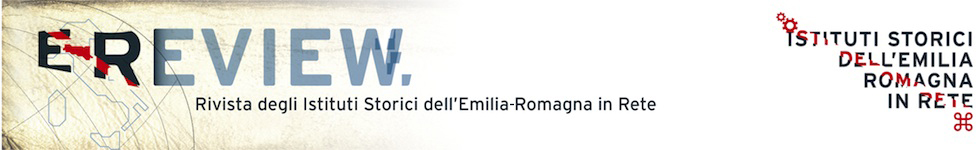
![Fig. 1. Il vescovo Evasio Colli durante una cerimonia insieme alle autorità civili, anni Trenta [Bonardi 1987].](./../../sites/default/images/articles/media/319/melegari_elmo_01.jpg)
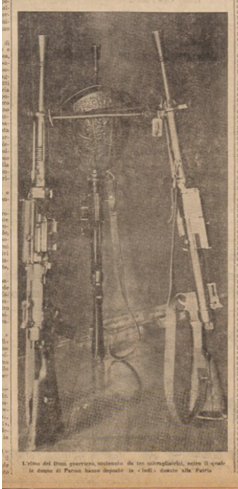
![Fig. 4. Don Cesare Bizzarri (anni Trenta o Quaranta) [ASDPr, Dizionario biografico del clero di Parma, a cura di don Enrico Dall’Olio, fasc. Bizzarri don Cesare].](./../../sites/default/images/articles/media/319/melegari_elmo_04.jpg)



