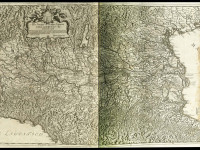1. Le radici storiche della vulnerabilità padana
In un recente volume, Uomini e fiumi, lo storico Franco Cazzola, attingendo ad un poderoso corpus di documenti archivistici e fonti a stampa, ha minuziosamente ricostruito il processo di territorializzazione della bassa pianura padana nel corso dell’età moderna [Cazzola 2021]. Lungo la riva destra del Po, tra la foce dell’Enza e il mare Adriatico, si snoda un sistema idrografico estremamente complesso e particolarmente fragile, caratterizzato da numerosi corsi d’acqua che provenendo dall’Appenino tosco emiliano e tosco romagnolo si dirigono a forma di pettine verso il Po. Questa intricata rete fluviale fu teatro di complesse dinamiche sociali e di aspre lotte politiche che coinvolsero diversi Stati preunitari a cavallo tra epoca moderna ed età contemporanea [Guidoboni 1998, 281].
Fin dal primo capitolo, Cazzola ha ricordato come la storia di quell’area fu profondamente segnata da un evento idrologico di portata catastrofica: la rotta – o meglio le rotte – di Ficarolo (Rovigo), avvenute a partire dal 1152 per circa un ventennio. Fino a quella data, il Po seguiva un tracciato profondamente diverso dall’attuale [Cazzola 2021, 56]. Rispetto al percorso odierno, il fiume scorreva con relativa fedeltà fino ad Ostiglia (Mantova), dove svoltava decisamente verso sud passando per Bondeno (Ferrara) e Ferrara. Poco dopo la città estense, in località Punta San Giorgio, il Po si divideva in due bracci principali: il ramo settentrionale di Volano (Ferrara), che sfociava 35 chilometri a nord di Marina di Ravenna, e quello meridionale di Primaro, oggi corrispondente all’ultimo tratto del fiume Reno, che si gettava in Adriatico, dieci chilometri a nord del sito ravennate. I numerosi affluenti appenninici che tentavano di immettersi nel Po, trovando l’alveo di quest’ultimo rialzato rispetto al piano di campagna, spagliavano le proprie acque nelle terre circostanti, formando un grande sistema di valli acquitrinose e in parte boschive conosciuto come Padusa. Oggi di quel sistema restano ancora in piedi le valli di Comacchio [Gambi 1950; Cazzola 2021, 31-33].
Con la rotta del 1152 si delineò una nuova asta fluviale assai più settentrionale – il cosiddetto Po di Venezia – che, seguendo pressappoco l’odierno tragitto, attraversava l’intera provincia di Rovigo approdando in mare oltre 40 chilometri più a nord del ramo di Primaro. Secondo l’ingegner Giovanni Veronesi, autore nel 1858 di Cenni storici sulle vicende idrauliche della bassa pianura bolognese, senza la rotta di Ficarolo, la Padusa si sarebbe col tempo bonificata per colmata trasformandosi in un fertile altopiano [Veronesi 1858, 4-5]. Lo sviluppo del Po di Venezia, invece, accrebbe la precarietà dell’intero settore meridionale della pianura padana, in particolare del triangolo situato tra le province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Mentre nel Seicento, infatti, la piena del Po di Venezia raggiungeva un’altezza di 28 piedi, il Po di Ferrara faticava a superare i sei piedi [Manfredi 1758, 271-272; Veronesi 1858, 11-12]. La diminuita velocità della corrente causava un accumulo di sedimenti lungo l’antico percorso, provocando un innalzamento generale dell’alveo. Tale fenomeno, noto come aggradazione, oltre ad ostacolare il deflusso delle acque del vecchio Po, influenzava negativamente il regime idraulico dei principali affluenti appenninici, con rotte sempre più frequenti che interessavano i fiumi alla destra del Primaro. Veronesi descriveva con queste parole le conseguenze di quell’interramento:
Tale conseguenza di un alzamento di fondo, sempre più sensibile verso le parti superiori, fu l’eccidio di tutta la pianura posta alla destra di quel ramo. I torrenti tributari furono obbligati di alzare ugualmente gli alvei rispettivi; ed ecco il perché d’allora innanzi vi accaddero rotte così frequenti. Gli scoli, subendo a poco a poco una diminuzione, e infine un’assoluta perdita di declivio, non poterono più scaricarsi entro il Po, o ne’ suoi influenti; e rimanendo senza sfogo, furono costretti ad espandersi per le basse campagne; le quali, diventate così il ricettacolo e delle acque provenienti dalle rotte dei fiumi, e di quelle degli scoli, si tramutarono in estesi stagni e in isquaillide paludi [Veronesi 1858, 6].
Per l’ingegner Elia Lombardini, forse il più grande studioso d’idraulica padana dell’Ottocento, ci vollero alcuni secoli prima che il corso attuale del fiume prendesse il sopravvento sul Po di Ferrara. Ancora nel Trecento, soltanto un quarto delle acque prendeva la via settentrionale, mentre i tre quarti continuavano equamente a scorrere tra Volano e Primaro [Lombardini 1852, 23]. Tra Quattro e Cinquecento, la maggior brevità del tracciato settentrionale indusse il progressivo interramento del cosiddetto Po di Ferrara [Lombardini 1852, 12]. In quel periodo gli Estensi attuarono numerosi sforzi per impedire il prosciugamento della via d’acqua che congiungeva il Ducato di Ferrara al mare. Nel 1522-1526, per rivitalizzare il Po di Ferrara, il Reno fu deviato sino alla località Porotto, cinque chilometri a monte della biforcazione tra Volano e Primaro. Tuttavia, come ricordato dal canonico Francesco Bertoldi, autore nel 1807 di Memorie per la storia del Reno, l’immissione delle acque torbide del Reno nel Po di Ferrara, pur contribuendo a prosciugare numerose valli del bolognese, aggravò l’insabbiamento del vecchio corso d’acqua [Bertoldi 1807, 28-36]. In effetti, il congiungimento tra Reno e Primaro peggiorò la frequenza degli eventi alluvionali, tanto che tra 1522 e 1542 il Po di Ferrara ruppe gli argini per ben 40 volte [Bertoldi 1807, 36-37]. Fu così che nel 1604 si recise il legame dell’antico ramo di Primaro con il Reno, il quale tornò ad allagare le valli di San Martina e Marrara. Tra il 1740 e il 1758, Papa Benedetto XIV, proprietario di diverse tenute perennemente alluvionate, promosse la costruzione di un grande canale scolmatore (cavo benedettino) che – mediante una svolta ad angolo retto – immetteva le acque del Reno nel tratto finale del vecchio tracciato del Primaro.
Tuttavia, fu soltanto con i lavori avviati nel 1767 sotto la guida di Antonio Lecchi, che la deviazione del corso d’acqua bolognese, le cui acque tendevano a rivolgersi verso settentrione interrando il cavo benedettino, riuscirono a condurre il Reno fino al mare [Lecchi, Temanza, Verace 1767]. Sorte diversa ebbe invece il Panaro, l’altro grande affluente di destra del Po. Sebbene vi fosse stato un tentativo nel 1621 di indirizzare il corso d’acqua modenese sino al Po di Ferrara per riattivarne la navigazione, nel 1638, viste le continue rotte, si decise di rivolgere tutti i principali fiumi dell’Emilia-Romagna, eccezion fatta per il Reno, verso il Po grande di Venezia. Da quel momento, le correnti del ramo settentrionale di Volano furono esclusivamente alimentate da acque di scolo, riducendo tale braccio alla condizione di naviglio a malapena navigabile [Lombardini 1852, 12-14].
Tra XVIII e XIX secolo, la bonifica del territorio emiliano-romagnolo conobbe una significativa accelerazione [Gambi 1949; Sereni 1961, 371-382, 423-436]. Attraverso la costruzione di una fitta rete di scolmatori, canali, collettori, capofossi e scoline, a cui si aggiunsero importanti opere ingegneristiche quali arginature, botti, chiaviche e chiuse, si cercò di alleggerire la portata massima dei fiumi riducendone tracimazioni e rotte [Menzani 2008]. Inoltre, le acque stagnanti della bassa pianura furono convogliate entro un sistema irriguo capace di drenare i fluidi e derivare acqua per irrorare le colture estive. Un caso emblematico fu costituito dal risanamento della Burana: una vasta area triangolare di oltre 83.000 ettari delimitata dai fiumi Po, Secchia e Panaro tra le province di Mantova, Modena e Ferrara. Anticamente, le acque di questa zona – conosciuta anche come depressione del Bondeno – scolavano, per mezzo di un collettore, nel Po di Ferrara in località Burana. In epoca moderna, a causa del progressivo innalzamento del letto fluviale, il sistema di drenaggio divenne inefficace, lasciando le campagne perennemente allagate [Lombardini 1852, 40-42]. Se ciò non bastasse, durante le piogge più intense, una volta serrate le chiaviche alla destra del Po di Venezia (Sermide, Quatrelle e Pilastri) e alla sinistra del Panaro (Bova), le località di Mirandola (Modena), Poggio Rusco (Mantova) e Bondeno (Ferrara), trovandosi al di sotto del piano di campagna, ricevevano le acque di scolo della pianura modenese sovrastante. Nel 1598 Clemente VIII ordinò la costruzione di un canale che avrebbe dovuto oltrepassare i fiumi Reno e Panaro, trasportando le acque reflue della Burana fino al Polesine di San Giorgio: il vecchio delta del Po tra Volano e Primaro. Tale proposta restò lettera morta e fu ripresa soltanto nel 1810 dal Governo napoleonico. In quell’anno si appaltò l’edificazione di un canale dotato di una botte sotto al Panaro, che convogliava le acque reflue della Burana sino al vecchio Po di Volano e dunque in Adriatico. Malgrado gli sforzi, prima la caduta di Napoleone e, diversi decenni più tardi le terribili alluvioni del 1872, decretarono l’interruzione dell’opera. Dopo l’Unità d’Italia, le bonifiche ripresero con vigore grazie alla legge promossa nel 1882 dal ministro dei Lavori pubblici, il ravennate Alfredo Baccarini. Tale provvedimento, noto ufficialmente come Norme per la bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi, prevedeva il risanamento di 200.000 ettari di terre con l’obiettivo di migliorare le condizioni igienico-sanitarie del Paese. Sul fronte delle spese, la legge Baccarini disciplinava l’intervento dello Stato nella misura del 50%, a cui si aggiungevano, in misura paritaria, i contributi degli enti locali (comuni e province) e quelli dei proprietari privati che avrebbero beneficiato di nuove superfici coltivabili. La normativa potenziò il ruolo dei consorzi, enti pubblici incaricati di promuovere e gestire i progetti di bonifica, e rafforzò la funzione del Genio civile, organo statale deputato al controllo, monitoraggio e supervisione delle opere pubbliche realizzate nelle aree periferiche. In forza della legge Baccarini, il 20 giugno 1886, fu inaugurata la botte napoleonica e pochi anni più tardi fu condotta a termine la bonifica della Burana [Maganzini 1887, 506-507].
Dalla seconda metà del Settecento, malgrado avanzasse il risanamento delle paludi, emergevano «nuovi squilibri» che pregiudicavano l’efficacia dell’azione bonficatoria [Bevilacqua, Rossi Doria 1984, 12-17]. Per molti studiosi dell’epoca, i grandi disboscamenti realizzati in montagna e i dissodamenti attuati in pianura aggravavano il fenomeno del dissesto idrogeologico, aumentando la velocità con cui le acque da monte si dirigevano a valle. Così, Lombardini, riprendendo le considerazioni di illustri scienziati come Vincenzo Viviani, Francesco Mengotti e Alexandre Surell, riteneva che i rimboschimenti, coadiuvati dalla presenza di briglie fluviali, fossero in grado di «moderare l’affluenza delle acque scorrenti sulle pendici de’monti , e ad arrestare […] un’ulteriore escavazione e dirupamento del terreno» [Lombardini 1852, 26]. Altri esperti, invece, puntavano il dito contro l’irreggimentazione del sistema fluviale, che costringeva ad edificare argini sempre più alti [Atti parlamentari 1880, 44-45]. Tra questi, Maurizio Brighenti, autore nel 1860 del pamphlet Sull’effetto del disboscamento e dissodamento dei monti, ricordava che la causa di allagamenti e rotte del Po e dei suoi affluenti fosse unicamente attribuibile alla progressiva canalizzazione dell’alveo. Durante le piene, le acque, costrette entro argini sempre più angusti, esercitavano un’enorme pressione sul greto e le sponde del fiume. Di fronte all’innalzamento dei livelli idrometrici e all’incremento della pressione sugli argini, maturava il rischio di esondazioni e rotture:
La cresciuta e tanto lamentata altezza delle piene del Po ai nostri giorni è derivata manifestamente dall’essere mutata per opera del fiume e dell’uomo la forma del vaso, e divenuta di amplissima che innanzi era, mano mano più angusta. Ed ormai angustissima [Brighenti 1860, 201].
In realtà, tanto Lombardini quanto Brighenti coglievano due aspetti fondamentali del problema. Da un lato, l’espansione delle aree coltivate e i massicci disboscamenti alteravano la capacità del suolo di drenare le acque e accrescevano il fenomeno dell’erosione superficiale. Di fronte a intense piogge, i terreni argillosi e sabbiosi, privati del manto vegetale, tendevano a depositarsi sotto forma di sedimenti lungo gli alvei fluviali determinando la progressiva crescita delle altezze idrometriche. Dall’altro, l’innalzamento di argini e le canalizzazioni rendevano il reticolo idrico più rigido e vulnerabile impedendo la naturale espansione dei fiumi verso le aree golenali. Ciò provocava l’aumento della velocità delle acque nonché il sollevamento delle altezze di piena [Bacchi, Orlandini, Pellegrini 2007, 158-161]. Se ciò non bastasse, durante la cosiddetta piccola era glaciale (1450-1850), si registrò un deciso peggioramento climatico con l’intensificazione di precipitazioni nevose e piovose. Come sottolineato nel 1998 da Emanuela Guidoboni, a partire dal XVI secolo, a fronte di un aumento moderato delle precipitazioni – per altro difficilmente stimabile – si registrarono profonde trasformazioni demografiche, economiche ed istituzionali che incisero sulla crescita dei fenomeni alluvionali. L’aumento della popolazione, il disboscamento dei versanti, la bonifica delle aree umide e la crisi del sistema di manutenzione degli argini, ancora fondato sull’apporto delle famiglie contadine, provocarono ingenti modificazioni nell’assetto territoriale [Guidoboni 1998, 303-304]. Nel corso del Seicento, lungo il cosiddetto Po di Venezia, si annoverarono quattro grandi inondazioni che crebbero a otto nel Settecento e dieci nell’Ottocento. Nel XX secolo, sebbene gli episodi più significativi si ridussero a sei, l’intensità delle piene crebbe notevolmente, rilevando ogni volta un livello idrometrico superiore al precedente [Bacchi, Orlandini, Pellegrini 2007, 145-146].
Ancora oggi, secondo l’ultimo rapporto pubblicato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), le regioni della pianura padana sono le tra più esposte al rischio alluvionale. In particolare, Lombardia (10.2%), Veneto (13.3%) ed Emilia-Romagna (45.6%) mostrano una percentuale di pericolosità idraulica media – ovvero di territorio potenzialmente allagabile – superiore alla media nazionale.
Tra queste, merita una menzione particolare l’Emilia-Romagna, che rappresenta il territorio italiano più vulnerabile per le inondazioni. I dati dell’Ispra segnalano come l’11.6% della superfice regionale – equivalente a quasi 2.600 km2 – presenti un rischio idraulico elevato, mentre il 45.6 % – corrispondente a ben 10.200 km2 – mostri un indice di livello medio [Ispra 2021]. Sono gli stessi studiosi Ispra a riassumere le ragioni di una condizione tanto allarmante:
La notevole estensione delle aree allagabili […] per la Regione Emilia Romagna è legata alla presenza di una complessa ed estesa rete di collettori di bonifica e corsi d’acqua minori che si sviluppano su ampie aree morfologicamente depresse, di tratti arginati spesso lungo alvei stretti e pensili, di regimazioni e rettifiche in specie nei tratti di pianura. […] Il reticolo di bonifica per lo più insufficiente in modo generalizzato, provoca allagamenti diffusi su porzioni molto ampie del territorio [Ispra 2021, 49].
Se al dato sulle inondazioni, poi, aggiungessimo che il 14.6% della superficie regionale è interessata da frane – ben 3.270 km2 – scopriremmo che, eccezion fatta per il caso particolare della Valle d’Aosta, l’Emilia-Romagna è di gran lunga la regione italiana a maggior rischio idrogeologico. Come ha scritto recentemente Stefano Piastra, «in prospettiva geostorica», l’alluvione verificatasi nel maggio 2023, pur costituendo un evento di portata eccezionale, può essere considerata il portato di una secolare condizione di fragilità del territorio romagnolo [Piastra 2024, 65].
Dopo aver sinteticamente delineato le radici profonde dell’instabilità idraulica del bacino padano, nel prossimo paragrafo si analizzeranno le maggiori piene del Po nel corso del Novecento. Per tale approfondimento, ci si baserà principalmente sulle fonti provenienti da due quotidiani: «Corriere della Sera», a livello nazionale, e «Il Resto del Carlino», più radicato nel contesto locale. La scelta di queste due testate risponde all’esigenza di combinare una prospettiva nazionale, utile a comprendere la rilevanza politica e mediatica degli eventi, con una lettura locale, più attenta alle dinamiche territoriali e all’impatto sulle comunità. Pertanto, l’intreccio di queste fonti consente di cogliere sia la costruzione di una narrazione pubblica a scala nazionale, sia le modalità con cui gli eventi furono percepiti e vissuti dagli abitanti del territorio.
2. L’alluvione del 1907
Dopo le disastrose inondazioni del Po del 1872 e 1879, la prima grande alluvione del XX secolo si verificò alla fine di ottobre del 1907, investendo Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. A Piacenza, alle 4 del mattino del 27 ottobre, il fiume superava di 8 metri il primo livello di guardia. Sei ore più tardi, alle 10, l’idrometro segnava 8,40 metri. Nel corso della serata, nonostante l’alveo del fiume raggiungesse in quel tratto i 500 metri di larghezza, le acque strariparono sommergendo le campagne circostanti. Secondo quanto riportato dal «Corriere della Sera», il Piacentino «per chilometri e chilometri intorno è una distesa d’acque che non ha più limiti, che si confonde con l’orizzonte». In alcuni punti, specie lungo i terreni coltivati, in poche ore il livello raggiunse i tre metri d’altezza [1]. Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, sotto l’impeto della corrente, l’argine destro ruppe in località Porta Borghetto, provocando «con una violenza ed una irruenza impressionanti» l’inondazione della “città bassa”. Centinaia di famiglie trovarono rifugio ai piani superiori e sui tetti delle case e, passata la piena, furono costrette ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni. I cronisti sottolineavano come la città, pur esposta al rischio alluvionale, non era mai stata subissata dalle acque: al torrione Fodesta e presso il quartiere di Porta Borghetto il livello oltrepassava di circa due metri e mezzo il piano stradale. I primi soccorsi furono diretti dal colonnello Capello – figura passata alla storia nel corso della Grande guerra – che coordinò con efficienza le operazioni del Genio civile, della Croce bianca e della Croce rossa [2]. Il 30 ottobre, il quotidiano riferiva che malgrado la città fosse ancora allagata, la piena era finalmente in remissione, toccando i 7,80 metri sopra la soglia [3]. Ad est di Piacenza, la rottura dell’argine presso il paese di Mortizza, provocò la distruzione dell’abitato e la morte di almeno tre persone [4].Tra i commenti più critici, un articolo osservava che sebbene le cause delle alluvioni fossero difficilmente attribuibili – «la mano degli uomini ha avuto parte in questo cambio di scena? C’è chi dice di sì, ma c’è chi dice di no» – la confusione amministrativa giocava senz’altro un ruolo di prim’ordine. La presenza di una moltitudine di enti, dal Genio civile alle province fino ai consorzi, generava un’inutile moltiplicazione di disposizioni, spesso contrastanti. Perfino le popolazioni delle opposte rive del fiume, anziché collaborare, si trovavano in conflitto. Ciascuno sperava, con amara ironia, che a cedere fosse l’argine opposto. In effetti, come documentato dalle cronache locali, non mancarono sabotaggi alle sponde situate sul versante dirimpetto [5]. In un contesto dove avrebbe dovuto prevalere la cooperazione, dominava invece l’antagonismo, alimentato da interessi locali e rivalità storiche, che finivano per compromettere ogni tentativo di gestire in maniera integrata la questione del dissesto idrogeologico [6]. Un editoriale del primo novembre, dopo aver sottolineato come la piena del 1907 avesse superato di ben 70 centimetri la massima portata registrata nel 1857, annoverava le cause primarie e secondarie degli eventi alluvionali. Se le piogge più intense e lo scioglimento nivale costituivano il fattore scatenate, i massicci disboscamenti e le canalizzazioni realizzate in montagna, accrescevano il volume d’acqua diretto a valle. Per di più, l’ingente trasportato di sedimenti, oltre a provocare l’innalzamento del fondo, alimentava il progressivo allungamento delle foci Po, riducendo la pendenza naturale del letto [7]. Tra le voci più autorevoli, l’agronomo Tito Poggi – noto per i suoi studi a cavallo tra XIX e XX secolo – spiegava che tutti gli affluenti del Po erano “pensili”, ossia scorrevano a un livello superiore rispetto al piano di campagna. Durante le piogge, dunque, tendevano inevitabilmente a tracimare «per la ragione semplicissima che dentro non ci possono più stare». Poggi criticava duramente l’approccio delle autorità, accusate di limitarsi a soluzioni temporanee che non affrontavano il problema alla radice: «sempre si applica la medicina, mai la profilassi», scriveva l’agronomo. Già nel 1907, egli proponeva un progetto organico che unisse gli sforzi delle molteplici realtà coinvolte e affermava che fosse giunto il momento d’investire con decisione. In montagna occorrevano milioni per i rimboschimenti, per la costruzione di briglie, laghetti e serbatoi che avrebbero potuto regolare il flusso delle acque. Poggi, ricordando che «le fortezze si costruiscono prima che arrivi il nemico», sosteneva che le opere di difesa andassero realizzate in tempo di pace, non durante l’emergenza. Utilizzando un proverbio veneto aggiungeva, con amara ironia, che i rimedi frettolosi finivano spesso per aggravare la situazione: «pezo el tacon del sbrego», peggiore la toppa dello strappo. Egli, pertanto, patrocinava con urgenza la realizzazione in pianura di casse d’espansione e canali scolmatori ricorrendo all’esproprio dei terreni. Pur dichiarandosi difensore convinto della proprietà privata, ricordava che in una società progredita l’interesse pubblico doveva imporsi su quello privato. Concludendo il suo articolo, Poggi ammoniva: «si dirà che in tempo di malanni, tutti son buoni a proporre rimedi. Vero. Ma che colpa ne ho io se in Italia si dimentica la sventura sì facilmente?» [8].
Nell’editoriale del 28 ottobre 1907, i redattori del «Il Resto del Carlino» rassicuravano i lettori affermando che, nonostante le campagne circostanti fossero pesantemente allagate, Piacenza poteva ritenersi al sicuro. Gli argini che circondavano la città apparivano solidi e ben costruiti, tanto da escludere qualsiasi possibilità di disastro. La stessa conformazione topografica del territorio – con il centro urbano situato più in alto rispetto al fiume – sembrava garantire una protezione naturale [9]. Tuttavia, la situazione precipitò nel giro di poche ore, tanto che l’editoriale del giorno successivo, 29 ottobre, sottotitolava con toni drammatici: Piacenza inondata dal Po. Un migliaio di famiglie nella desolazione. L’orrore d’una notte indimenticabile. I redattori, pur sottolineando che nessuno avrebbe potuto immaginare un quadro tanto fosco, riconobbero l’infondatezza delle loro previsioni. Fortunatamente, l’allarme diramato per tempo evitò che la popolazione venisse colta di sorpresa nel pieno della notte. Nonostante ciò, le cronache del quotidiano bolognese riportavano una situazione angosciante: «quasi tutti i villaggi, quasi tutte le borgate vedono con terrore crescere d’ora in ora il livello dell’acqua» [10]. Strade, piazze, cortili si erano trasformati in una rete di canali improvvisati, solcati da barche e barchini che cercavano di raggiungere i superstiti o trasportare generi di prima necessità [11]. Se nel Piacentino si registravano le conseguenze più evidenti, l’intera regione emiliana si trovava in situazione di forte criticità. Nel Reggiano, a Gualtieri, per alleggiare la pressione dell’acqua fu decisa la rottura controllata dell’argine del Po. L’operazione, necessaria per salvare i centri abitati, provocò l’allagamento di oltre 60 ettari di terre appartenenti alla nobile famiglia Malaspina [12]. Anche le località di Brescello, Luzzara e Guastalla (Reggio Emilia) vennero colpite dalla piena, vedendo i propri campi subissati con ingenti danni per l’economia agricola [13]. Nel Parmense, si verificarono diverse rotte di torrenti minori, mentre il grande fiume traboccò e invase la linea ferroviaria Parma-Brescia [14]. Non soltanto il Po destava preoccupazione. L’intero reticolo idraulico regionale, a cominciare dal Reno, annoverava un innalzamento pericoloso. A Casalecchio, nel Bolognese, il livello delle acque aveva superato i 2,80 metri sopra lo zero idrometrico, suscitando timori e paure [15]. Sintetizzando, l’illusoria sicurezza iniziale dei giornalisti, lasciò rapidamente spazio al racconto di una calamità diffusa. L’ondata del Po, che aveva sorpreso le autorità e la stampa, mostrò ancora una volta l’estrema vulnerabilità di ampie fasce della pianura padana, tanto che perfino la grande bonifica veniva percepita in forte pericolo [16].
3. Le piene del 1917 e 1926
Tra maggio e giugno del 1917, le cronache dei quotidiani erano quasi completamente assorbite dal serrato racconto del primo conflitto mondiale che contrapponeva il Regno d’Italia agli imperi centrali. Nel pieno della decima battaglia dell’Isonzo, lo spazio riservato agli avvenimenti interni era estremamente circoscritto. Il primo giugno, la terza pagina del «Corriere della Sera», riferiva attraverso una manciata di brevi comunicati dei Disastri e delle vittime del maltempo. Tra questi, si segnalava la tragedia di Palazzolo Milanese, dove il crollo di un ponte sul Seveso provocò la morte di 16 persone. Nel Piacentino, il livello del Po era, se possibile, ancora più allarmante di quello misurato dieci anni prima. Alle ore 16 del 31 maggio, l’idrometro a Piacenza segnava 8,82 metri sopra lo zero idrometrico, ben 17 centimetri oltre il record storico del 1907. Fortunatamente, Piacenza fu risparmiata dall’inondazione, grazie soprattutto ai nuovi argini innalzati appositamente per proteggere l’abitato. Sorte ben diversa spettò alle campagne circostanti che si trovarono rapidamente esposte al dilagare delle acque. Molti villaggi furono evacuati, mentre in località San Zenone il fiume ruppe allagando ampie porzioni della campagna pavese [17]. Il 2 giugno, i giornali riportavano come la piena avesse iniziato a ritirarsi. Le autorità del Genio civile – attraverso la manovra controllata di brecce sugli argini – riuscirono a contenere gli effetti dell’alluvione, indirizzando le acque verso le zone golenali. Malgrado ciò, in campagna i danni risultarono ingenti. Le località di San Rocco nel Lodigiano e Mortizza nel Piacentino furono nuovamente travolte dalla piena, provocando lo sfollamento di centinaia di residenti [18]. Il 4 giugno, a Santa Maria Maddalena, nel Ferrarese, il livello idrometrico toccò i 3,52 metri oltre la soglia mentre a Pontelagoscuro la furia della corrente trascinò con sé un intero bosco ripariale [19]. Complessivamente, la piena del 1917, pur risultando superiore a quella del 1907, non lasciò un’impronta altrettanto profonda nella memoria collettiva. Da una parte, l’adozione tempestiva di misure di contenimento, consentì di limitare i danni delle aree urbane. Dall’altra, il teatro di guerra, oscurò l’impatto dell’evento alluvionale che si stava consumando lungo il Po. Quella del 1917, dunque, fu a tutti gli effetti un’alluvione silenziosa e rimossa, schiacciata dal peso di una tragedia più grande che ne offuscò ogni eco. Secondo lo storico Giacomo Parrinello, il periodo tra la grande alluvione del 1872 e la piena del 1917 rappresentò un momento cruciale per lo sviluppo della scienza idrologica italiana. Dopo le pioneristiche ricerche di Elia Lombardini, nel 1873 la Commissione Brioschi avviò le prime misurazioni sperimentali per determinare le corrette altezze degli argini e la capacità di deflusso delle acque del Po nel corso degli eventi pluviometrici. Gli studiosi erano ormai consapevoli che la complessità del bacino padano – caratterizzato dalla combinazione di tributari alpini, appenninici e laghi subalpini – richiedesse l’abbandono di misurazioni sporadiche e localizzate, in favore di un approccio continuativo a grande scala. Con l’inizio del XX secolo fu dunque istituita la Commissione per lo studio della navigazione interna nella valle del Po, a cui seguì nel 1912 la fondazione dell’Ufficio speciale del Genio civile per gli studi idrografici del bacino del Po. Questi enti introdussero un sistema continuo e distribuito di monitoraggio dell’intero bacino, con una rete di stazioni dedicate alla raccolta sistematica e standardizzata di dati su precipitazioni, livelli idrometrici, temperature e portate. Fu dunque a cavallo tra XIX e XX secolo che la scienza idrologica italiana venne progressivamente integrata in un programma di azione statale, volto a mitigare e, per quanto possibile, a prevedere il rischio alluvionale in un’area che rappresentava il cuore agricolo e industriale del Paese, ma che, a causa della sua intrinseca complessità e fragilità, era spesso soggetta a eventi di carattere catastrofico [Ciarmatori 2007; Parrinello 2017].
Una situazione profondamente diversa si verificò nel maggio del 1926, in occasione della terza grande piena del secolo. Alle ore 22 del 17 maggio, il livello del Po a Piacenza raggiunse i 9,20 metri sopra lo zero idrometrico. Mentre nel Pavese il fiume aveva già superato gli argini in diversi punti, a Piacenza i quartieri settentrionali furono nuovamente allagati. Dalla Valle d’Aosta al Trentino, passando per Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il maltempo investì l’intero settentrione provocando lo straripamento di piccoli e grandi corsi d’acqua [20]. Nella notte tra il 18 e il 19 maggio, il Po ruppe nel Piacentino in almeno quattro punti: a Sant’Antonio di Trebbio, Gerbido, Mortizza e Fossadello. Medesima sorte toccò ai centri del versante lombardo, anch’essi investiti dall’ondata di piena. Sul «Corriere della Sera», un cronista osservava come il grande fiume, con inquietante cadenza decennale, fosse soggetto ad esondazioni e brecce tanto che gli abitanti del luogo conoscevano i segnali della minaccia. In tale contesto, un ruolo cruciale era svolto dalle cosiddette “guardie del Po”: figure designate dal Genio civile per monitorare costantemente lo stato degli argini, prevedere l’andamento della piena e intervenire rapidamente mediante rotture controllate [21]. Quando tra il 20 e il 21 maggio, il livello delle acque era ormai in fase calante (attestandosi a 6,37 metri sopra lo zero), si verificò una rottura dell’argine a Gussola, nel Cremonese. Secondo quanto riportato dalla stampa i danni furono ingenti. Sebbene non si registrassero vittime, oltre 20.000 pertiche cremonesi coltivate a frumento e vigna – corrispondenti a circa 1.300 ettari – finirono sott’acqua, causando perdite stimate in più di 10 milioni di lire. Durante emergenze di questo tipo, risultava fondamentale l’intervento dei contadini. Allertati dal rintocco incessante delle campane, accorrevano sugli argini per tamponare le falle con ogni mezzo disponibile: sacchi di terra, sabbia, laterizi, legna e qualsiasi altro materiale in grado di fare massa. La crisi del maggio 1926 non risparmiò le altre province del bacino padano. Nel Ferrarese, le aree golenali erano completamente allagate, costringendo le famiglie a rifugiarsi ai piani superiori delle abitazioni. Nel Parmense, il Po aveva toccato livelli record: a Roccabianca, il fiume era tracimato in diversi tratti, provocando l’evacuazione di 128 persone [22]. A sintetizzare la gravità del disastro ci pensò con una nota ufficiale del ministro dei Lavori Pubblici, Giovanni Giurati, futuro segretario del Partito nazionale fascista. Egli, sottolineando l’eccezionalità delle piene, sosteneva che il Po, al pari dell’Adige, avesse superato di diverse decine di centimetri i suoi massimi storici. L’intero sistema idrografico del Nord, dai laghi alpini ai torrenti montani, si era gonfiato in modo repentino e inaspettato, complicando ogni previsione. Eppure, nonostante l’entità del fenomeno, i danni materiali, particolarmente intensi nel Piacentino, furono tutto sommato contenuti [23].
Anche i cronisti de «Il Resto del Carlino», seguendo l’impostazione adottata dal «Corriere della Sera», dedicarono ampio spazio al racconto degli eventi di quel maggio. Le prime pagine del quotidiano riportavano titoli carichi di tensione e preoccupazione: Disastrose inondazioni in Piemonte e nel Veneto [24], Le ansiose giornate di Piacenza sotto la minaccia del Po [25]. Una narrazione densa e partecipata, che, oltre a restituire la portata dell’evento, delineava il senso di precarietà diffuso lungo tutto il bacino padano. Tra i fatti più gravi, «Il Resto del Carlino» segnalava la situazione di Caorso (Piacenza), dove l’inondazione colse del tutto impreparato il paese. Sebbene non si registrarono vittime, l’impatto sul patrimonio zootecnico fu enorme. Annegarono centinaia di vacche, migliaia di suini e una quantità incalcolabile di pollame [26]. Secondo le stime riportate dal quotidiano, nella sola provincia di Piacenza i danni superavano i 100 milioni di lire [27]. Emergeva con chiarezza il dramma vissuto dal mondo contadino, che costituiva la categoria più esposta a simili calamità. Spettava infatti a piccoli proprietari, mezzadri, fittavoli e braccianti, il gravoso compito di affrontare in prima linea l’emergenza. Costoro, non soltanto collaboravano con il Genio civile durante i lavori più urgenti di contenimento e ripristino arginale, ma provvedevano al rapido drenaggio dei campi nella speranza di evitarne l’isterilimento. Non mancavano, in queste circostanze, situazioni di conflitto. Da un lato numerosi proprietari terrieri si opponevano al taglio degli argini temendo la perdita dei propri beni; dall’altro i funzionari del Genio civile, per salvare i centri abitati, spingevano per allagare i tratti golenali di campagna. In entrambi i casi, a pagare il prezzo più alto erano sempre i contadini costretti in un caso a riportare i campi a condizioni accettabili e nell’altro a vedere le proprie abitazioni sommerse [28]. Un editoriale del 22 maggio, infine, pur non trattando specificatamente il tema delle alluvioni, esaminava il progressivo depauperamento del patrimonio boschivo. Mediante un’intervista al presidente dell’Istituto internazionale di agricoltura, si denunciava «l’indifferenza predominante» attorno alla questione forestale, sottolineando l’urgente necessità di una gestione integrata tra attività agricole e selvicolturali. Occorreva un approccio che considerasse il bosco non più come elemento accessorio, bensì come vera e propria coltura da preservare, curare e valorizzare [29].
4. Il dramma del 1951
Per affrontare un evento come quello del 1951 che, assieme all’alluvione di Firenze del 1966, costituisce uno dei momenti più significativi nella storia delle alluvioni italiane, non basterebbe un intero volume [Istituto Veneto di Scienze, Lettere ad Arti, Accademia dei Concordi di Rovigo 1994; Sorcinelli, Tchaprassian 2014; Cibotto 2021]. Anche le cronache giornalistiche, per diversi mesi, dedicarono ampio spazio all’evento. Per questo breve paragrafo, dopo una breve descrizione del fatto, si è deciso di focalizzarsi su alcuni editoriali particolarmente significativi.
Dopo un’estate e un autunno particolarmente piovosi, tra il 6 e il 12 novembre 1951 si abbatté sull’intero bacino padano (circa 70.000 km²) una quantità straordinaria di rovesci. Oltre 16,5 miliardi di metri cubi d’acqua, 5 miliardi in più del precedente record del 1926. Mediamente caddero in area padana 236 millimetri di pioggia anche se in diversi sottobacini si registrarono picchi pluviometrici assai più elevati. A rendere più critica la situazione contribuirono sia lo scioglimento nivale dovuto ad aria particolarmente calda, sia le forti mareggiate causate da venti di scirocco che ostacolarono il deflusso del Po in Adriatico [Della Valle 1953, 135-141; Ispra 2021, 35-37]. Il risultato di queste circostanze concorrenti provocò il generale dissesto idrografico, con diverse rotture e il moltiplicarsi del fenomeno dei fontanazzi: infiltrazioni violente e continue d’acqua che, penetrando sotto l’argine maestro, riemergevano come fontane lungo il piano di campagna sottostante. Il 14 maggio cedette l’argine destro allagando 13.000 ettari di terra tra le province di Parma e Reggio. Lo stesso giorno si consumò il disastro più grave con il cedimento in tre punti diversi, tra le località di Occhiobello e Paviole (Rovigo), della riva sinistra per un fronte complessivo di 756 metri. La rotta determinò l’inondazione di circa 100 mila ettari del Polesine, con un’altezza media del fluido di 2,5 metri. Il Rodigino, situato in depressione naturale, tornò nel giro di pochi minuti ad assumere l’aspetto di una palude stagnante. I centri più colpiti furono 27 in particolare Adria, Cavarzere, Loreo e Porto Viro. Le conseguenze furono enormi. Persero la vita 108 persone, si contarono 180.000 sfollati, il comparto agricolo e zootecnico fu annichilito, oltre 800 abitazioni vennero distrutte e più di 3.000 subirono danni. Contemporaneamente, nel resto del bacino padano, si ebbero numerosi eventi alluvionali minori. Si contarono complessivamente 121 rotte lungo i corsi d’acqua, 135 cedimenti nei canali di bonifica, la distruzione di 52 ponti e ingenti danni alle infrastrutture stradali e ferroviarie dell’intera pianura [Della Valle 1953, 139-140].
Tra i numerosi articoli del «Corriere della Sera» che trattavano i fatti di quel novembre, un editorialista riteneva necessario Imbrigliare le acque dalla sorgente alla foce. Il fatto era che le recenti bonifiche, pur assicurando un’enorme quantità di suolo coltivabile, non avevano garantito la sicurezza idraulica di territori storicamente alluvionali. Occorreva dunque affrontare alla radice la regolamentazione dei corsi d’acqua. A questo proposito si rendeva necessario attuare un piano generale di rimboschimento che disciplinasse, anche attraverso l’edificazione di opere idraulico-forestali, «i bacini dei singoli corsi d’acqua con una cura totale dalla sorgente alla foce» [30]. Alcuni giorni più tardi, un articolo di Libero Lenti titolava: Rimboscare. Da questi ed altri editoriali traspariva un tema centrale del dibattito pubblico. All’alba della legge Fanfani sui provvedimenti in favore della montagna (1952, n. 991), i rimboschimenti apparivano come la migliore soluzione al problema del dissesto idrogeologico. Scriveva Lenti: «varie e concomitanti sono le cause che spiegano le disastrose inondazioni di questi giorni. Ma una è alla radice di ogni male: il disboscamento delle nostre montagne e in parte delle nostre colline». Egli criticava aspramente la secolare politica agraria del Paese, fondata su un tessuto di micro-aziende contadine in grado a malapena di garantire la sopravvivenza familiare. Tali imprese, occupando vaste porzioni di suolo un tempo boscate, originavano un’irrazionale e inefficiente distribuzione terriera. Si auspicava quindi un grande investimento capitalistico, capace di liberare le aree montane dall’eccessiva frammentazione fondiaria per fare spazio a grandi interventi di rimboschimento [31]. Oggi sappiamo che di fronte ad eventi meteorologici estremi, il bosco, pur contribuendo a mitigare il rischio, non può offrire una protezione efficace senza il supporto di opere strategiche fondamentali quali casse d’espansione e canali scolmatori. Inoltre, i rimboschimenti realizzati negli anni Cinquanta furono concepiti come impianti provvisori, destinati a favorire l’insediamento di specie autoctone, più adatte a resistere agli agenti atmosferici e al passare del tempo. Tuttavia, per molte zone, questo processo di sostituzione arborea non si è verificato, generando numerose criticità in tema di stabilità idrogeologica [Scarascia-Mugnozza, Masci 2002, 131]. L’ultimo pezzo del «Corriere della Sera», anch’esso firmato dall’economista Lenti, era intitolato: Amministrare il Po. Secondo l’autore il problema della regolamentazione idraulica del Po, costituiva un dilemma insoluto almeno a partire dall’Unità d’Italia. Si trattava di dare una continuità amministrativa che invece «coloro che con la scheda elettorale sono gli arbitri del loro successo politico» non intendevano percorrere. Per Lenti era necessario dare vita ad un’autorità tecnico-amministrativa che, sovrintendendo sull’intero bacino idrografico, fosse in grado di decidere «quali sono le zone da allagare per salvarne altre più ricche e più fruttifere». Rivolgendosi alla Commissione d’inchiesta parlamentare sul disastro del 1951, l’economista non faceva altro che auspicare la nascita di un ente sovraregionale per la gestione unitaria del Po [32]. Un’idea, condivisa con il prof. Giulio De Marchi, che avrebbe trovato piena realizzazione molti decenni più tardi, con l’istituzione nel 1989 delle cosiddette Autorità di bacino (1989, n. 183).
Tra gli articoli pubblicati da «Il Resto del Carlino» – che nel frattempo aveva assunto temporaneamente il nome di «Giornale dell’Emilia» – merita attenzione un editoriale del 15 novembre firmato da Arturo Marescalchi, enologo ed ex sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura nel periodo fascista. A differenza di quanto sostenuto da Lenti nel «Corriere della Sera» che aveva parlato di un rapporto insostenibile tra pressione demografica e superficie coltivata [33], Marescalchi individuava nell’abbandono delle campagne l’origine di numerosi “mali” italiani. Riprendendo un tema proprio del ruralismo fascista, l’autore – durante i giorni più drammatici della piena – lanciava un accorato appello: «guai al giorno in cui le campagne mancassero di valide braccia». Parole che si levavano come un monito contro il rischio che lo spopolamento, specie in montagna, compromettesse l’equilibrio sociale e ambientale del Paese [34]. Indubbiamente, i reportage più intensi di quei giorni furono siglati da un giovane Enzo Biagi, inviato speciale per il «Giornale dell’Emilia» nel Polesine. Tra i numerosi editoriali si ricordano: Circondata dalle acque una popolazione attende [35], Con la gente della città assediata [36], Le fotoelettriche di Corbola illuminano l’approdo dei profughi [37]. Il 28 novembre, Biagi, annunciando la sua imminente partenza dal Polesine, scrisse il suo pezzo più significativo: Soltanto buoni italiani almeno per dieci Giorni. In quell’articolo il giornalista, con prosa asciutta e toccante, raccontava come superata la fase acuta dell’emergenza, il Polesine sarebbe stato inghiottito «dal dramma della miseria silenziosa che si trascina sui tavoli dei ministeri o negli uffici delle prefetture». L’alluvione, scriveva, non era più puro spettacolo ma semplicemente un problema. Per dieci giorni l’Italia era stata buona, concludeva malinconicamente, ma per ridare vita ad una terra sconvolta, non sarebbero certo bastati [38].
5. I fatti del 1994 e 2000
Le ultime due grandi piene del Po del XX secolo si sono verificate a breve distanza l’una dall’altra, nel novembre 1994 e nell’ottobre del 2000, a quasi cinquant’anni dal disastroso evento del 1951. Già nel 1926 un articolo del «Corriere della Sera» osservava che la piena del Po «sembra rinnovarsi a periodi decennali» [39]. In effetti, non si trattava di un’affermazione troppo distante dalla realtà se è vero che nel corso del Novecento il tempo di ritorno degli eventi più significativi si attesta attorno a 16 anni e mezzo. Insomma, sebbene episodi estremi come quello del Polesine presentino un tempo di ritorno stimato anche di due secoli, i dati dimostrano che il rischio alluvionale lungo il bacino idrografico del Po resta molto elevato. L’alluvione del 1994 colpì in modo particolare il settore nordoccidentale del bacino padano, a cominciare dal Piemonte. In alcune aree, le precipitazioni raggiunsero i 200 millimetri in 24 ore, saturando il terreno e provocando frane e smottamenti. Oltre al Po strariparono il Tanaro e diversi affluenti, allagando vaste zone delle province di Cuneo, Asti, Alessandria, Vercelli e Torino e mettendo in crisi l’intero sistema golenale del grande fiume. Le vittime furono 69, oltre 500 feriti e circa 5.500 sfollati. Lunedì 7 novembre alle ore 10 il Po segnava un’altezza di 9,88 metri sopra il livello del mare a Piacenza, inferiore soltanto al dato registrato nel 1951 di 10,25 metri [40]. Il 7 novembre, sul «Corriere della Sera», Cesare De Seta apriva con un editoriale dal titolo eloquente: La terra dimenticata. L’architetto si chiedeva come fosse possibile che regioni come Piemonte, Lombardia e Toscana – che fin dall’Unità d’Italia avevano rappresentato l’avanguardia della scuola idraulica italiana – si fossero ritrovate in condizioni simili, se non peggiori, rispetto ai territori del Mezzogiorno. «Sono le regioni più ricche del Paese a franare e a smottare», scriveva De Seta. «Sono i fiumi che attraversano le contrade del rigoglioso sviluppo capitalistico a correre impazziti, senza alvei capaci di contenerli, né argini in grado di reggere». Citando autori come Carlo Cattaneo e Manlio Rossi-Doria, egli puntava il dito contro un processo di territorializzazione troppo rapido e incontrollato. In particolare, denunciava la cementificazione selvaggia che durante gli anni del Boom economico aveva sottratto all’agricoltura nazionale un’area grande quanto il Veneto. Secondo De Seta, il bacino del Po si trovava in condizioni peggiori, cioè più insicure, di quanto non fosse nel 1951. Egli, concludendo il suo editoriale, attaccava duramente sia la politica – colpevole di non aver fatto nulla, in decenni di storia, per invertire la rotta – sia le imprese, responsabili di aver cementificato il Paese con la forza cieca di un bulldozer [41]. Il giorno dopo Enzo Biagi, memore delle esperienze in Polesine, scriveva: I dolori di sempre. Rifacendosi al romanzo Il mulino del Po di Riccardo Bacchelli, il giornalista emiliano ricordava che la miseria, da sempre, giungeva in barca. Dopo l’arrivo della macchina dei soccorsi, infatti, il dramma iniziava a protrarsi nel tempo. Così, ancora una volta, senza una risposta efficace delle istituzioni, si abbatteva sulla gente il dramma della ricchezza perduta, dalla casa al lavoro, dalle infrastrutture alle nuove tasse [42]. Il 9 novembre anche l’economista Mario Talamona, descrivendo i Conti dell’incuria, affermava che malgrado si conoscessero fin dal 1967 i risultati della commissione De Marchi per la mitigazione del rischio idraulico, poco si era fatto per la protezione ambientale: «non lo si è fatto, non l’hanno fatto, non l’abbiamo fatto», ammetteva Talamona [43]. Un taglio diverso, invece, assumeva il brano di Giuliano Zincone. Egli, attaccando le politiche “verdi”, considerava le inondazioni un problema tipico delle società sottosviluppate, non certo di quelle avanzate. Il giornalista, che ammetteva la necessità di accrescere le sistemazioni collinari e montane, sosteneva che «la tragedia nasce dall’assenza dell’uomo, non dalla sua presenza arrogante» [44].
In occasione dell’alluvione che colpì il Piemonte nel novembre del 1994, «Il Resto del Carlino» mise in evidenza il ritardo nei soccorsi e la mancanza di coordinamento tra le istituzioni politiche e la macchina dei soccorsi, a cominciare dalla Protezione civile [45]. In un articolo firmato da Alessandro Poggi – il professor Franco Prodi – attaccava il servizio meteorologico nazionale, ancora monopolizzato dall’Aeronautica militare e privo di un adeguato sistema satellitare di supporto [46]. Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, «Il Resto del Carlino» segnalava che l’evento del 1994 si presentasse, per portata e impatto, persino peggiore di quello del 1951. Nonostante ciò, il capo della Protezione civile, assicurava la preparazione e la capacità di risposta del sistema regionale [47]. Alcuni giorni più tardi, il giornalista Beppe Errani evidenziava la presenza immancabile di sciacalli pronti a trarre vantaggio dalle disgrazie altrui. Egli, non faceva tanto riferimento ai ladri che si introducevano nelle case vuote e alluvionate, quanto ai commercianti e agli imprenditori che imponevano prezzi esorbitanti sui beni di prima necessità [48]. In un articolo del 9 novembre, Luca Borghi sottolineava il pericolo costante rappresentato dai fiumi della provincia di Bologna, in particolare dal Reno [49]. Da questo punto di vista, il Wwf Emilia-Romagna suggeriva di intervenire con decisione, ampliando gli argini per garantire maggiore sicurezza [50]. Nell’ultimo articolo firmato da Alessandro Farruggia, il segretario generale dell’Autorità di bacino, professor Roberto Passino, respingeva le accuse di essersi opposto a vari interventi in alveo finalizzati alla mitigazione del dissesto. Al contrario, Passino sosteneva che l’ente avesse più volte sollecitato il Governo a stanziare 3.380 miliardi di lire per la messa in sicurezza dell’alveo del Po. Con quei fondi, che non giunsero mai nelle case dell’Autorità, si sarebbero potute adeguare le arginature del Po e completare le opere di difesa per diversi centri urbani. Il suo commento amaro si chiudeva con parole dure: «l’appello è rimasto inascoltato, e oggi ci ritroviamo a contare i morti e a stilare un bilancio di distruzioni che supererà, e di molto, quei 3.380 miliardi che non si sono voluti trovare» [51].
L’ultimo evento alluvionale a cavallo tra XX e XXI secolo si verificò tra il 13 e il 16 ottobre del 2000. Complessivamente, si registrarono 23 vittime tra Valle d’Aosta e Piemonte. La piena del Po, che pure aveva superato il record storico del 1951, attestandosi a Piacenza a 10,5 metri, fu contenuta attraverso una serie di tracimazioni controllate. I tecnici intendevano rallentare la velocità con cui le acque, pericolosamente, si abbattevano sugli argini maestri, provocando una pressione insostenibile. Dalla Lombardia alla Romagna le ruspe lavorarono alacremente per aprire piccoli varchi che allagassero enormi fasce golenali [52]. Nonostante i danni economici, la strategia del Magistrato delle acque si rivelò vincente consentendo alla più grande piena del Po di defluire senza troppi intoppi. Sul «Corriere della Sera», Guido Vergani, nel suo editoriale attaccava «la favoletta della calamità naturale». A suo giudizio, avvenimenti di tale portata – che si ripetevano con inquietante regolarità ogni autunno – erano frutto della cementificazione selvaggia e della sistematica alterazione degli alvei fluviali, sconvolti dall’eliminazione di anse, golene e spazi di esondazione naturale. Ripercorrendo brevemente le normative, Vergani ricordava che i provvedimenti che vietavano la costruzione di abitati entro i 150 metri dagli argini fossero stati sistematicamente disattesi. Complice una lunga tolleranza istituzionale, anche l’abusivismo aveva peggiorato la situazione. Vergani concludeva con un appello: era tempo che il Piano di assetto idrogeologico (Pai) del Po, approvato nel 1999, entrasse in vigore mediante un cospicuo giro di vite sui piani regolatori comunali [53]. Il 18 ottobre, il «Corriere della Sera», annunciava il taglio programmato degli argini in diverse località per alleggerire la portata di una piena che, specie nel Cremonese, nel Mantovano e nel Parmense aveva assunto proporzioni simili a quelle del 1951 [54]. A tal proposito, Gian Antonio Stella descriveva l’atteggiamento bellicoso riscontrabile lungo il bacino del Po, esito di una sorta di Federalismo fluviale. In epoca moderna, il Magistrato del Po esercitava un potere centralizzato e autorevole, prendendo decisioni cruciali sugli argini da potenziare o in caso di pericolo da tagliare. In età contemporanea, specie con la costituzione delle Autorità di bacino, Stella rilevava la progressiva frammentazione e i conflitti di attribuzione tra enti locali. Del resto, era difficile immaginare che l’Autorità di bacino potesse imporre l’allagamento di un territorio emiliano piuttosto che veneto, senza scontrarsi con la ferma opposizione delle amministrazioni locali e delle medesime comunità [55]. L’ultimo intervento che si è deciso di esaminare, firmato da Indro Montanelli, decano dei giornalisti italiani, criticava la stampa e la televisione. Nonostante il crollo di alcuni argini del Po, egli sosteneva che l’alluvione non si fosse trasformata in disastro, come accaduto nel 1951, grazie a tre fattori determinanti. In primo luogo, le autorità avevano preso decisioni sagge riguardo al taglio degli argini, alleviando la portata della piena. Secondariamente, le spallette erano state rinforzate negli anni precedenti, garantendo un’effettiva tenuta del sistema padano. Infine, i soccorsi, a detta della medesima popolazione alluvionata, si erano comportati egregiamente, portando in salvo a tempo di record le persone in difficoltà. Secondo Montanelli, dunque, il Po era stato Salvato dagli argini e dalle sceneggiate [56].
Sul «Resto del Carlino», il 14 ottobre, Francesca Ronchin analizzava uno dei problemi cronici dell’Emilia-Romagna: le frane. Di fronte a intense precipitazioni, gli Appennini – costituiti prevalentemente da rocce argillose – “scivolano” pericolosamente a valle. Nel 2000 la regione, tra le più esposte al rischio idrogeologico, contava ben 32.000 frane. La situazione era particolarmente critica attorno al fiume Reno. Un territorio caratterizzato da una marcata instabilità geologica, dovuta a suoli argillosi e pendenze accentuate, che favorivano gli smottamenti [57]. Alcuni giorni più tardi, Franco Barberi, allora capo della Protezione civile, criticava severamente gli enti locali, a cominciare dai piccoli comuni. I problemi maggiori, infatti, si erano verificati laddove, per mancanza di risorse o più spesso per insofferenza, i comuni si erano opposti ad opere fondamentali di difesa. Riemergeva nuovamente la questione dei conflitti di competenze tra poteri centrali e autorità locali [58]. Il 18 ottobre, un brano segnalava come, nei successivi dieci anni, sulle Alpi si sarebbe verificato un incremento del 10% delle precipitazioni. Il dato, se confermato, avrebbe determinato una crisi ulteriore dell’intero sistema idrografico padano. Per la prima volta, in modo esplicito, si faceva riferimento al tema del cambiamento climatico, sottolineando l’urgenza di aggiornare il Pai del grande fiume [59]. Il giorno seguente, Giancarlo Mazzucca ricordava i due problemi cruciali che il Paese aveva dovuto affrontare almeno dal dopoguerra: la disoccupazione e il dissesto idrogeologico. Quest’ultimo, in particolare, era un problema ben noto, per il quale da tempo erano state individuate soluzioni concrete. Eppure, scriveva Mazzucca, nessuno aveva mai mostrato la volontà politica di intervenire con decisione. Egli faceva riferimento ad una sorta di «lassismo suicida», che finiva per indurre molti a mantenere lo status quo, piuttosto che affrontare il problema alla radice [60]. Con l’editoriale Caccia agli sciacalli del fiume, «Il Resto del Carlino» tornava a denunciare una pratica ricorrente: l’apertura deliberata di fontanazzi per indirizzare le acque lontano dalle abitazioni. Un comportamento che si manifestava con inquietante regolarità quasi ad ogni piena, tratteggiando quasi una sorta di rituale difensivo di alcune comunità a scapito di altre [61]. Infine, un ultimo brano riportava la denuncia dell’allora ministro dei Lavori Pubblici, Nerio Nesi, sul fenomeno dell’abusivismo edilizio lungo le rive del Po. Secondo Nesi, era giunto il momento di porre un freno a quello che appariva ormai come un grande problema nazionale [62].
6. Considerazioni finali
Dopo aver brevemente illustrato nel primo paragrafo le ragioni storiche dell’instabilità idrogeologica del bacino padano, nella seconda parte del saggio, attingendo ad un corpus di fonti giornalistiche provenienti dal «Corriere della Sera» e da «Il Resto del Carlino», ci si è concentrati sulla storia delle alluvioni del Po nel corso del XX secolo. La scelta di analizzare in chiave comparativa editoriali provenienti da una testata giornalistica nazionale e da un quotidiano radicato nel contesto locale ha consentito di coniugare uno sguardo più ampio, necessario per analizzare il peso politico e mediatico degli eventi, con una prospettiva locale, più sensibile alle dinamiche territoriali e agli effetti concreti sulle comunità. L’uso incrociato di queste fonti ha permesso così di ricostruire sia il processo di elaborazione di un discorso pubblico a scala nazionale, sia le modalità con cui tali eventi furono percepiti e vissuti a livello periferico. Come prevedibile, gli articoli più vecchi, spesso anonimi, sono generalmente orientati a fornire una cronaca asciutta degli eventi, anche se, talvolta, non mancano riflessioni più profonde. Con il passare del tempo, il tono degli editoriali muta sensibilmente, divenendo più consapevole, articolato e spesso carico di implicazioni politiche volte a individuare cause e responsabilità del fenomeno. Scorrendo le testimonianze offerte dalla stampa dal 1907 al 2000, emergono una serie di tematiche che – come una sorta di filo conduttore – attraversano epoche e sensibilità diverse.
La prima questione riguarda le responsabilità umane. Sin dal 1907, infatti, s’ipotizzava che la mano dell’uomo potesse aver inciso negativamente sul delicato equilibrio del bacino padano. Tuttavia, se fino al 1951, a suscitare le critiche della stampa erano i disboscamenti e i dissodamenti inconsulti, nel 1994 e nel 2000, l’attenzione si spostava sulla cementificazione e l’abusivismo. Invece di rispettare il fiume, l’uomo lo aveva progressivamente alterato abbattendo boschi, edificando nelle aree golenali e modificandone il corso. Si può dunque sostenere che lo sfruttamento del territorio costituisca un elemento persistente nell’analisi giornalistica lungo tutto il XX secolo. Eppure non mancavano opinioni contrarie. Giuliano Zincone, ad esempio, rifiutando il principio che la colpa ricadesse sull’uomo, sosteneva che le alluvioni più turbolente si manifestassero proprio in mancanza del presidio antropico. Non era il cemento sotto accusa, bensì l’abbandono delle campagne, la scarsa manutenzione di canali, fossi e versanti collinari, l’assenza di briglie, dighe e casse d’espansione. Riassumendo, lo Stato civile non era quello che attendeva passivamente la piena, ma quello che metteva in campo tutti i mezzi della modernità per arginarla.
Accanto a queste letture, gli editoriali denunciavano con frequenza crescente il tema dei conflitti di attribuzione tra Stato, magistratura delle acque (Genio civile o Autorità di bacino) e autorità locali. Per ogni alluvione si potrebbero rintracciare le critiche che il potere centrale – dai ministeri alla Protezione civile – rivolgeva al magistrato delle acque e, soprattutto ai comuni. Questi ultimi, considerati riottosi e negligenti venivano accusati di frapporsi alla realizzazione di opere fondamentali di contenimento. Dall’altra parte, le amministrazioni rispondevano lamentando l’assenza di fondi o denunciando la totale incompetenza governativa. Ne emerge un lungo quadro di disorganizzazione strutturale, dove l’ostacolo maggiore era costituito dalla mancanza di coordinamento tra istituzioni centrali e realtà periferiche. Da questo punto di vista, un’inversione di tendenza potrebbe essere rappresentata dai cosiddetti Contratti di fiume (Cdf). Uno strumento giuridico, sorto in Francia fin dai primi anni Ottanta, che ha avuto un considerevole sviluppo in Italia a partire dal 2000, a seguito della ricezione della Direttiva quadro sulle acque (2000/60/Ce) e della Direttiva alluvioni (2007/60/Ce). I Cdf costituiscono «strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata» che, attraverso la convergenza tra istituzioni pubbliche e comunità locali, compongono un corpus di regole per migliorare la qualità complessiva dei bacini idrografici: dalla mitigazione del rischio idraulico, al ripristino degli ecosistemi fluviali; dal miglioramento della qualità delle acque, alla valorizzazione dei paesaggi fluviali e delle risorse culturali a livello territoriale. Attualmente, sebbene lungo il distretto del Po siano stati complessivamente attivati circa 50 tra Contratti di fiume e Contratti di lago – segnale di un crescente interesse verso la governance delle risorse idriche – restano numerose criticità riguardanti soprattutto il passaggio dalla fase concertativa a quella operativa. I Cdf, infatti, non avendo natura giuridica cogente ma fondandosi su un sistema di adesione volontaria, generano impegni di carattere politico e morale che finiscono, spesso, per restare largamente disattesi [63].
Non meno rilevante appare leggendo i giornali, il complesso rapporto tra le popolazioni locali e il grande fiume. Se da una parte, infatti, la bonifica padana aveva aperto enormi possibilità di sviluppo economico, dall’altra le popolazioni del Po, memori della lunga storia alluvionale, temevano la forza e l’impeto di nuove piene. Dal 1907 al 2000 le cronache non mancavano di denunciare episodi di sabotaggio, come l’apertura di fontanazzi o il taglio degli argini, per deviare l’acqua lontano dalle proprie case. Tali gesti mettono in evidenza due aspetti fondamentali. Da un lato emerge la fragilità di comunità che si sentivano abbandonate a sé stesse, prive del sostegno di istituzioni credibili in grado di guidarle nei momenti critici e accettare, quando necessario, decisioni impopolari. Dall’altro lato, si manifesta un atteggiamento di chiusura a difesa del proprio territorio, spesso a discapito delle comunità vicine situate sull’argine opposto. Accanto alla solidarietà unanime che il Paese rivolgeva ai territori alluvionati, è necessario dunque segnalare l’articolata e spesso ostile convivenza dimostrata dalle comunità confinanti.
Un ultimo elemento che attraversa l’intera narrazione è quello delle spese per la mitigazione del rischio. La stampa denunciava con insistenza l’incapacità e talvolta la dubbia volontà delle istituzioni di affrontare il problema alla radice. Le soluzioni adottate, spesso con fatica e lentezza, si rivelavano frammentarie e inefficaci. Si trattava di interventi tampone, realizzati in fretta che nel lungo periodo si dimostravano dispendiosi e spesso inutili. Già nel 1907, Tito Poggi segnalava la necessità di un piano per il Po che placasse il rischio alluvionale. Di volta in volta i quotidiani evidenziavano come le spese per le ricostruzioni superassero regolarmente quelle necessarie per la mitigazione del dissesto. Emerge con chiarezza, dunque, il tema della memoria pubblica del disastro. Mentre tra gli alluvionati la paura e il senso di precarietà continuano a vivere a lungo, coloro che si dovrebbero occupare delle soluzioni tendono per qualche ragione a rimuovere rapidamente le cause profonde. Tra i vari autori Enzo Biagi descrisse con lucidità il dramma delle popolazioni inondate. Una volta ritirate le acque, e spente telecamere, le famiglie rimaste senza casa si trovano ad affrontare, in solitudine, un futuro incerto. Il tempo del fango, della ricostruzione e del silenzio era anche più lungo e doloroso, se possibile, dell’alluvione stessa.
Bibliografia
- Bacchi, Orlandini, Pellegrini 2007
Baldassarre Bacchi, Stefano Orlandini, Maurizio Pellegrini, Le alluvioni del Po nel secolo XIX: alla ricerca delle cause, in Un Po di Carte: La Dinamica Fluviale del Po nell’Ottocento e le Tavole della Commissione Brioschi, a cura di Ireneo Ferrari, Maurizio Pellegrini, Reggio Emilia, Diabasis, 2007, pp. 145-165. - Bertoldi 1807
Francesco Leopoldo Bertoldi, Memorie per la storia del Reno di Bologna, Ferrara, Stamperia del Seminario, 1807. - Bevilacqua, Rossi Doria 1984
Le bonifiche in Italia dal ʼ700 a oggi, a cura di Piero Bevilacqua, Manlio Rossi Doria, Roma-Bari, Laterza, 1984. - Brighenti 1860
Maurizio Brighenti Sull’effetto del disboscamento e dissodamento dei monti rispetto all’altezza delle piene maggiori dei fiumi arginati, in «Memorie dell’accademia delle scienze dell’istituto di Bologna», Bologna, Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1860, vol. X, pp. 197-211. - Cazzola 2021
Franco Cazzola, Uomini e Fiumi. Per una Storia idraulica ed agraria della bassa pianura del Po (1450-1620), Roma, Viella, 2021. - Cibotto 2021
Gian Antonio Cibotto, Cronache dell’alluvione. Polesine 1951, Milano, La Nave di Teseo, 2021. - Cirmatori 2007
Luigi Cirmatori, Introduzione: le grandi piene del 1872 e la Commissione Brioschi, in Un Po di Carte: La Dinamica Fluviale del Po nell’Ottocento e le Tavole della Commissione Brioschi, a cura di Ireneo Ferrari, Maurizio Pellegrini, Reggio Emilia, Diabasis, 2007, pp. 15-23. - Della Valle 1953
Carlo Della Valle. Le alluvioni del 1951 in Italia e le loro cause, in «Bollettino della Società geografica italiana», 2 (1953), pp. 135-141. - Gambi 1949
Lucio Gambi, L’insediamento umano nella regione della bonifica romagnola, a cura di Francesco Micelli, Lucio Gambi Bologna, Forni, 2011. - Gambi 1950
Lucio Gabi, Cosa era la Padusa, Faenza, Fratelli Lega, 1950. - Guidoboni 1998
Emanuela Guidoboni, Human Factors, Extreme Events and Floods in the Lower Po Plain (Northern Italy) in the 16th Century, in «Environment and History», 3 (1998), pp. 279-308. - Manfredi 1758
Eustachio Manfredi, Risposta del dottore Eustachio Manfredi alle ragioni de’ Signori Ceva e Moscatelli, in Raccolta d’autori che trattano del moto dell’acque, Firenze, Stamperia di sua Altezza Reale, vol. V, 1758, pp. 251-413. - Ispra 2021
Ispra, Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio, rapporto 356/2021, https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/dissesto-idrogeologico-in-italia-pericolosita-e-indicatori-di-rischio-edizione-2021. - Istituto Veneto di Scienze, Lettere ad Arti, Accademia dei Concordi di Rovigo 1994
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ad Arti, Accademia dei Concordi di Rovigo, Il Fiume e la sua terra. Tutela e gestione del territorio a quarant’anni dall’alluvione del Polesine 1951-1991, Venezia 1994. - Lecchi, Temanza, Verace 1767
Antonio Lecchi, Tommaso Temanza, Giovanni Verace, Relazione della visita alle terre danneggiate dalle acque di Bologna, Ferrara, e Ravenna per deputazione di nostro signore Clemente XIII felicemente regnante, Bologna, Stamperia Camerale, 1767. - Lombardini 1852
Elia Lombardini, Dei Cangiamenti cui soggiacque l’idraulica condizione del Po nel territorio di Ferrara e della necessità di rettificare alcuni fatti annunciati da Cuvier su tale argomento, Milano, Tipografia Bernardoni, 1852. - Maganzini 1887
Italo Maganzini, Sulla bonificazione di Burana; cenni dell’ingegnere del Genio civile I. Maganzini, in «Giornale del Genio Civile», V (1887), pp. 503-545. - Menzani 2008
Tito Menzani, Le bonifiche in Romagna. La realizzazione del Canale in destra di Reno (secc. XVIII-XX), Imola, La Mandragora, 2008. - Parrinello 2017
Giacomo Parrinello, Charting the Flow: Water Science and State Hydrography in the Po Watershed, 1872–1917, in «Environment and History», 23 (2017), pp. 1-28. - Piastra 2024
Stefano Piastra, Crisi idrogeologiche storiche in Romagna. Studiare il passato per gestire gli eventi futuri, in Paesaggio e crisi ambientale, a cura di Gabriella Bonini, Rossano Pazzagli, Reggio Emilia, Istituto Alcide Cervi, 2024, pp. 65-74. - Scarascia-Mugnozza, Masci 2002
Giuseppe Scarascia-Mugnozza, Albero Masci, Selvicoltura, in Accademia dei Georgofili. Storia dell’agricoltura italiana. L’età contemporanea. Sviluppo recente e prospettive, a cura di Franco Scaramuzzi, Paolo Nanni, Firenze, Polistampa, 2002, vol. III (2), pp. 105-154. - Sereni 1961
Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Roma-Bari, Laterza, 1961. - Sorcinelli, Tchaprassian 2014
Paolo Sorcinelli, Mirhan Tchaprassian L’alluvione (l’Italia e il polesine nel 1951), Pesaro, Metauro, 2014. - Veronesi 1858
Giovanni Veronesi, Cenni storici sulle vicende idrauliche della bassa pianura bolognese, Bologna, Tipografa dell’Ancora, 1858.
Note
1. La impressionate piena del Po. Piacenza bassa allagata, in «Corriere della Sera», 28 ottobre 1907. Tutti gli articoli di giornale sono stato consultati presso la Biblioteca comune dell’Archiginnasio di Bologna.
2. Piacenza allagata, in «Corriere della Sera», 29 ottobre 1907.
3. Piacenza sott’acqua. I soccorsi, in «Corriere della Sera», 30 ottobre 1907.
4. Le vittime di Mortizza, in «Corriere della Sera», 3 novembre 1907.
5. Arresti per tentate rotte dolose in aiuto ai dispersi, in «Corriere della Sera», 31 ottobr1 1907.
6. Nuovi allagamenti e nuove minacce sotto l’imperversare delle piogge. Confusione di poteri e lotta di rivieraschi, in «Corriere della Sera», 31 ottobre 1907,
7. Desolante situazione nei paesi inondati, in «Corriere della Sera», 1° novembre 1907.
8. Dopo le inondazioni del veneto, in «Corriere della Sera», 11 novembre 1907.
9. La piena del Po a Piacenza ha rotto gli argini, in «Il Resto del Carlino», 28-29 ottobre 1907.
10. La rotta del Po a Piacenza, in «Il Resto del Carlino», 29-30 ottobre 1907.
11. La dolorosa rovina dei paesi inondati, in «Il Resto del Carlino», 30-31 ottobre 1907.
12. Altri disastri nella nostra regione, in «Il Resto del Carlino», 30-31 ottobre 1907.
13. Gli orrori e le sciagure dell’inondazione, in «Il Resto del Carlino», 31 ottobre-1° novembre 1907.
14. Altri disastri nella nostra regione, in «Il Resto del Carlino», 30-31 ottobre 1907.
15. Il Reno in piena, in «Il Resto del Carlino», 30-31 ottobre 1907.
16. Terrore e rovina lungo le sponde del Po, in «Il Resto del Carlino», 1-2 novembre 1907.
17. Disastri e vittime del maltempo, in «Corriere della Sera», 1° giugno 1917.
18. La piena del Ticino e del Po, in «Corriere della Sera», 2 giugno 1917.
19. La piena Po, in «Corriere della Sera», 4 giugno 1917.
20. La furia delle intemperie scatenata nelle regioni dell’alta Italia, in «Corriere della Sera», 18 maggio 1926.
21. I fiumi straripati rientrano negli argini, in «Corriere della Sera», 19 maggio 1926.
22. La piena del Po in diminuzione, in «Corriere della Sera», 21 maggio 1926.
23. L’eco dei disastri delle intemperie alla Camera, in «Corriere della Sera», 22 maggio 1926.
24. Disastrose inondazioni in Piemonte e nel Veneto, in «Il Resto del Carlino», 17 maggio 1926.
25. Le ansiose giornate di Piacenza sotto la minaccia del Po, in «Il Resto del Carlino», 19 maggio 1926.
26. Una notte di terrore e di angoscia a Caorso, in «Il Resto del Carlino», 20 maggio 1926.
27. Il maltempo in Italia, in «Il Resto del Carlino», 21 maggio 1926.
28. Ibidem.
29. Il problema delle foreste, in «Il Resto del Carlino», 22 maggio 1926.
30. Imbrigliare le acque dalla sorgente alla foce, in «Corriere della Sera», 18 novembre 1951.
31. Rimboscare, in «Corriere della Sera», 22 novembre 1951.
32. Amministrare il Po, in «Corriere della Sera», 30 novembre 1951.
33. Rimboscare, in «Corriere della Sera», 22 novembre 1951.
34. L’abbandono delle Campagne, in «Giornale dell’Emilia», 15 novembre 1951.
35. Circondata dalle acque una popolazione attende, in «Giornale dell’Emilia», 19 novembre 1951.
36. Con la gente della città assediata, in «Giornale dell’Emilia», 20 novembre 1951.
37. Le fotoelettriche di Corbola illuminano l’approdo dei profughi, in «Giornale dell’Emilia», 24 novembre 1951.
38. Soltanto buoni italiani almeno per dieci giorni, in «Giornale dell’Emilia», 28 novembre 1951.
39. I fiumi straripati rientrano negli argini, in «Corriere della Sera», 19 maggio 1926.
40. Po adesso l’incubo si chiama scirocco, in «Corriere della Sera», 10 ottobre 1994.
41. La terra dimenticata, in «Corriere della Sera», 7 novembre 1994.
42. I dolori di sempre, in «Corriere della Sera», 8 novembre 1994.
43. I conti dell’incuria, in «Corriere della Sera», 9 novembre 1994.
44. I reazionari dell’acqua, in «Corriere della Sera», 12 novembre 1994.
45. Ma i soccorsi sono arrivati tardi, in «Il Resto del Carlino», 7 novembre 1994; Non li hanno avvertititi in tempo, in «Il Resto del Carlino», 8 novembre 1994; “Il disastro era stato previsto”, in «Il Resto del Carlino», 9 novembre 1994.
46. «Servizi meteo? È tutto da rifare», in «Il Resto del Carlino», 8 novembre 1994.
47. Emilia, peggio che nel ʼ51, in «Il Resto del Carlino», 8 novembre 1994.
48. Sono i giorni degli sciacalli, in «Il Resto del Carlino», 9 novembre 1994.
49. Bombe a tempo sulle rive, in «Il Resto del Carlino», 9 novembre 1994.
50. Contro le piene? Argini più larghi, in «Il Resto del Carlino», 9 novembre 1994.
51. Ci negavano i soldi per il Po, in «Il Resto del Carlino», 10 novembre 1994.
52. Il Po sconfitto dall’apertura degli argini, in «Corriere della Sera», 19 ottobre 2000.
53. Ogni autunno, in «Corriere della Sera», 16 ottobre 2000.
54. Argini aperti per frenare la furia del Po, in «Corriere della Sera», 18 ottobre 2000.
55. Federalismo Fluviale, in «Corriere della Sera», 19 ottobre 2000.
56. Salvati dagli argini e dalle sceneggiate, in «Corriere della Sera», 21 ottobre 2000.
57. “Una cura per la terra che frana”, in «Il Resto del Carlino», 14 ottobre 2000.
58. Barbieri accusa: «è colpa degli enti locali», in «Il Resto del Carlino», 17 ottobre 2000.
59. E sulle Alpi pioverà sempre di più, in «Il Resto del Carlino», 18 ottobre 2000.
60. Il lassismo statale quasi un suicidio, in «Il Resto del Carlino», 19 ottobre 2000.
61. Caccia agli sciacalli del fiume, in «Il Resto del Carlino», 19 ottobre 2000.
62. Nesi: «Guerra all’abusivismo sul Po», in «Il Resto del Carlino», 23 ottobre 2000.
63. Per approfondire il tema dei Cdf lungo il bacino del Po: https://www.adbpo.it/contratti-di-fiume/.
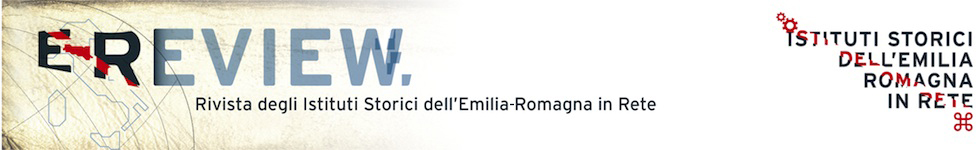
![Fig. 1. Le valli di Comacchio in un disegno di Pietro Azzoni trascritto fedelmente da Pio Battista Benetti nel 1737 [Archivio di Stato di Ravenna, Corporazioni religiose, b. 1237, allegati cartografici].](./sites/default/images/articles/media/327/gestri_acque_01.JPG)
![Fig. 2. Cavo benedettino a Po di Primaro in uno schizzo settecentesco [Archivio di Stato di Ravenna, Corporazioni religiose, b. 682, allegati cartografici].](./sites/default/images/articles/media/327/gestri_acque_02.JPG)
![Fig. 3. Mappa della bonificazione della gregoriana attribuibile ad Antonio Farini del 1769. Si può osservare come Ravenna fosse circondata dalle acque [Archivio di Stato di Ravenna, Corporazioni religiose, b. 677].](./sites/default/images/articles/media/327/gestri_acque_03.JPG)
![Fig. 4. Percentuali di area comunale allagabile per scenario di pericolosità da alluvione media [Ispra 2021, 55].](./sites/default/images/articles/media/327/gestri_acque_04.jpg)
![Fig. 5. “Corso del Po per la Lombardia dalle sue fonti sino al mare, descritto da Agostino Sargente Maggiore Cerruti Capitano di una Compagnia di fanti Oltramontani della Guardia di sua Santitá”, 1702 [Biblioteca Casanatense - Roma, IT-RM0313, Inventario: 07 35767, Segnatura: 20 B.I.3 47].](./sites/default/images/articles/media/327/gestri_acque_05.jpg)