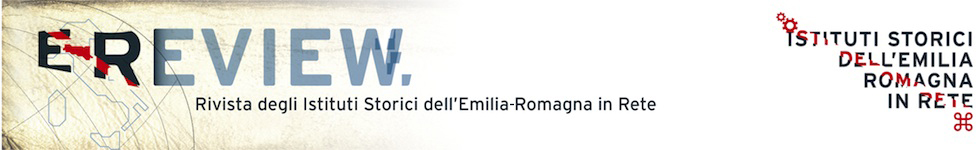Solo un giorno dopo l’annuncio dell’armistizio tra l’Italia e gli Alleati il campo di prigionia di Fontanellato, nella bassa parmense, divenne protagonista di un avvenimento peculiare, che ha assunto ed ancora oggi conserva un significato profondo non solo per la popolazione del paese, ma anche per la storia nazionale. Il 9 settembre 1943, infatti, i cancelli del campo PG49 – adibito, a partire dalla primavera di quello stesso anno, alla reclusione di ufficiali, in gran parte britannici – furono aperti e tutti coloro che si trovavano al suo interno vennero liberati, senza spargimenti di sangue. I prigionieri riuscirono a fuggire nelle campagne circostanti, dove le famiglie della zona li accolsero e li aiutarono, proteggendoli dai tedeschi: quasi improvvisamente la popolazione locale si era resa conto che quegli inglesi non erano più “nemici”. Per la provincia di Parma quell’evento segnò simbolicamente l’inizio della lotta di liberazione.
[[figure caption="Immagine del campo PG49 ripreso dal retro" align="center"]]figure/2013/malice/malice_2013_01.jpg[[/figure]]
In occasione dell’anniversario della liberazione del campo PG49 e nell’ambito delle celebrazioni per il Settantesimo della Resistenza, il Comune di Fontanellato, insieme all’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Parma (Isrec), ha deciso di intrecciare alle occasioni di commemorazione e memoria e a quelle formative relative all’avvenimento in questione, anche un momento di riflessione storica sui temi della prigionia e dell’internamento militare nel periodo a cavallo dell’8 settembre 1943.
[[figure caption="Manifesto dell'iniziativa" align="left" width="300px"]]figure/2013/malice/malice_2013_04.jpg[[/figure]]All’interno di questa prospettiva è stato ideato il convegno “Prigionieri militari nella seconda guerra mondiale tra Italia e Inghilterra. Storia e memoria”, organizzato dall’Isrec, dalla Fondazione ex campo Fossoli e dall’Istituto Parri Emilia Romagna, con il patrocinio del Comune di Fontanellato, della Provincia di Parma e della Regione Emilia Romagna.
All’incontro, moderato dal professor Lorenzo Bertucelli della Fondazione ex campo Fossoli, sono intervenuti gli storici Marco Di Giovanni (Università di Torino), Isabella Insolvibile (Università di Napoli), Clare Makepeace (Birkbeck College - University of London) e Marco Minardi, direttore dell’Istituto storico di Parma. Tra il pubblico erano presenti oltre un’ottantina di parenti di ufficiali inglesi e due ex prigionieri del campo di Fontanellato.
1. Una guerra di soldati? L'Africa Settentrionale nel quadro della Seconda guerra mondiale
Ad aprire il ciclo di conferenze è stato Marco Di Giovanni, ricercatore alla facoltà di Scienze politiche di Torino e studioso di storia militare. La guerra africana si trova a monte dei percorsi messi a fuoco nel corso del convegno, poiché gran parte dei prigionieri britannici e del Commonwealth che furono reclusi in Italia furono catturati proprio su quel campo di battaglia. Di Giovanni ha presentato alcuni spunti di riflessione sulle particolarità di quella “piccola” guerra e sul suo significato per la memoria collettiva, soprattutto italiana.
Innanzitutto il conflitto in Africa, che tra il 1940 e il 1943 contrappose italiani e tedeschi da un lato e forze alleate dall'altro, si caratterizzò come teatro di guerra che assorbiva quasi completamente le linee operative principali delle potenze in campo, e dove il primo obiettivo era il successo strategico. In quel campo di battaglia lontano, isolato dal centro europeo degli eventi ed estraneo alle logiche dell'annientamento, ciò che contava era raggiungere la vittoria, sottomettendo l'avversario.
Si trattava inoltre di una guerra avvincente, in cui le grandi personalità ebbero un ruolo centrale nel corso della campagna e divennero simboliche dopo la sua conclusione, al di là degli schieramenti. Così nella memoria britannica, ad esempio, al mito del generale Bernard Law Montgomery si affiancò anche il ricordo della grandezza del feldmaresciallo Erwin Rommel, a capo dell’esercito tedesco. Rommel e Montgomery furono i rappresentanti delle due compagini militari maggiori; stretta tra le potenze alleate e i tedeschi c'era poi la piccola Italia, che si muoveva tra giganti nel piano strategico del potere mediterraneo. Il ruolo marginale dell’Italia nel contesto della guerra d’Africa spiega, in parte, il modo in cui si andò consolidando la memoria nazionale su quegli avvenimenti nel periodo postbellico: secondo Di Giovanni la campagna del Nordafrica fu ricordata come un «terreno onorevole di possibilità perdute», legato al ricordo della guerra fascista e della sconfitta e alla difficoltà per la nazione di inquadrare quel passato. Ne scaturì un dopoguerra dominato da memorie e narrative divise, che oggi – ha proseguito il ricercatore – è necessario riconsiderare.
Di Giovanni ha poi sollevato un'ulteriore riflessione legata al tema della memoria: per gli europei, e per noi italiani in particolare, il percorso cimiteriale dei soldati è ancora in gran parte ancorato all'elaborazione del lutto nazionale della Prima guerra mondiale, in seguito alla quale furono creati quasi ovunque e in gran numero appositi spazi pensati per raccogliere le spoglie dei combattenti “eroi della Patria” e per eternare la loro memoria. Quell’esperienza effettivamente non venne riproposta per coloro che avevano combattuto, nel corso della Seconda guerra mondiale, sul suolo europeo; mentre – ha ricordato il ricercatore – diversi spazi monumentali e memoriali furono creati in nome dei caduti nella guerra d’Africa, sebbene con caratteristiche diverse: sacrari per i combattenti italiani, torri in memoria di quelli tedeschi (come quella del Totenburg, del 1959) e cimiteri destinati ad accogliere le lapidi dei soldati inglesi.
2. I “fortunati”. I prigionieri italiani in Gran Bretagna, 1941-1946
Al centro dell’intervento di Isabella Insolvibile è stato invece il tema della prigionia, e in particolare la condizione dei prigionieri italiani in Gran Bretagna fino al 1946.
Dalle ricerche di Insolvibile – già sfociate nella pubblicazione Wops. I prigionieri italiani in Gran Bretagna (1941-1946), Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2012 – è emerso innanzitutto che quell’esperienza di cattività fu una delle migliori dal punto di vista materiale. I reclusi vennero sfamati, alloggiati, equipaggiati e curati in modo adeguato: in questo senso i prigionieri di guerra italiani furono “fortunati”. Questa loro “buona detenzione” era dipesa, oltre ad un sostanziale rispetto delle normative internazionali relative ai prigionieri di guerra, dalla necessità inglese di ottimizzare lo sfruttamento della loro manodopera, soprattutto nel campo dell’agricoltura. Insolvibile ha parlato per questo di “filantropia interessata”, di logica di utilizzazione.
Tuttavia la prigionia fu tanto buona dal punto di vista materiale, quanto devastante dal punto di vista psicologico, a causa della sua durata. Gli inglesi infatti trattennero i prigionieri-lavoratori italiani anche dopo l’8 settembre, fino alla conclusione dell’ennesimo raccolto nel 1945-46; ed anche i governi dell’Italia postfascista, a causa delle difficoltà dovute al reinserimento degli ex prigionieri e in ragione di quella che in fondo era una “buona detenzione”, non li reclamarono immediatamente. Se prima dell’armistizio la cattività era stata tutto sommato sopportabile, grazie alla convinzione che - presto o tardi - la guerra sarebbe finita, il periodo dopo il settembre 1943 fu per i reclusi il più lungo e doloroso.
L’8 settembre costituì uno spartiacque non solo dal punto di vista psicologico, ma anche per lo status giuridico degli italiani in cattività. Prima di quella data, infatti, lo status di prigionieri di guerra non fu mai messo in discussione: giacché gli italiani erano nemici a tutti gli effetti, anche la natura dei loro prigionieri era assodata e riconoscibile. Quella condizione giuridico-diplomatica, tuttavia, non venne modificata quando il Paese passò dalla parte degli alleati: gli italiani in Inghilterra sarebbero rimasti prigionieri di guerra anche in seguito alla proclamazione della “cobelligeranza” e (dal maggio 1944) della “cooperazione”: in sostanza fino al loro rimpatrio. La mancata modifica dello status è spiegabile in parte con le decisioni congiunte di Gran Bretagna e USA, per cui l’Italia avrebbe dovuto rimanere un paese pienamente sconfitto; in parte con l’assenso dato dal generale Badoglio ad «utilizzare prigionieri italiani in servizi non di combattimento, ma connessi con lo sforzo bellico». Sulle base di quell’ambigua dichiarazione infatti gli Alleati trovarono la base giuridica per introdurre la cooperazione su base volontaria. Alcuni cooperarono, perché speravano in un rimpatrio anticipato, altri no; certo è che quelle divisioni, fomentate anche dai detentori, contribuirono alla distruzione di quella fraterna “comunità di campo” che si era costruita in precedenza.
Insomma, i prigionieri italiani in Gran Bretagna rimasero tali fino a quando non acquisirono lo status di reduci: e tuttavia la loro condizione fu differente da quella dei reduci della Grande guerra. Il significato della loro esperienza fu adombrato dalle necessità immediate della nuova Italia, divisa tra molteplici anime e smaniosa di ricostruirsi inserendosi nella parte occidentale del mondo. Sulla lunga distanza la loro memoria si perse: in parte perché la loro non fu una storia eroica, facilmente collocabile nel contesto resistenziale; in parte perché affrontare le vicende di quei prigionieri avrebbe significato recuperare il discorso della responsabilità italiana in guerra, argomento ancora oggi affrontato come un “tabù” nella memoria nazionale.
3. Prigionieri di guerra in fuga dopo l’8 settembre
Ricollegandosi in parte a temi sollevati nei precedenti interventi, il direttore dell’Isrec Marco Minardi si è invece concentrato sul tema della fuga dei prigionieri di guerra dopo l’8 settembre.
L’armistizio portò, nell’immediatezza, un carico di drammaticità e incertezza, poiché introduceva una situazione politica e militare estremamente instabile; ma costituì anche l’evento in seguito al quale la storiografia venne a conoscenza dell’esperienza degli oltre 70.000 prigionieri di guerra alleati in Italia. A questo proposito Minardi ha ricordato l’opera di Roger Absalom del 1991, A Strange Alliance, tradotta in italiano nel 2011, il cui valore sta proprio nella rinnovata centralità che l’autore riconosce al tema dei prigionieri alleati e alla rete dei campi nella storia della guerra in Italia. Un lavoro di fondamentale importanza, perché ha consentito di studiare quei fenomeni affrancandoli dall’abbraccio della storia locale ed inserendoli in un più ampio contesto.
Secondo Minardi, tuttavia, al tema del salvataggio dei prigionieri nei mesi dopo l’8 settembre, su cui si concentra maggiormente Absalom, è da affiancare la storia delle violenze e delle brutalità subite dai prigionieri nei giorni immediatamente successivi all’armistizio, quando molti di loro tentarono la fuga. Un fenomeno che in realtà non ha inizio nel settembre 1943, ma che in molti casi risale addirittura al momento della cattura in battaglia o dei trasferimenti dei prigionieri; e che fu tutt’altro che marginale o episodico, come hanno dimostrato sia la documentazione conservata negli archivi inglesi, australiani e sudafricani, sia lettere, diari e testimonianze. Questa realtà violenta fu lasciata ai margini della ricostruzione storica: fagocitata ed annientata dalla memoria pubblica consolidatasi nel secondo dopoguerra, fondata sul mito degli “italiani brava gente”.
[[figure caption="Ex prigionieri di Fontanellato sul monte Cimone, ritratti insieme ad un gruppo di partigiani (ottobre 1944)" align="right" width="350px"]]figure/2013/malice/malice_2013_03.jpg[[/figure]]Alla luce di questa impostazione, Minardi ha avanzato l’ipotesi – suggestiva, anche se ancora da approfondire – di una possibile lettura dell’armistizio come fine della guerra; e di ciò che seguì come nient’altro che un lungo e logorante interregno tra la guerra e la pace. Una visione che forse si caratterizza per un’eccessiva parzialità, ma che in fondo non si discosta di molto da quella che fu propria, allora, degli ex prigionieri in fuga, dei militari che tentavano di fare ritorno a casa, nonché dei contadini – come quelli di Fontanellato – che li soccorsero.
4. I prigionieri inglesi nei campi italiani
L’ultimo intervento è stato quello della ricercatrice inglese Clare Makepeace. La studiosa si è concentrata sulla condizione dei prigionieri inglesi nei campi italiani – tra cui proprio il PG49 di Fontanellato – ed in particolare sulle esperienze legate all’affettività nella cattività e ai rapporti con le famiglie in patria.
[[figure caption="Clare Makepeace, Lorenzo Bertucelli e Marco Minardi" align="left" width="400px"]]figure/2013/malice/malice_2013_02.jpg[[/figure]] Nell’agosto 1943 erano quasi 42.200 i prigionieri britannici in Italia, e più di 26.100 quelli provenienti dal Commonwealth e dall’impero inglese. Alcuni di loro erano stati catturati sul suolo italiano, altri durante la guerra del Nordafrica tra il 1940 e il 1943: questi ultimi, dopo un periodo trascorso in campi di transito, venivano trasferiti nei circa 70 campi di prigionia situati sul territorio peninsulare. Così come in Germania, anche in Italia i campi assumevano essenzialmente due forme: potevano essere ospitati all’interno di un edificio già esistente - come il campo di Fontanellato, ex orfanotrofio riassegnato per la detenzione di ufficiali inglesi - o costruiti dal nulla. Soldati semplici e gradi più alti erano generalmente reclusi in sezioni separate all’interno dello stesso campo, o in campi diversi, come dimostra ancora una volta il caso del PG49.
Dopo una breve descrizione dei campi e della loro organizzazione Makepeace, specializzata in cultural history delle due guerre mondiali, ha poi esposto al pubblico parte degli esiti della ricerca condotta per la sua tesi di dottorato, sulle esperienze emotive dei prigionieri durante la cattività. Per il suo lavoro – ha spiegato – ha utilizzato 110 testimonianze di ex prigionieri, operando però una divisione tra diari e lettere scritti durante la prigionia e memoirs scritti successivamente. Grazie all’esame di quei documenti la ricercatrice ha dimostrato la centralità del rapporto con gli affetti nella madrepatria nel corso della reclusione.
Se i rapporti con amici e parenti in Gran Bretagna erano molto stretti, altrettanto non si poteva dire di quelli all’interno dei campi – anche se, a questo proposito, la Makepeace ha ammesso che la sua ricerca andrebbe approfondita per quanto riguarda la parte italiana, poiché le fonti da lei prese in considerazione sono relative principalmente a prigionieri reclusi in Germania. Il suo studio, tuttavia, ha dimostrato che i POW inglesi, tra loro, non costruirono una comunità forte; anzi, continuarono a distinguersi tra loro in molti modi: in base all’appartenenza all’Army o alla Air Force, in base alle scuole frequentate, alle professioni, alla lunghezza del periodo di cattività. Da questo punto di vista si tratta di un quadro molto diverso da quello delineato da Isabella Insolvibile per i prigionieri italiani in Gran Bretagna.
Risorse
- Scheda sul campo PG49 di Fontanellato - Campi Fascisti
- http://www.campifascisti.it/scheda_campo.php?id_campo=422
- Recensione a Isabella Insolvibile, Wops. I prigionieri italiani in Gran Bretagna (1941-1946) “Storia e futuro”, n. 30, 2012
- http://storiaefuturo.eu/isabelle-insolvibile-wops-i-prigionieri-italiani-in-gran-bretagna-1941-1946-napoli-edizioni-scientifiche-italiane-2012
- Sito personale di Clare Makepeace
- http://www.warfarehistorian.org