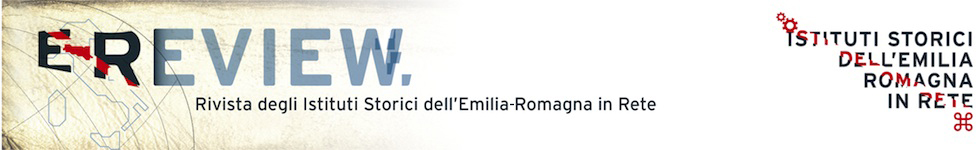1. Gli anni giovanili di Aldo Filicori e di Luigi Zecchini
Oggi, la Filicori Zecchini è una marca di caffè molto conosciuta. Vanta oltre un secolo di vita e in questo breve saggio si vuole ripercorrerne un pezzo di storia, inquadrandola nell’evoluzione del settore e nello sviluppo economico del territorio di riferimento, ovvero la città di Bologna. Aldo Filicori e Luigi Zecchini furono i due imprenditori che diedero il via a tale esperienza, legando il proprio cognome al brand. In quanto artefici di una lunga e proficua collaborazione, partiamo proprio dall’analisi delle loro biografie.
Aldo Filicori nacque il 14 agosto 1887 a Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna. Luigi Zecchini, invece, nacque a Verona il 12 settembre 1892. Sulla famiglia di Aldo Filicori possediamo poche informazioni; si sa solo che il padre, Riccardo Filicori, possedeva alcuni poderi, per cui si desume un minimo grado di benessere. In età infantile, Aldo Filicori, ultimo di cinque figli, rimase orfano di entrambi i genitori, e fino agli anni dell’adolescenza venne allevato dalla famiglia del campanaro di Lovoleto, frazione del comune di Granarolo. Luigi Zecchini, invece, era figlio di Silvio Zecchini e di Regina Doro, riconducibili alla piccola borghesia veronese. Sia Aldo Filicori che Luigi Zecchini avevano ricevuto un’istruzione di base, e si erano inizialmente cimentati in brevi esperienze lavorative di carattere saltuario [1].
Nel 1915 l’Italia entrava nella Prima guerra mondiale. Aldo Filicori venne chiamato al fronte, dove svolse quasi esclusivamente la mansione di addetto al recapito della posta, mentre Luigi Zecchini si trasferiva da Verona a Bologna, assieme alla moglie Corinna Fumanelli, anche lei veronese. Non sono note le ragioni di questa scelta, anche se pare che lavorasse nel campo della commercializzazione di prodotti alimentari e che fosse stato inviato a Bologna in qualità di agente. Non è nemmeno chiaro in quale occasione, al termine del conflitto mondiale, Aldo Filicori e Luigi Zecchini si conobbero, anche se si può ipotizzare che il loro incontro avvenne per ragioni di lavoro.
Infatti, un fratello di Aldo, Archimede Filicori, dal 1911 aveva intrapreso un’attività di rappresentanza di generi alimentari; è probabile che dopo aver conosciuto per affari Luigi Zecchini, lo avesse presentato al fratello Aldo, che aveva da parte un modesto capitale e che aveva maturato l’idea di dare vita ad una qualche attività imprenditoriale. Tra i due nacque subito un’amicizia e si elaborò il progetto di avviare una società che operasse nell’ambito della torrefazione del caffè che, all’epoca, sembrava un comparto economicamente promettente.
2. L’avvio della ditta di caffè
Il 21 ottobre del 1919, quindi, per la ragguardevole cifra di 5.000 lire, acquistarono la Ditta Alcibiade Bacchi, dall’omonimo proprietario, costituendo una società in nome collettivo, rinominata Ditta Alcibiade Bacchi di Filicori e Zecchini. Il capitale sociale, che ammontava a 40.000 lire, fu interamente versato da Aldo Filicori, mentre, come veniva scritto dal notaio, Luigi Zecchini avrebbe «messo la propria opera»; gli utili, però, sarebbero stati divisi in parti uguali [2]. La sede della ditta era in via Caprarie, nel pieno centro storico di Bologna.
Inizialmente, era poco più che un negozio collegato ad un piccolo stabilimento. In un locale avveniva, in maniera artigianale, la lavorazione del caffè, mentre, a pochissima distanza, c’era la rivendita, che commercializzava il prodotto sia al dettaglio che all’ingrosso. Il retrobottega fungeva da magazzino. All’epoca i vari gestori di bar non ricevevano direttamente i sacchi di caffè acquistati dal proprio fornitore di fiducia, ma erano soliti recarsi autonomamente alla torrefazione per le proprie scorte. Per cui, in questa fase iniziale, la Filicori e Zecchini, che contava un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità, assomigliava ad una delle tante botteghe artigiane dell’epoca, nelle quali produzione e vendita si coniugavano all’interno del medesimo contesto.
Ben presto, però – soprattutto per volontà di Luigi Zecchini, che nel settore aveva un’esperienza più ampia – vennero aperti alcuni negozi e spacci collegati con la sede principale. Si trattava di esercizi commerciali che assommavano servizi differenti. Il caffè veniva venduto al dettaglio, già tostato ma anche crudo, oppure veniva servito in degustazione. Fin dagli esordi, questi negozi, non furono mai dei veri e propri bar, come dimostra il fatto che al di fuori del caffè venivano servite poche altre bevande, e tutte analcoliche, quanto piuttosto dei luoghi in cui si consumavano più tipi di caffè, oltretutto qualitativamente migliori di quelli generalmente proposti nei tradizionali locali pubblici, se non altro per il fatto che in genere la macinazione dei chicchi avveniva subito prima della preparazione, il che preservava le qualità aromatiche [3].
Infatti, la strategia imprenditoriale di Luigi Zecchini e di Aldo Filicori era quella di far conoscere direttamente al pubblico un prodotto qualitativamente di fascia alta, per poi venderlo all’ingrosso sotto il proprio marchio ai singoli esercenti. Fu un metodo che consentì una rapida espansione dell’azienda che pure doveva concorrere con ditte come la Roversi, presente a Bologna dal 1882, o come la Cagliari, modenese, ma all’epoca già attiva in buona parte del mercato regionale [Negri Zamagni 1986]. Tra l’altro, alcuni mesi dopo la costituzione della Filicori e Zecchini, il 7 agosto 1920, il fratello di Aldo, Archimede, decise anch’esso di inserirsi nel settore. Acquistò, pertanto, una piccola torrefazione nel centro storico di Bologna – la Roberto Veronesi – alla quale collegò, due anni più tardi, un bar-drogheria. Sempre nel 1922, Archimede Filicori acquisì una seconda torrefazione, denominata Moderna, che però ebbe un esito più infelice e giunse alla chiusura un anno dopo [Battilani 2001].
Non ci è dato sapere quali rapporti intercorressero tra la Filicori e Zecchini e la ditta di Archimede, anche perché si trattò di una concorrenza estremamente limitata nel tempo; infatti, quest’ultima impresa, dopo una piccola espansione tra il 1924 e il 1930, in particolare grazie al fortunato marchio «Filicori, il re dei caffè il caffè dei re», entrò in una profondissima crisi in seguito alla morte di Archimede, e sparì dal panorama economico.
3. La Filicori Zecchini fra espansione e difficoltà generate dall’autarchia
Negli stessi anni, la Filicori e Zecchini continuava quella rapida ascesa verso la leadership nel mercato bolognese. Nel 1928 i due imprenditori pensarono di separare la produzione dal commercio. La loro ditta si sarebbe occupata esclusivamente del primo aspetto, mentre una seconda società avrebbe assunto compiti mercantili. Assieme a Giovanni Battista e a Fernando Bozzoli, imprenditori commerciali, costituirono la Mocha, destinata, però, a concludere in breve tempo il proprio ciclo. In meno di due anni, gli screzi con i nuovi soci portarono allo scioglimento della società che, di fatto, non aveva mai raggiunto un’operatività completa. La Filicori e Zecchini, quindi, mantenne quella configurazione che la vedeva impegnata sul fronte della produzione, su quello del commercio e su quello della gestione di piccoli esercizi.
Nei primi anni Trenta, il caffè Filicori e Zecchini era già noto in tutta Bologna, in buona parte della provincia e in alcune località emiliano-romagnole, tant’è che, nonostante un percorso imprenditoriale ancora breve, sia Aldo Filicori che Luigi Zecchini ricevettero importanti onorificenze: quella di Cavaliere il primo, e quella di Grande ufficiale il secondo. Nel 1933, la loro impresa era diventata «provveditrice ufficiale» della Casa reale italiana [4]. Sul finire del 1938, dopo che la Camera di commercio aveva già da alcuni anni disposto che nelle pratiche potesse scriversi Ditta Filicori e Zecchini, anziché Ditta Alcibiade Bacchi di Filicori e Zecchini, il nome venne definitivamente aggiornato.
Nella seconda metà degli anni Trenta, la politica economica autarchica mise in difficoltà le varie torrefazioni italiane. Una serie di provvedimenti economici avrebbero dovuto valorizzare le produzioni nazionali e, soprattutto, evitare che l’Italia dipendesse in una qualche maniera dall’importazione di materie prime e prodotti stranieri che, in caso di guerra, avrebbero potuto essere bloccate. Il graduale razionamento alle importazioni imposto dal regime, spinse in alto i prezzi di alcuni generi di consumo, tra i quali il caffè. Molti torrefattori convertirono una parte della produzione, altri addirittura chiusero lo stabilimento e liquidarono l’impresa. Nella cultura gastronomica italiana dell’epoca si affermarono alcuni surrogati, come il caffè d’orzo o quello di cicoria, che però, al gusto risultavano significativamente differenti, e da un punto di vista nutrizionale mancavano delle qualità eccitanti della caffeina [Zani 1988].
La Filicori e Zecchini diminuì la produzione e tentò di inserirsi nel commercio di altri prodotti alimentari. Già dalla fine degli anni Venti, nei vari negozi dell’azienda erano in vendita anche lo zucchero e alcune spezie; ora queste merci iniziarono ad essere trattate anche all’ingrosso. Ma si trattò di un palliativo; in pratica, per tutti gli anni dell’autarchia e del successivo conflitto, la ditta vide bloccate quelle possibilità di espansione che si erano profilate in precedenza.
I due soci, però, credevano ancora nell’azienda, nel mercato del caffè e delle altre referenze che avevano iniziato a trattare. Nel 1940 procedettero ad un aumento di capitale, il quale, tra l’altro, risolse l’anomalia delle origini, che aveva visto uno solo dei due soci in qualità di finanziatore. Aldo Filicori versò 160.000 lire, mentre Luigi Zecchini 200.000 lire, e si ritrovarono, quindi, con una uguale quota sociale [5]. Le successive vicende belliche si ripercossero in maniera ulteriormente negativa sull’attività della torrefazione. I razionamenti, la compressione dei consumi, il richiamo alle armi di molti operai, fecero progressivamente calare la produzione fino quasi ad azzerarla negli anni della Repubblica sociale italiana.
4. Dal secondo dopoguerra alla scomparsa dei fondatori
Con la Liberazione, venne rapidamente dismesso dalla cultura gastronomica nazionale il caffè di cicoria. La rapida ripresa dei commerci permise alle varie torrefazioni di ritornare a livelli produttivi pre-autarchici. La Filicori e Zecchini, dopo un quinquennio postbellico di significativa risalita, ebbe un piccolo ridimensionamento delle attività di vendita al minuto e di degustazione. Alcuni esercizi furono chiusi, tra i quali, nel dicembre del 1952, quello di via Clavature, che per anni aveva rappresentato uno storico luogo d’incontro per gli amanti della cultura del caffè. In pratica, sul finire degli anni Cinquanta, la ditta conservava la propria sede sociale in via Caprarie, dove c’era uno spaccio-degustazione, collegato ad un secondo locale, situato nella adiacente via Orefici, mentre lo stabilimento per la torrefazione, lo stoccaggio delle merci, e la vendita all’ingrosso si trovava lungo la via Emilia, in direzione S. Lazzaro di Savena.
Negli anni del miracolo economico la Filicori e Zecchini mantenne quella notorietà sulla piazza di Bologna che in precedenza aveva conquistato. I dipendenti si attestarono attorno alla trentina di unità, mentre i bilanci si chiudevano con soddisfazione dei soci. Tuttavia, mancò l’approdo sui mercati esteri, come invece avevano fatto altre ditte nello stesso calibro. Questo balzo di qualità che avrebbe sdoganato l’impresa da un circuito economico esclusivamente locale, si sarebbe avuto solo negli anni Ottanta. Nonostante ciò, si trattava di un’impresa decisamente rilevante a livello regionale, dato che poteva vantare su circa 600 clienti, composti da bar e ristoranti, distribuiti, oltre che nel Bolognese, nelle province romagnole e, in misura minore, nel Ferrarese. Nel 1959 fu fatto un nuovo importante investimento, ovvero un nuovo stabilimento produttivo alla periferia nord di Bologna, in località Dozza.
In questa fase, si ebbe la scomparsa di uno dei due fondatori: il 22 dicembre 1961, poco più che settantenne, moriva a Bologna Aldo Filicori, lasciando i figli Archimede, Giovanni, Franco e Riccardo, e la moglie Margherita Gozzoli; circa due anni prima era deceduto il figlio ventottenne Romano Filicori (23 maggio 1930 – 19 gennaio 1958) [6]. L’azienda, con una consolidata connotazione di media impresa, continuò la propria attività sotto la direzione del socio Luigi Zecchini. Nel 1964, per ragioni di età, l’avrebbe ceduta a Giovanni Filicori.
Quest’ultimo dovette affrontare il successo di una diretta concorrente, la Segafredo – non ancora di proprietà della famiglia Zanetti – che dal secondo dopoguerra aveva messo in pratica una innovativa strategia di marketing. Per acquisire nuovi clienti, aveva iniziato a dare in comodato d’uso delle macchine da caffè e delle insegne luminose ai vari esercenti che la sceglievano come fornitrice [Danesi 2003]. Era una strategia vincente che, negli anni a venire, sarebbe stata adottata da moltissime altre imprese del settore, Filicori e Zecchini compresa.
Nonostante ciò, anche in una fase in cui si era esaurito lo slancio del miracolo economico, la Filicori e Zecchini rimaneva una delle torrefazioni più prestigiose e conosciute del Bolognese. Superati da poco gli ottant’anni, il 31 dicembre 1973 si spegneva a Bologna anche Luigi Zecchini. Lasciava la moglie Corinna Fumanelli e i figli Giorgio e Maria Luisa [7]. Le gestioni della seconda e della terza generazione delle famiglie Filicori e Zecchini, ancora oggi alla guida dell’impresa, avrebbero dato ulteriore lustro all’azienda. E oggi, a oltre mezzo secolo di distanza dalla scomparsa dei fondatori, questi vengono celebrati per le capacità e la visione lungimirante che seppero mettere in campo:
Alla fine della Prima Guerra Mondiale – si legge sul sito web societario –, Aldo Filicori e Luigi Zecchini decisero di dare vita ad una realtà commerciale a Bologna che abbracciava, sotto il loro sguardo vigile ed esperto, l’intera filiera del caffè, dall’importazione dei chicchi fino alla preparazione dell’espresso. Attorno a quella tazzina si è presto creato un vero e proprio mondo di valori, che, ancora oggi, coniuga la passione artigianale con l’innovazione tecnologica per creare prodotti inconfondibili [8].
Bibliografia
- Battilani 2001
Patrizia Battilani, Il percorso impossibile. Dal laboratorio artigiano alla grande impresa nel settore alimentare: Bologna, in Comunità di imprese. Sistemi locali in Italia tra Ottocento e Novecento a cura di Franco Amatori, Andrea Colli, Bologna, il Mulino, 2001. - Danesi 2003
Alfredo Danesi, Caffè, mito e realtà. Storia, cultura e ricerca, Avezzano-Roma, Idea Libri, 2003. - Negri Zamagni 1986
Vera Negri Zamagni, L’economia, in Bologna a cura di Renato Zangheri, Roma-Bari, Laterza, 1986. - Zani, 1988
Luciano Zani, Fascismo, autarchia, commercio estero: Felice Guarneri un tecnocrate al servizio dello Stato nuovo, Bologna, il Mulino, 1988.
Note
1. Archivio della Camera di Commercio di Bologna, fasc. r.e.a. 1683, Note.
2. Archivio della Camera di Commercio di Bologna, fasc. r.e.a. 1683, Statuto e Atto costitutivo.
3. Biblioteca universitaria, sezione opuscoli, f. a.2. GuerraCassPer 3/21, Al Brasile: numero unico omaggio. Filicori & Zecchini, Bologna, importatori torrefattori di caffè.
4. Biblioteca universitaria, sezione opuscoli, f. t4626/tor166255, Il Caffe del Brasile: Filicori e Zecchini importatori.
5. Archivio della Camera di Commercio di Bologna, fasc. r.e.a. 1683, Comunicazioni.
6. Dati ricavati dai database anagrafici cimiteriali e del Comune di Bologna.
7. Ibid.