1. Introduzione
La mancata pubblicazione di un archivio può essere per lo storico un’esperienza frustrante e finire col diventare un vincolo anche insolubile nel corso di una ricerca, specialmente quando il produttore dello stesso è una figura storicamente di primo piano o comunque tra i protagonisti di fasi particolarmente importanti. Fino a pochi anni fa, rientrava in questa categoria anche Italo Balbo, squadrista della prima ora, quadrumviro della marcia su Roma e governatore della Libia dal 1934 al 1940. La documentazione privata del gerarca fascista, infatti, per vari decenni non è stata liberamente accessibile agli studiosi, rimasta custodita dal figlio Paolo nella casa di famiglia a Ferrara, in via Borgo dei Leoni 7 [Govoni 2022], in una dimensione di riservatezza raramente alleggerita fino al luglio 2016. In tale occasione, Paolo Balbo e la moglie Paola Bellini donarono all’Istituto di storia contemporanea della città la collezione del «Corriere Padano» – il quotidiano fondato dal quadrumviro nel 1925 –, un’iniziativa a cui seguì la decisione di cedere l’interezza del patrimonio documentario da loro detenuto. È così che il 15 giugno 2018 è stato ufficializzato il primo passaggio di proprietà, in una serie di trasferimenti proseguiti fino alla fine del 2020. Finalmente disponibile ai ricercatori, l’archivio in questione si compone di una notevole varietà di documenti che vanno dalla biblioteca personale di Balbo ad una lunga serie di fotografie, passando per riviste, carte geografiche e lettere ricevute dai propri ammiratori. Tutto questo materiale rende possibili nuovi percorsi di ricerca, fra i quali rientra anche il presente articolo. Avendo modo di accedere alla documentazione privata del gerarca si possono operare svariate indagini sulla sua figura che vanno dalla sua vicinanza giovanile al repubblicanesimo, ricordata dalle numerose opere di Mazzini conservate, al rapporto con la Francia – il paese che ricorre più di frequente nell’archivio.
In questo contesto, nello specifico, si intende approfondire la dialettica instauratasi tra Balbo e il contesto coloniale nei suoi anni al governatorato della Libia, e come questa si sia declinata tanto a forgiare l’immaginario del gerarca quanto a condurne l’operato politico. Nell’operare questa ricerca, si è proceduto con un’analisi dettagliata del contenuto dell’archivio, in seguito alla quale si è avuto modo di individuare al suo interno alcuni fili conduttori tematici a cui è riconducibile la massima parte della documentazione archivistica di ambito coloniale conservata da Balbo; tali categorie sono state quindi utilizzate per organizzare logicamente dapprima il materiale ritenuto significativo ai fini dello studio e successivamente anche al fine di definire la struttura del testo. L’articolo si svilupperà quindi proponendo una sezione introduttiva che spieghi perché si ritiene utile una ricerca di questo tipo, facendo riferimento sia ad una problematica metodologica di ampio respiro che a quale sia l’interesse specificatamente riconducibile a Italo Balbo. A questo seguiranno tre sezioni, ognuna delle quali affronterà dettagliatamente il materiale studiato mettendolo in relazione con una specifica area tematica di riferimento che si è tentato di analizzare facendo continuo affidamento alla teoria storiografica come ad aspetti più strettamente biografici.
2. Italo Balbo, un case study
Occorre in questo senso comprendere in che modo uno studio di questo tipo possa essere utile non solo per fornire un nuovo punto di vista sulla vita di Italo Balbo – già largamente studiata dagli storici [1] – ma anche dalla prospettiva della storia del colonialismo. Il soggetto, infatti, costringe lo storico a confrontarsi con spazi geografici particolarmente estesi e con una varietà di problemi storiografici non completamente risolti dalla riflessione teorica in materia. Malgrado i numerosissimi sforzi fatti e i vari sottogeneri storiografici creati per venirne a capo, ancora oggi si fatica ad abbandonare un modus operandi che è sostanzialmente eurocentrico o comunque “eurocentrato” ponendo inevitabilmente le nazioni europee come soggetti unici o principali di un’azione semplicemente subita dal resto dell’umanità. In tal senso, l’Europa diviene in una volta sola il punto di partenza sia dell’intenzione colonialista, sia degli studi in materia – puntualmente definiti in relazione alla potenza colonizzatrice. Così facendo, si ripropone inevitabilmente l’oggettivazione del colonizzato, un “altro” puntualmente ridotto ad una proprietà prima del dominio reale coloniale e ora di quello simbolico-culturale della scienza storica [Todorov 2014]. Posti questi termini del discorso, l’esistenza stessa del mondo extra-europeo è direttamente determinata dalla presenza di una visione coloniale, come se ci fosse bisogno di una legittimazione concessa dall’alto. I rischi di questa prospettiva in ambito storiografico sono particolarmente evidenti e si traducono in una forma di razzismo suprematista più o meno consapevole che non solo è odioso ma azzoppa la comprensione del passato nella produzione di schemi interpretativi obsoleti e inefficaci – ad esempio, legando a doppio filo il concetto di “modernità” alla sua definizione occidentale, fino a negare la possibilità che questo potesse essere anche solo pensato altrove [Chakrabarty 2008]. A tal proposito, è ormai un fatto assodato che la disciplina storica (così come altre, umanistiche e non) sia stata largamente piegata ai fini della riproduzione sociale del sistema coloniale, fornendogli delle legittimazioni che si pretendeva essere scientificamente fondate [Said 2013]. Nonostante questo, è comunque possibile sfruttare questa considerevole limitatezza per farne uno strumento utile a definire una trattazione più completa della storia coloniale, declinandone i difetti a proprio vantaggio. Davanti ad una storiografia viziata dalla prospettiva del colonizzatore e nel caso in cui manchino gli strumenti epistemologici per affiancarvi una lettura coerente e decostruita del colonizzato, occorre concentrarsi sul primo. Così facendo, naturalmente, restano irrisolti i problemi sopra esposti, semplicemente messi fra parentesi piuttosto che avventurarsi nella ricerca di una soluzione che sarebbe inevitabilmente goffa e parziale. Accettando l’incompletezza e rinunciando ad una visione complessiva su una questione tanto vasta, si ritiene possibile approfondire in modo più chiaro il singolo oggetto della ricerca, il ruolo da lui esercitato e anche l’immaginario che ne determina l’azione. Così facendo, però, si esce da quello che è il sentiero della storia coloniale propriamente detta – che non può esistere in una visione a metà – per arrivare al campo della memoria coloniale. Questo particolare punto di vista è ancillare alla storia del colonialismo, giacché non ne problematizza l’esperienza nella sua interezza ma la sola percezione che ne ha avuto una delle parti coinvolte, ma non per questo è meno efficace. Le ipocrisie, le menzogne e il suprematismo propri della visione colonialista vengono infatti mantenuti nella propria integrità allo scopo di entrare nei panni del “carnefice” – senza volerlo giustificare, né identificarcisi – e osservarne l’operato più da vicino. Questa modalità operativa non differisce troppo dallo studio delle opere etnografiche di età moderna [Parker 2020], ma la si è applicata soprattutto nei confronti di interi popoli europei, approfondendone la produzione artistica, letteraria e culturale per individuarvi l’impronta lasciata dal periodo coloniale e, in un secondo momento, per cercare di capire perché sia così difficile per una nazione ammettere le proprie colpe in tale ambito. Più raro è stato il tentativo di applicare la medesima lente allo studio di un singolo individuo – come si farà in queste pagine – allo scopo di restare focalizzati sulla sua esperienza personale, un esperimento che però può rivelarsi estremamente importante nel momento in cui si tratta di un protagonista del periodo come un funzionario o un governatore.
Malgrado goda da sempre di una nomea positiva che l’ha voluto ora “amico degli ebrei” (un’idea da considerarsi falsa [Fabre 2023]) ma anche colonialista “gentile”, l’adesione di Italo Balbo all’ideologia imperialista coincide esattamente con quella al fascismo [Guerri 1984], ragion per cui si può ragionevolmente affermare che la sua visione dell’impero fosse motivata in primo luogo dal nazionalismo razzista e dall’idea che gli stati europei avessero il diritto ad espandersi oltremare. In che modo Balbo abbia inteso individualmente questa ideologia diffusa in tutta la politica europea è quanto si intende comprendere in questo articolo, appunto attraverso l’analisi della documentazione da lui detenuta. In questo senso e tenuto da conto le premesse di cui sopra, tale lavoro vuole porsi come un’intersezione di approccio biografico e di storia coloniale finalizzata a definire la dialettica di influenze instauratasi tra colono e colonia. Naturalmente, visto l’utilizzo esclusivo del punto di vista di Balbo, la ricerca risulterà sbilanciata nel proprio equilibrio interno ma come detto in precedenza ci si rende conto che uno studio di questo tipo sia utile soprattutto per definire più chiaramente l’elemento europeo e non il contesto coloniale nella sua interezza. Dopotutto, è doveroso anche sottolineare come le ristrettissime politiche culturali ed educative messe in atto dall’Italia nelle proprie colonie hanno fortemente compromesso la scolarizzazione dei territori e di conseguenza limitato la possibilità che in questi paesi si sviluppasse, durante ma anche dopo l’indipendenza, un pensiero anti-coloniale e post-coloniale che producesse una lettura critica degli anni sotto il governo italiano [Palumbo 2003]. A confermare la coscienza circa questa limitazione, si è ritenuto utile concentrare le ricerche sul solo materiale accumulato da Balbo durante l’esercizio del mandato di governatore, anche al fine di evitare una ricerca che diventasse una forma di storia intellettuale strettamente teorica che sarebbe risultata poco utile nella definizione del rapporto bidirezionale fra il gerarca e l’Africa italiana. Questo, dopotutto, costituisce un notevole fattore di interesse vista la relativa unicità del governatorato di Balbo entro l’intera esperienza coloniale italiana; è ormai fatto accertato che il colonialismo italiano, pur essendo stato meno longevo di quello di altre nazioni europee, abbia fatto continuo affidamento a spettacolari quanto terrificanti livelli di violenza ai danni delle popolazioni colonizzate [Del Boca 2005]. Date le scarse possibilità economiche del regno, le ancora più ridotte capacità dimostrate nell’implementare politiche di sviluppo risolutive e la lontananza geografica delle colonie, l’Africa italiana fu di fatto sottoposta ad un prolungato regime emergenziale implementato militarmente che non permise mai l’affermarsi di un certo grado di stabilità tale per cui i territori in questione potessero divenire qualcosa di più che una – scarsa e costosissima – fonte di legittimazione nei rapporti internazionali. Fa eccezione in questo contesto la Libia degli anni Trenta, che sebbene non fosse a sua volta mai divenuta un affare economicamente redditizio per l’Italia risultava comunque sufficientemente vicina e pacifica (visto il successo della repressione genocida messa in atto per sedare la ribellione ivi scoppiata all’inizio del decennio precedente) da tentare di mettervi in piedi una vetrina propagandistica per il regime fascista – e fu proprio questa la missione assegnata a Balbo dal governo fascista [Rochat 1986]. Nei suoi sei anni di governatorato della Libia – fra i più lunghi dell’intera storia coloniale italiana – il gerarca ferrarese fu particolarmente libero di plasmare il territorio a suo piacimento negli ambiti più disparati. Il mito popolare che vuole Balbo “colonialista buono” nasce quindi proprio dal fatto che lui solo «poté dedicarsi alla pars costruens del progetto coloniale» [Deplano, Pes 2024, 99] senza doversi preoccupare di mettere pienamente in moto i normali meccanismi coercitivi coloniali, banalmente perché solo in Libia si era stati capaci di porre fine alle crisi più gravi ed urgenti [Cresti, Cricco 2015] che invece le altre colonie non furono mai capaci di superare, a causa dell’eccessiva lontananza o dell’incapacità di sottomettere la popolazione al proprio controllo. Caso più unico che raro di operatività e longevità al potere nella storia coloniale italiana, è proprio questo elemento a rendere tanto interessante la figura di Italo Balbo che in questo senso può essere considerato l’unico governatore coloniale italiano a tutto tondo, rivelandosi anche in virtù della propria personalità il solo ad essere stato capace di lasciare un segno personale nella propria amministrazione che non sia riducibile alla sola efferatezza nei confronti della popolazione nativa. A quanto già detto bisogna poi aggiungere l’elemento personale fornito da Italo Balbo, un entusiasta aderente al fascismo della prima ora che però fu capace di non appiattirsi completamente sul suo ruolo di gerarca, capace di riassumere su di sé come di contraddire qualunque considerazione sul Ventennio e risultando in definitiva un soggetto «sempre diverso e spiazzante, a seconda dell’angolo di visuale da cui si decide di osservarlo» [Baravelli 2021, 13].
Tornando alla documentazione donata all’Istituto di storia contemporanea di Ferrara, occorre capire in che modo questa possa raccontare il particolarismo della figura di Balbo. Senza cadere nell’idea erronea che un archivio possa essere considerato a priori come riflesso della personalità che l’ha prodotto [Valacchi 2015], occorre comunque ribadire che nel caso in questione ci troviamo davanti ad un corpus documentario composto da oltre 2.500 esemplari in massima parte conservati dal gerarca in persona [2] per interesse personale piuttosto che per necessità pratiche. In virtù di ciò, quello che ci si ritrova davanti è una vera e propria materializzazione dell’immaginario di Balbo talmente chiara che – pur concentrandoci sul solo aspetto coloniale, da lui notoriamente mal sopportato [Rochat 1986] – è possibile individuarne con notevole chiarezza le principali aree d’interesse, tanto evidenti da essere facilmente riconducibili a tre precise categorie. La prima di queste è l’ossessione per la guerra, a cui segue un immaginario esotico- avventuroso e infine il problema dell’emigrazione italiana; ciascuno di questi «è puntualmente attraversato dal profondo personalismo del quadrumviro che, perfino nel privato del proprio archivio, si rivela estremamente attento a delineare una immagine di sé stesso virile ed eroica, l’archetipo di uomo ideale ben più completo di quanto non richiesto dai già restrittivi criteri fascisti di mascolinità [Benadusi 2014].
3. La Libia geopolitica
In questo senso è naturale che il principale focus di Balbo sia quello militaresco, senza dimenticare che tanto lui quanto il fascismo nella sua interezza avevano il proprio mito fondatore nella guerra e nell’esperienza del primo conflitto mondiale. Il contesto coloniale è quindi da intendersi ai loro occhi come una proiezione di potenza della metropoli nel più vasto agone geopolitico internazionale, uno strumento strategico o da utilizzare in un potenziale nuovo scontro su larga scala. Tale percezione del colonialismo la si ritrova anche nei paesi liberali, ma solo nei regimi nazionalisti e autoritari dell’Europa meridionale acquisisce una tanto forte declinazione propagandistica – si pensi alla particolare insistenza sul tema nel Portogallo degli anni Trenta [Buettner 2016]. Tale aspetto diviene ancora più centrale in un contesto quale quello del colonialismo italiano, in cui i possedimenti d’oltremare restituivano un ritorno economico tutto sommato scarso, per cui la loro rappresentazione come avamposti cruciali in caso di guerra diveniva necessaria anche solo per legittimare le enormi somme di denaro ivi investite (960 milioni di lire fra il 1937 e il 1942 nella sola Libia [Segrè 2000]); al contempo, non si può ridurre tale prospettiva ad un mero calcolo politico del regime o ad un tòpos fascista e infatti occorre ancora una volta guardare al ruolo determinato giocato dall’ambizione personale di Balbo. Nominato governatore della Libia al fine di essere allontanato dalle luci della ribalta una volta che Mussolini aveva iniziato a percepirne la fama come una minaccia, infatti, il quadrumviro accettò l’inattesa posizione marginale proprio perché si augurava che questa gli potesse garantire un ruolo di primo piano in caso di una guerra futura [Labanca 2002]. Tenuto a mantenere un basso profilo, Balbo esprime questa speranza in modi più discreti, facendo uso di un linguaggio difensivo come quello che si riscontra nella sua relazione del 1939 La colonizzazione in Libia – conservata nell’archivio di Ferrara in tre diverse copie – e nella quale dichiara di non aver «bisogno di illustrare l’importanza della Quarta sponda agli effetti della difesa e della potenza dell’Italia fascista, che ha il suo centro di vita nel Mediterraneo» [Balbo 1939, 12]. Al contempo, per quanto ambizioso potesse essere, Balbo non era certo uno sprovveduto e anzi la sua biblioteca rivela un profilo di avido lettore di saggi di teoria militare e relazioni internazionali, evidentemente al fine di comprendere quanto fosse probabile un nuovo conflitto su vasta scala. Saggi come La guerra segreta per il petrolio, scritto nel 1936 dal giornalista austriaco Anton Zischka, sono infatti tra i più usurati fra quelli conservati nell’archivio, così come le pubblicazioni che collegano la guerra d’Etiopia ad una potenziale escalation militare a livello europeo – si ricorda che l’invasione aveva implicato l’accerchiamento italiano dell’Egitto, una colonia de facto di Londra la cui conquista era il sogno non dichiarato di Balbo [Labanca 2002]. Non a caso la nuova frontiera calda torna più volte fra gli scaffali della sua raccolta nelle forme più diverse, trattasi di saggistica in testi come La questione etiopica (in cui ci si augura eufemisticamente che Il Cairo possa «assidersi un giorno non lontano al lieto concilio dei popoli liberi») o in pubblicazioni di tono più satirico, la cui presenza nell’archivio desta stupore [3]; è il caso dell’Abyssiniomachie, un breve testo francese scritto prima della guerra ma già ferocemente critico rispetto alle mire fasciste sull’Africa orientale, interpretate come possibile causa di un’escalation militare tra l’Italia e l’Inghilterra. Lo scontro prospettato, però, non sembra essere visto da Balbo come una contrapposizione di valori e infatti nella sua biblioteca la possibilità di una guerra intra-europea è sempre trattata in toni pragmatici o al più nazionalistici, senza che sia fornita una qualche ulteriore carica ideologica: per ogni libro in cui si proclama che «prima o poi gli attuali detentori dell’Affrica dovranno riconoscere all’Italia un diritto di cittadinanza nel continente nero» [Tuninelli 1933, 272], ne corrisponde un altro in cui si afferma come necessaria l’unità delle nazioni occidentale in vista della contrapposizione con i popoli asiatici, un tema molto comune nella prima metà del Novecento [Gentile 2008] e riscontrabile nell’archivio in opere come L’India e gli inglesi, pubblicato ancora nel 1936.
Insomma, la guerra è per Balbo una prospettiva concreta con la quale fare i conti nella quotidianità dell’amministrazione coloniale, e dopotutto proprio questo è il fine di una gran parte del suo operato in Libia. Il rafforzamento dei trasporti e delle comunicazioni, la creazione di una qualche rete sanitaria, le politiche per l’autosufficienza alimentare libica, sono tutte operazioni che avevano come preciso scopo la trasformazione della colonia mediterranea in un hub strategico-militare funzionale. Eppure, niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza instaurare un qualche rapporto con la popolazione araba, profondamente compromesso dall’estrema violenza dei suoi predecessori – si ricorda in questo senso la particolare brutalità dimostrata da Rodolfo Graziani in Cirenaica [Volterra, Zinni 2021] – e fu proprio a tale scopo che Balbo chiuse i campi di internamento e concesse ai profughi il diritto di rientrare nelle proprie terre [Guerri 1984]. Che questa riformulazione dei rapporti con i libici avesse finalità soprattutto geopolitiche e opportunistiche è evidente ad esempio se si guarda alla narrazione propagandistica del regime fascista come protettore dell’Islam [Labanca 2002] ma questo non implica che non vi sia stato un qualche mutamento sostanziale nei rapporti fra coloni e colonizzati. I secondi, infatti, smettono sotto il governatorato di Balbo di essere considerati come nemici potenziali e si ritrovano relativamente più integrati nella società coloniale. Vista la svolta rispetto ai decenni precedenti non stupisce che il tema venga sottolineato in moltissimi dei libri della biblioteca, per quanto sia senza dubbio esagerata l’idea, riportata nella pubblicazione francese La politique islamique de l’Italie, per cui il ferrarese sarebbe stato «un Gouverneur qui s’est rapproché de l’élément indigène avec pleine compréhension et franchise». In questo senso occorre sottolineare come l’ammorbidimento del controllo sulla popolazione araba non fosse assolutamente il primo passo nell’instaurazione di un regime egualitario [Rochat 1986] e questo lo si riscontra già dal fatto che non vi sono nell’archivio testi che testimonino un qualche approfondimento della cultura libica – fatta eccezione per un unico volume dedicato ai Santuari Islamici nel secolo XVII in Tripolitania. Quello a cui sembra aspirasse Balbo potrebbe essere piuttosto l’integrazione dei continenti europeo ed africano in un unico blocco politico-economico, legandone indissolubilmente i destini nella costituzione di un’entità nuova e indipendente. Tale proposta non prescindeva dai presupposti del pensiero coloniale, e infatti non solo l’Africa ne sarebbe stato il partner più debole ma meritava tale posizione proprio perché lo si considerava un contesto più arretrato rispetto al resto del mondo, ragion per cui sarebbe stato « in Africa che la latinità [poteva] dare ancora l’impronta a gran parte del continente» [D’Agostino Orsini Di Camerota 1934, 17]. Eppure non si può ridurre tale visione ad una semplice rivisitazione in chiave geostrategica del colonialismo, dal momento che pur di vederla implementata gli autori impegnati a propagandarla si dicevano disposti ad accettare politiche di piena tolleranza religiosa e un’apertura all’immigrazione nelle metropoli, in coscienza che la simbiosi tra i due mondi dovesse essere reale e non soltanto formale – come suggeriscono testi consumati e dai titoli eloquenti come Africa Bianca e Eurafrica. L’obiettivo ultimo è il conseguimento di un’autonomia strategica del Vecchio continente dalla sopracitata “minaccia” asiatica come dalla crescente egemonia statunitense che non a caso avrebbe ancora goduto di una certa popolarità, specie negli ambienti dell’estrema destra francofona, nei primi decenni dopo il secondo conflitto mondiale [Lee 1997]. L’invasione dell’Etiopia può essere considerata in questo senso come una sorta di prova generale dello sfruttamento militare dei libici ai fini delle ambizioni strategiche italiane: per averne la prova non serve fare riferimento alla storiografia, che ha già provato come Graziani istigasse le truppe coloniali contro il nemico adducendo motivazioni religiose [Del Boca 2003], ma semplicemente ai libri conservati da Balbo in cui si afferma che «per il compimento dell’impresa abissina la Libia ha magnificamente assolto al proprio compito politico e militare» [Ambrosini 1937, 25].
Il carattere razzista del regime coloniale non viene in alcun modo messo in discussione da questa circostanza e non stupisce quindi che fra i testi di Balbo sia conservato un volume di Johann von Leers, filosofo esoterista tedesco e membro delle Waffen-SS, in cui la depurazione della Germania dagli «inquinamenti giudaici» è messa in parallelo all’idea che «il Fascismo vuole che l’Italia sia romana, esclusivamente romana» [von Leers 1940, 21]; dopotutto è lo stesso Balbo che nella sua relazione del 1938 La politica sociale fascista verso gli arabi della Libia – conservata nell’archivio in ben sei copie – distingue la popolazione sahariana, a cui sarebbe necessario approcciarsi facendo affidamento ad una «politica coloniale di carattere paternalistico», dagli abitanti della costa «di razza superiore influenzata dalla civiltà mediterranea» che malgrado presenti «caratteristiche innegabili di nobiltà, di intelligenza e di levatura morale» ha pur sempre bisogno di essere assistita mediante un «complesso di provvidenze dirette alla loro elevazione morale ed alla loro evoluzione civile» [Balbo 1938, 4]. Poco importa se nelle pagine seguenti il governatore rifiuti gli stereotipi sugli arabi («ciarpami della più vìeta e superata letteratura esotica») e arrivi a definirli «italiani mussulmani», nel concreto il suo archivio rivela come gli indigeni restino ai suoi occhi soggetti meno evoluti, ai quali destinare abitazioni e terre peggiori [Segrè 2000] e a cui concedere la cittadinanza solo allo scopo di accelerare il processo di annessione della Libia [Deplano, Pes 2024]. Questo, per quanto ne ridimensioni l’importanza ideologica, non implica comunque che Balbo non fosse veramente intenzionato a compiere tale passo anche solo per poter vantare d’essere stato il primo governatore coloniale a fare una simile concessione agli autoctoni. Il tema, infatti, rappresenta un unicum giuridico non solo per il colonialismo europeo degli anni Trenta, ma anche per quello del Dopoguerra; si pensi a come l’impero francese, ancora durante la presidenza di De Gaulle, interpreterà la questione non come l’estensione di un diritto ma in quanto premio da concedere a quanti dimostratisi capaci di farsi assimilare dalla civilisation française [Cooper 2010]. Il ferrarese è perfettamente consapevole della novità e così il regime che infatti non lo autorizzò a procedere, costringendolo ad accontentarsi di una “piccola cittadinanza” [Younis 2022] di difficile ottenimento e fatta di concessioni tanto scarse [4] da risultare uno strumento utile soltanto a ribadire le gerarchie coloniali piuttosto che ad aprire le porte alla naturalizzazione degli arabi [Renucci 2005]. Niente di tutto questo sembra aver impedito a Balbo di essere fiero del proprio, pur scarso, risultato e infatti nella sua raccolta troviamo una serie di 13 fotografie in vario formato scattate nel 1939 (la data precisa non è riportata) e raffiguranti una cerimonia di consegna degli attestati di cittadinanza [5]. Dietro il palco impera un enorme ritratto di Benito Mussolini ma dagli scatti è evidente come il vero protagonista dell’evento sia Balbo, personalmente impegnato a porgere i documenti; ancora più interessante, però, è l’ostentazione estetica dell’evento come incontro dell’Italia fascista e del mondo arabo, per cui i libici vestono in abiti tradizionali – portando inoltre il jard, un mantello utilizzato nelle grandi occasioni – circondati da un miscuglio di tappezzerie locali, tricolori italiani, militari in divisa e gonfaloni delle corporazioni, a ricordare il sogno dell’Eurafrica ma soprattutto la sua natura inevitabilmente unidirezionale.
4. Immaginarsi eroi
Malgrado si sognasse alla guida della conquista dell’Egitto, Balbo non ebbe mai la possibilità di dedicarsi veramente alla guerra, morendo ad appena 18 giorni dall’entrata dell’Italia nel secondo conflitto mondiale, e questo lo costrinse a dirigere altrove i propri sforzi nel dare prova di coraggio e virilità. Per quanto il periodo interbellico non possa certo essere considerata un’epoca di pace, è indubbio che l’esilio libico abbia quantomeno frustrato le ambizioni del quadrumviro, tenendolo lontano da tutti i contesti operativi reali – un fatto inaccettabile per un uomo che si percepiva come naturalmente destinato all’azione. Così come la crescente popolarità delle arti marziali miste è stata interpretata come uno sfogo della violenza in un periodo di mascheramento della stessa anche a livello militare [Dal Lago 2016], allo stesso modo si può interpretare l’ossessione che Balbo matura e coltiva per i racconti e le esperienze di carattere avventuroso. La passione per le imprese di questo tipo era già da tempo parte del suo personaggio pubblico – si pensi alla trasvolata dell’Atlantico, onnipresente nell’archivio fra libri sul tema, ritagli di giornale, raccolte di foto [6] e francobolli commemorativi – ma in questi anni in particolare il quadrumviro sembra concedere ancora più spazio, come testimoniano i numerosissimi libri sul tema di cui si circonda. Sono infatti proprio titoli come Dalla Persia all’India attraverso il Seistan e il Belucistan, Un prince Saharien Méconnu, Da Tunisi alla Jung-Frau o Espolorazioni nell’America equatoriale (oltre a classici della narrativa come I misteri della jungla nera di Salgari) a essere i più visibilmente consumati della biblioteca, raccontandoci un Balbo quasi infantile nella sua lettura apparentemente instancabile di resoconti di esplorazioni in giro per il mondo. L’idea del mondo extra-europeo come spazio da scoprire utile a soddisfare la sete di conoscenza e di avventura dell’uomo bianco, dopotutto, è tipicamente coloniale, tanto che i ruoli di esploratore e di colonizzatore si sono frequentemente confusi fin dalla prima età moderna [Davies 2012], e non stupisce quindi che Balbo ci si identifichi a pieno già da prima di diventare governatore della Libia. A conferma di ciò, nel suo archivio è conservato un grosso album fotografico di ben 50 foto che documentano il viaggio aereo compiuto nel giugno del 1931 nel sud della Libia, seguendo quasi manualisticamente i canoni estetici del genere: le foto dall’alto del deserto e delle montagne, la rappresentazione orientalistica degli indigeni (intenti a compiere fantasie equestri come a raccogliere l’acqua al pozzo), i campi base organizzati ai piedi dei velivoli e l’abbigliamento di Balbo, in tenuta da esploratore anche una volta accolto a Tripoli dall’allora governatore Badoglio, sono lì a dimostrarlo. Il quadrumviro non si limita a cercare il brivido per sé stesso, ci tiene anche a mostrare il proprio rispetto verso quanti condividono con lui tale passione; nel 1935 scrive a Giorgio Parodi, vincitore del raduno aereo sahariano, per congratularsi del suo successo [7], mentre risale al gennaio del 1940 una lettera «al caro Mataloni, compagno indimenticabile d’indimenticabili scorrerie nell’Hammada» [8]. Più in generale appare evidente che Balbo ami essere in compagnia nel corso delle sue piccole imprese, specialmente nelle battute di caccia, lo sfogo più violento della sua ricerca dell’azione. Lo scrittore Leo Longanesi, suo amico, ha raccontato di essere stato coinvolto in una sanguinosa caccia ai gabbiani nel porto di Tripoli [Segrè 2000] e in una serie di fotografie raccolte in una busta anonima è rappresentato un soggiorno in Eritrea in cui il governatore e un gruppo di tedeschi si dedicano alla mattanza di scimmie, giraffe ed elefanti. È evidente come anche in questo caso occorra fare riferimento alla categoria dell’orientalismo, per cui lo stesso spazio naturale africano è ridotto ad un oggetto di divertimento ad uso e consumo degli europei esattamente come le società sommesse. I due elementi, antropico e naturalistico, si confondono nella categoria di “selvaggio”, semplice e tutto sommato indistinguibile dalla bestia, per cui non è un caso se nella stessa successione di immagini vi si trovano anche vari scatti degli ospiti di Balbo in compagnia di donne africane a seno nudo, un classico dell’iconografia coloniale [Levine 2013].
Occorre a questo punto evidenziare che, malgrado si proponga di fare altrimenti, la prassi coloniale non può permettere che nel corso della propria opera di “civilizzazione” dei barbari questi vengano completamente spogliati della loro “diversità” per continuare a legittimarsi. Il colonialismo, infatti, è possibile proprio nel momento in cui si squalifica l’altro dal novero del genere umano [Losurdo 2013], mascherando appena questo fatto con la creazione, dettata da esigenze pragmatiche, di piccole élites a cui attribuire incarichi di governo minori – un esperimento tentato anche nella Libia di Balbo [Rochat 1986]. È proprio in questo spazio di (immaginaria o forzata) arretratezza che si crea la fascinazione per l’elemento esotico che accomuna il fascista ferrarese agli esploratori che tanto ammira ma anche alla società del tempo, che condivideva il gusto per i racconti di avventura ma non necessariamente aveva interesse a correre gli stessi rischi dei propri beniamini, accontentandosi di affidarsi alla nascente industria del turismo. Insomma, se per Balbo le esplorazioni sono un surrogato della guerra, per gli altri le vacanze sostituiscono le imprese avventurose; creduto privo di materie prime e scarsamente profittevole sul piano agricolo, è in particolare al settore turistico che il governatore ritiene opportuno destinare la colonia [Guerri 1984], con risultati ambivalenti.
Sebbene la Libia non diventerà mai una meta tra le più popolari dell’Africa settentrionale, bisogna riconoscere che l’operato di Balbo, tra la costruzione di strutture dedicate e la continua organizzazione di eventi che attirino i visitatori [Younis 2022], rappresenta comunque un discreto successo e come tale è riconosciuto dalla stampa dell’epoca. Nell’archivio di Ferrara troviamo varie attestazioni in proposito, come il resoconto di viaggio La Tripolitanie vue par un français dell’esploratore René Pottier, il ritaglio di un giornale francese in cui si racconta la visita della giornalista britannica Grace Drummond-Hay [9] o l’edizione dell’ottobre 1936 di «Le vie d’Italia e del mondo», la rivista del Touring Club Italiano, che dedicava ampio spazio all’attenzione del governatorato per la ricerca archeologica per provare il carattere mediterraneo della civiltà libica. In questo senso, Balbo risponde ad una doppia esigenza, ovvero provvedere a fornire alla sua colonia un’ulteriore attrattiva per i turisti ma anche perseguire nella narrazione propagandistica fondata sul mito di Roma [De Plano, Pes 2024] cruciale nella politica coloniale fascista per dare un precedente storico alla missione civilizzatrice dell’Italia nei confronti del resto del mondo [Arthurs 2013]. Pur tanto importante, però, l’antichità resta per l’appunto un mito e quindi un soggetto liberamente manipolabile e privo di effettiva consistenza storiografica [Jesi 2011] come evidente intanto nell’individuazione di una continuità fra la civiltà romana e l’Italia del XX secolo e quindi in ragione della scarsissima presenza della cultura classica nell’archivio di Balbo, riducibile a qualche libro di letteratura latina e ad un album di fotografie raffiguranti il sito archeologico di Ghirza, nella Tripolitania orientale [10]. Dopotutto, i suoi modelli non possono che essere moderni perché a quel mondo lui appartiene e solo lì può continuare a dimostrare il proprio valore di avventuriero e di colono: nell’immaginario del regime e anche in quello balbiano «la dominazione romana fu dunque una forma di collaborazione eurafricana e fu la prima» [D’Agostino Orsini Di Camerota 1934, 240] ma quello che conta davvero sono i risultati ottenuti dalla seconda opera di “civilizzazione”, d’impronta coloniale e fascista. In questo senso, nei libri della biblioteca di Balbo leggiamo che «il compito che l’Italia ha svolto nella Libia è dei più grandi per il destino stesso della civiltà» [Ambrosini 1937, 24] o ancora che «non è nemmeno un impero questo stendere la mano a chi è fuori della civiltà» [Benelli 1936, 226]; decisamente meno retorici sono invece i toni della rivista svizzera «Föhn», in cui il resoconto dalla Libia della giornalista tedesca Paola Stuck è intitolato «Saison in Tripoli. Die modernisierte Wüste» [11] – un’immagine comunque coerente con l’intenzione del governatore e del regime di far incontrare una stereotipata tradizione nord-africana con il modello italiano di modernità [McLaren 2018]. L’idea di fondo, in ogni caso, è sempre quella: non solo il colonialismo può essere benefico ma quello italiano si è particolarmente rivelato tale, cancellando qualunque ricordo degli abusi contro la popolazione autoctona. Insomma, impedito allo scontro Balbo si reinventa eroe nei panni ora dell’esploratore, ora del colonizzatore modello, due figure che suggeriscono tutto meno una scarsa simpatia per la propria posizione di governatore.
5. La Quarta sponda degli italiani
L’idea di portare la civiltà ai popoli coloniali e di inserirli finalmente in una modernità predeterminata, come si è detto, era il primo fattore di legittimazione del colonialismo, tanto in Italia quanto nella cultura politica degli altri paesi europei. Eppure, malgrado la lamentata importanza del “fardello dell’uomo bianco”, non era assolutamente scontato che i dominatori si impegnassero concretamente nello sviluppo economico – e, anzi, era frequente che operassero in senso contrario [Chatterje 1993]. I soli casi in cui le risorse della metropoli venivano effettivamente impiegate per elevare il contesto coloniale agli standard produttivi e riproduttivi della metropoli erano le colonie di popolamento, vale a dire quegli spazi destinati all’insediamento in massa di popolazione europea quali l’Algeria, l’Australia o il Sudafrica. La Libia non era certamente fra queste, dal momento che nel 1934 la presenza italiana si attestava ad appena 50 mila persone [Guerri 1984], meno di quante non ce ne fossero nel Protettorato francese in Tunisia. Il caos dell’insurrezione senussa e la diffusa convinzione che la colonia non fosse che uno “scatolone di sabbia” [12] avevano reso quantomeno poco attrattiva la migrazione in Nordafrica e questo rappresentava un enorme problema per il regime, costretto a far convivere i proclama sulla rinascita dell’Italia al proseguire dei movimenti migratori verso l’estero. Davanti a questa realtà, il fascismo operò seguendo due direttrici: l’ininterrotta prosecuzione dei rapporti con gli emigranti, anche a fini propagandistici [Pinna 2017], e il tentativo di contenere gli spostamenti – in entrambe le quali Balbo è particolarmente impegnato. Forse anche in ragione della popolarità conseguita negli Stati Uniti – e in particolare fra gli italoamericani – dopo la crociera atlantica del 1933, il quadrumviro sembra aver preso particolarmente a cuore la situazione degli emigrati e si informa sulle loro vicende con una certa assiduità: nell’archivio di Ferrara sono quindi raccolti giornali pubblicati dalle comunità italiane in tutto il mondo dall’Uruguay all’Australia, dagli Stati Uniti alla Tunisia. Proprio quest’ultima è oggetto speciale del suo interesse, come suggeriscono intanto le numerose copie conservate de «L’Italiano» [13] (il più presente nell’archivio fra gli organi di informazione della diaspora, con l’eccezione del parigino «Giustizia e libertà»), ma anche la presenza nella biblioteca di libri come Per gli italiani della Tunisia, La Tunisia e gl’italiani, Lo statuto degli italiani in Tunisia e Noi e Tunisi, tutti accomunati da una retorica anti-francese particolarmente aggressiva: in un passaggio, le politiche di naturalizzazione della popolazione non francese vengono definite come la soppressione delle «vestigia della civiltà altrui, che abolisca le altre nazionalità», un «programma brutale, innaturale di sopraffazione» che viene perfino paragonato ad un sacrificio «nell’alvo di un altro Moloch» [Benedetti 1934]. In questo Balbo non è un’eccezione – il territorio nordafricano era una questione ancora aperta per i fautori dell’espansione coloniale italiana, essendo stato percepito come un furto ai danni del regno – e infatti il suo rapporto con la comunità emigrata di Tunisi è ben antecedente al governatorato della Libia. Ne sono una prova due foto del 1926 di una classe della Regia scuola italiana Giovanni Meli di Tunisi (con dedica al quadrumviro, «esempio di passione e precursore della rinascita») [14] e una raccolta di congratulazioni firmate da cittadini italo-tunisini fattagli pervenire nel 1929 per complimentarsi della nomina a ministro dell’aviazione, lunga ben 17 pagine e alla quale si uniscono le categorie sociali più varie – fra cui educatori, sportivi, affiliati della Camera di commercio, architetti e mutilati di guerra [15].
È avendo in mente tutto questo che va interpretato l’avviamento nel 1938 delle migrazioni di massa di famiglie contadine italiane verso la Libia, «la logica conclusione della politica di colonizzazione di Balbo» [Segré 2000, 377] in quello che è stato l’unico tentativo italiano di avviare un colonialismo di insediamento, la cui messa in atto avrebbe permesso di non implementare alcuna riforma volta a contenere i movimenti emigratori verso l’estero [Ertola 2022] e di cui infatti si posero le basi anche in Etiopia [Ertola 2019]. Il progetto è senza dubbio il più ambizioso dell’intera carriera da governatore di Balbo, prevedendo la selezione dei coloni in patria, il loro trasporto oltremare, la costruzione di infrastrutture per la loro accoglienza e la divisione delle terre da assegnare. Il progetto non nasce nel vuoto, tanto che nella sua biblioteca si trovano i due testi Popolare la Libia e Libia colonizzata…Libia pacificata, rispettivamente del 1929 e del 1933 e a firma di Vittore Pisani, in cui si spiega perché e come l’Italia dovrebbe avviare un processo di questo tipo nella colonia. L’argomento è comunque trattato con toni pragmatici, per cui l’autore non si fa scrupoli a criticare la tendenza dei coloni europei a considerare gli indigeni come «il nemico di ieri, o di anni sono, [nonché] di razza inferiore» [Pisani 1929, 137] o ad affermare la limitatezza di risorse della colonia, tale per cui non la si può gestire come «una torta che possa essere distribuita ai connazionali a fette» [Pisani 1933], considerazioni di notevole lucidità, se si considera la piena adesione al colonialismo dell’autore, e che verosimilmente hanno contribuito alla relativa moderazione del ferrarese nell’organizzazione delle migrazioni di massa. I piani di Balbo, infatti, prevedono che dopo la partenza dei primi 20 mila coloni i successivi gruppi siano di dimensioni più ridotte e oltre ai villaggi colonici è programmata anche la costruzione di insediamenti per i soli libici – per quanto meno attrezzati e con accesso a terre meno fertili. Questo, naturalmente, non bastò a limitare le preoccupazioni: il colonialismo di insediamento, dopotutto, è una forma di potere ancora più pervasiva di quello tradizionale, che prevede una presenza fisica visibile dell’oppressore creando forme ancora più violente di marginalizzazione sociale dei nativi (come l’apartheid) e che rende più difficile anche il processo di liberazione, per cui non sorprende che l’evento suscitò diffuse proteste in tutto il mondo arabo che sentiva ulteriormente minacciata la propria continuità culturale in Africa settentrionale [Rochat 1984].
La sottovalutazione di questo fatto da parte del ferrarese, dopotutto, non desta particolare sorpresa, ricordando lo scarso approfondimento della cultura libica che sembrano testimoniare la scarsità in biblioteca e l’evidente rara attenzione di testi informativi in proposito come una lunga relazione su storia, geografia e economia libiche fin dall’epoca della conquista ottomana [16], praticamente intonsa. Malgrado ciò, per Balbo la “migrazione dei ventimila” resta un trionfo politico e di pubblico che viene ripetutamente ricordato come tale all’interno dell’archivio, in varie raccolte fotografiche ed in numerosissime lettere. Particolarmente vistoso è l’album Prima migrazione di masse per la colonizzazione demografica della Libia [17], prodotto dall’Istituto Luce e aperto da un collage di propaganda in cui la sagoma di Mussolini si affianca ad una mappa della colonia, a sua volta riempita di immagini delle famiglie in partenza accanto ad alcune delle navi impiegate nella missione; seguono immagini di quella che sembra essere una grande festa collettiva, tanto in Italia quanto in Libia, e in cui Balbo è presente dapprima marginalmente, per poi diventare sempre più centrale una volta che il focus delle foto si sposta sui villaggi colonici appena occupati. A questa produzione ben curata, si affiancano poi due serie di foto senza album (probabilmente escluse dal primo), dedicate l’una esclusivamente al viaggio in nave – e in particolare ai bambini che vi hanno preso parte – e l’altra alle visite del governatore nelle case dei nuovi arrivati. Oltre a questo, come detto, Balbo ha conservato anche molte lettere, sia quelle scritte da lui per ringraziare quanti hanno contribuito alla migrazione (spesso accompagnate da una foto autografata), sia le risposte ricevute. In particolare, si segnala la corrispondenza con i capomanipolo della milizia incaricati nella selezione dei coloni e quella con i militari coinvolti nella logistica dell’operazione: sono in particolare i primi a sembrare davvero interessati alla colonizzazione della Libia, definita ad esempio una «grandiosa migrazione di coloni da Voi voluta ed attuata», mentre gli appartenenti delle forze armate si limitano a celebrazioni di carattere più cameratesco, come se l’obiettivo in sé fosse stato un fatto secondario. È l’apoteosi della personalizzazione dello spazio coloniale, un territorio che resta per Balbo tutto sommato estraneo e che sembra esistere solo per il suo interesse politico ed alimentarne l’immagine pubblica. La Libia non è mai stata per Balbo niente di più che un foglio bianco su cui proiettare la propria regalità [Guerri 1984] e così è anche nel momento in cui avvia quello che si propone esserne lo stravolgimento demografico definitivo.
6. Un colono modello
Combattente, esploratore, guida dei popoli: Balbo si vuole allo stesso tempo in tutti questi panni e in ognuno si vede come personaggio di successo, amato e ammirato proprio in ragione delle sue dimostrazioni in ogni veste che questi fa propria esattamente allo scopo di perpetuare la leggenda di sé stesso. Il materiale conservato nell’archivio donato all’Istituto di storia contemporanea non fa che confermare come ogni scelta di politica coloniale fatta dal quadrumviro sia destinata precisamente a questo scopo: l’eventuale guerra di espansione deve essere la guerra di Balbo, le imprese nel deserto vanno ricordate come le imprese di Balbo e anche il popolamento della Libia, un’operazione che ha richiesto il coinvolgimento di migliaia di persone, non è alla fine dei conti che un suo progetto. Se è senz’altro normale che il produttore di un archivio privato appaia di frequente all’interno dello stesso, il gerarca ferrarese raggiunge in questo livelli quasi propagandistici di riproduzione della propria figura: ogni album fotografico, ogni lettera, ogni documento vedono l’assoluta centralità di Balbo che viene prima di Mussolini, prima di Vittorio Emanuele III e prima anche della Libia nella sua interezza. In questo senso, il quadrumviro compie un’operazione particolarmente affascinante tale per cui se già di base il colonialismo implica la reificazione dell’altro, piegato agli interessi politici ed economici della metropoli, qui è l’intero apparato coloniale che viene a sua volta ridefinito simbolicamente come strumento per l’auto-affermazione del governatore. Nella storia sono stati tanti i governatori coloniali che hanno indissolubilmente legato la propria esistenza ai territori da loro amministrati e che vi hanno lasciato una forte impronta personale – si pensi a Cecil Rhodes nella Colonia del Capo o a Hubert Lyautey in Marocco - ma nessuno è mai stato così profondamente autoriferito nel proprio intero operato coloniale come ha fatto Italo Balbo, che si conferma essere non solo un soggetto capace di fare propri tutti gli archetipi del colonialismo europeo, ma più in generale l’apoteosi stessa di questa modalità politica. Per quanto il suo operato non abbia mai neanche sfiorato i livelli di violenza e brutalità che sono la principale cifra storica dell’esperienza coloniale italiana e a cui hanno fatto affidamento suoi connazionali come i già citati Rodolfo Graziani e Pietro Badoglio o ancora Cesare Maria De Vecchi – un altro quadrumviro esiliato che aveva brutalmente sfogato sulla popolazione somala la frustrazione per la propria condizione [Meynier 2008] – non si può comunque affermare che l’amministrazione del ferrarese non sia stata altrettanto autoritaria, personalista e priva di qualunque interesse per la comprensione degli individui colonizzati. Il presente lavoro è stato aperto con l’intenzione di comprendere in che modo il contesto coloniale abbia forgiato l’immaginario di Balbo ma alla fine si è avuto modo di cogliere soltanto il contrario: il gerarca resta tutto sommato uguale a sé stesso ed è il resto del mondo che deve adattarsi ai suoi desideri e alle sue ambizioni. A tale scopo non c’è meccanismo politico o giuridico che non rientri in questa logica, dalla pianificazione bellica alla colonizzazione demografica passando per la definizione della cittadinanza. L’uomo nuovo, quale si percepiva Balbo, ha il diritto di plasmare il reale a propria immagine e somiglianza e in tal modo finisce paradossalmente per mostrarsi come una figura vecchia e ancora legatissima all’ideologia coloniale, di cui mantiene tutti i tratti fondamentali portandoli all’estremo. Si è scritto che l’analisi della parabola politica di Balbo, tanto esuberante e ricca, possa permettere di comprendere il fascismo «forse ancor più [che non quella] dello stesso Mussolini» [Baravelli 2021, 12], una considerazione che diventa ancora più vera in materia di storia coloniale: come si è visto, nell’analisi del materiale documentario è stato sufficiente fare appello alle categorie più tipiche dello studio del colonialismo, poiché esattamente a queste rispondeva il ferrarese senza distinguersi troppo dai propri omologhi nel resto del mondo colonizzato. L’umanità, la natura, lo spazio geografico e le culture sottomesse non erano agli occhi dei governi coloniali che risorse o ostacoli ai propri obiettivi politici che nel caso di Balbo diventano addirittura – e quasi esclusivamente – quelli personali, in una perversione personalistica del proprio ruolo tanto limpida che la si è potuta agevolmente classificare nelle pagine di questo articolo. Dopotutto, il gerarca accettò la propria condizione proprio perché fin da subito capì di poter trasformare la colonia in un proprio riflesso, ideale e materiale, e proprio in questo modo ha operato per tutto il periodo al governatorato della Libia. L’archivio rivela tutto questo al ricercatore in modo particolarmente chiaro, riconfermando così il proprio potenziale ruolo di apripista a nuove prospettive nello studio della figura di Balbo. Probabilmente, il materiale disponibile non è sufficiente per tracciare un ritratto completo del gerarca ma è possibile farne un uso più limitato e contestuale che implichi l’analisi di aspetti più specifici della sua vita e della sua carriera politica. Anche a questo scopo si è deciso di non produrre un articolo di carattere strettamente biografico, optando piuttosto per l’intersecazione di questo genere con i metodi e le categorie della storia coloniale nella quale, in definitiva, Balbo si inserisce a pieno titolo come uno dei maggiori promotori della visione intrinsecamente suprematista di cui tale sistema si nutriva e a cui faceva affidamento come mezzo di autolegittimazione sociale e culturale.
Bibliografia
- Ambrosini 1937
Gaspare Ambrosini, I problemi del Mediterraneo, Roma, Istituto Nazionale di Cultura Fascista, 1937. - Arthurs 2013
Joshua Arthurs, Excavating Modernity: The Roman Past in Fascist Italy, Ithaca, Cornell University Press, 2013. - Balbo 1939
Italo Balbo, La colonizzazione in Libia, Regio Istituto Agronomico per l’Africa Italiana, 1939 . - Balbo 1940
Italo Balbo, La politica sociale fascista verso gli arabi della Libia, estratto dall’VIII Convegno, tema: L’Africa, Roma, 4 - 11 Ottobre 1938, Roma, Reale Accademia d’Italia, 1940. - Baravelli 2021
Andrea Baravelli, Così è (se vi pare), in Il fascismo in persona, a cura di Andrea Baravelli, Sesto San Giovanni, Mimesis, 2021, pp. 9-22. - Benadusi 2014
Lorenzo Benadusi, Storia del fascismo e questioni di genere, in «Studi storici», 1 (2014), pp. 183-196. - Benedetti 1934
Achille Benedetti, Per gli italiani della Tunisia, Roma, Nuova Europa, 1934. - Benelli 1936
Sem Benelli, Io in Affrica, Milano, Mondadori, 1936 - Buettner 2016
Elizabeth Buettner, Europe after Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 2016. - Chakrabarty 2008
Dipesh Chakrabarty, Provincialising Europe, Princeton, Princeton University Press, 2008. - Chatterje 1993
Partha Chatterje, The nation and its fragments, Princeton, Princeton University Press, 1993. - Cooper 2010
Frederick Cooper, Le colonialisme en question, Paris, Payot, 2010 (ed. or. 2005). - Cresti, Cricco 2015
Federico Cresti, Massimiliano Cricco, Storia della Libia contemporanea, Roma, Carocci, 2015. - D’Agostino Orsini Di Camerota 1934
Paolo D’Agostino Orsini Di Camerota, Eurafrica, Roma, Cremonese, 1934. - Davies II 2012
Edward J. Davies II, The Americas, 1450-2000, in The Oxford Handbook of World History, a cura di Jerry H. Bentley, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 508-528. - Del Boca 2003
Angelo Del Boca, The Myths, Suppressions, Denials, and Defaults of Italian Colonialism, in A Place in the Sun, a cura di Patrizia Palumbo, Los Angeles, University of California Press, 2003, pp. 17-36. - Del Boca 2005
Angelo Del Boca, Italiani, brava gente?, Milano, Neri Pozza, 2005. - Del Lago 2016
Alessandro Dal Lago, Il senso della brutalità, in «Etnografia e Ricerca Qualitativa», 3 (2016), pp. 427-450. - Deplani, Pes 2024
Valeria Deplano, Alessandro Pes, Storia del colonialismo italiano, Roma, Carocci, 2024. - Ertola 2019
Emanuele Ertola, In terra d’Africa, Roma, Laterza, 2019. - Ertola 2022
Emanuele Ertola, Il colonialismo degli italiani, Roma, Carocci, 2022. - Fabre 2023
Giorgio Fabre, Il Gran Consiglio contro gli ebrei, Bologna, Il Mulino, 2023. - Gentile 2008
Emilio Gentile, L’apocalisse della modernità, Milano, Mondadori, 2008. - Bruno Guerri 1984
Giordano Bruno Guerri, Italo Balbo, Milano, Vallardi, 1984. - Jesi 2011
Furio Jesi, Cultura di destra, Milano, Nottetempo, 2011. - Labanca 2002
Nicola Labanca, Oltremare, Bologna, Il Mulino, 2002. - Lee 1997
Martin A. Lee, The Beast Reawakens, New York, Little Brown and Company, 1997. - Levine 2013
Philippa Levine, Naked Thruts: Bodies, Knowledge, and the Erotics of Colonial Power, in «Journal of British Studies», 52 (2013), pp. 5-25. - Losurdo 2013
Domenico Losurdo, La lotta di classe, Roma, Laterza, 2013. - McLaren 2018
Brian McLaren, Architecture and Tourism in Italian Colonial Libya, Seattle, University of Washington Press, 2018. - Palumbo 2003
Patrizia Palumbo, Italian Colonial Cultures, in A Place in the Sun, a cura di Patrizia Palumbo, Los Angeles, University of California Press, 2003, pp. 1-14. - Parker 2020
Charles H. Parker, Identities and encounters, in Interpreting Early Modern Europe, a cura di C. Scott Dixon, Beat Kümin, New York, Routledge, 2020, pp. 49-71. - Pinna 2017
Pietro Pinna, La fascistizzazione dei migranti italiani in Francia e Brasile: una comparazione, in «Storicamente», 13 (2017), pp. 1-31. - Pisani 1929
Vittore Pisani, Libia colonizzata… Libia pacificata, Roma, Cremonese editore, 1929. - Pisani 1933
Vittore Pisani, Popolare la Libia: perché e come, Roma, Cremonese editore, 1933 - Renucci 2005
Florence Renucci, La strumentalizzazione del concetto di cittadinanza in Libia negli anni Trenta, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 33-34 (2005), pp. 319-342. - Rochat 1986
Giorgio Rochat, Italo Balbo, Torino, UTET, 1986. - Said 2013
Edward W. Said, Orientalismo, Milano, Feltrinelli, 2013 (ed. or. 1978). - Segrè 2000
Claudio G. Segrè, Italo Balbo: una vita fascista, Bologna, Il Mulino, 2000 (ed. or. 1987) . - Todorov 2014
Tzvetan Todorov, La conquista dell’America, Torino, Einaudi, 2014 (ed. or. 1982). - Tuninetti 1933
Dante Maria Tuninetti, La politica coloniale del regime, Roma, Pinciana, 1933. - Valacchi 2015
Federico Valacchi, Diventare archivisti, Milano, Editrice Bibliografica, 2015. - Volterra 2021
Alessandro Volterra, Maurizio Zinni, Il leone, il giudice e il capestro, Roma, Donzelli, 2021. - von Leers 1940
Johann von Leers, Elementi comuni nella storia Italiana e Germanica, Vienna, Anton Schroll & Co., 1940. - Younis 2022
Mustafa Rajab Younis, L’esilio dorato, Milano, FrancoAngeli, 2022.
Note
1. In particolare, si rimanda a Bruno Guerri 1984; Giorgio Rochat 1986; Segrè 2000.
2. Occorre specificare che questi non è il produttore unico dell’archivio, dal momento che una buona parte del materiale è piuttosto riconducibile all’opera del figlio Paolo, intenzionato a perpetuarne la memoria, in particolare raccogliendo riviste o quotidiani nei quali si parlava di Balbo con toni che vanno dal celebrativo allo scandalistico.
3. Curiosamente, il libro sembra essere arrivato a Balbo per mano dello stesso autore, Vincent Schettini, che gli lascia anche una dedica in italiano recitante: «Viva l’Italia! Viva la Repubblica italiana, che salverà il paese! Giù papato e monarchia!».
4. Si ritiene utile qui ricordare che, come sottolineato dal filosofo francese Étienne Balibar in un saggio del 2012, ancora oggi la concessione della cittadinanza non implica necessariamente un incremento della condizione sociale dei beneficiari, potendosi questa costituire come semplice “cittadinanza relativa” dalla valenza esclusivamente nominale. Lo studioso ha individuato il concetto guardando alle zone grigie della società neoliberale contemporanea ma è appropriato applicarlo anche ai timidi e maldestri esperimenti in contesto coloniale come quello di cui sopra.
5. Archivio Istituto di storia contemporanea di Ferrara (ISCOFE), Fondo Donazione famiglia Paolo Balbo (FFB), Cerimonia della consegna della cittadinanza italiana ai Libici, 1939.
6. ISCOFE, FFB, Album fotografico Crociera aerea del Decennale 1 luglio - 12 agosto 1933-X.
7. ISCOFE, FFB, Lettera a Giorgio Parodi, 2 giugno 1935, non catalogata.
8. ISCOFE, FFB, Lettera a Mataloni, 22 gennaio 1940, non catalogata.
9. ISCOFE, FFB, Doc II fasc. 11.4, Voyage avec Lady Drummond Hay, senza data.
10. ISCOFE, FFB, Album Vestigia di Roma in territorio Orfella – III-IV secolo d.C., senza data, non catalogato.
11. “Stagione a Tripoli. Il deserto modernizzato”.
12. L’espressione è dello storico e antifascista Gaetano Salvemini ma è usata in Italia anche negli anni del regime mussoliniano, tanto che se ne trova attestazione nello stesso archivio di Balbo. Nella fattispecie si cita il caso di Aquila Rivoluzionaria, una rappresentazione teatrale in tre parti del 1942 in cui un personaggio femminile si riferisce in questi termini alla colonia nordafricana. Le verrà risposto che oramai, al contrario, «al posto delle ampie distese desertiche, lungo le strade e presso i nuovi villaggi colonici, sorgono campi biondeggianti di cereali, ricchi di olive e di viti».
13. Giornale pubblicato dalla sezione di Tunisi della Lega italiana dei diritti dell’uomo, bandita dal fascismo.
14. ISCOFE, FFB, R. Scuola Italiana “Giovanni Meli” Tunisi, 21 aprile 1926, non catalogato.
15. ISCOFE, FFB, Gli italiani di Tunisi esaltarono riconoscenti il nome e la volontà del ministro Italo Balbo, 15 settembre 1929, non catalogato.
16. ISCOFE, FFB, Doc. I fasc. 11.4, Monografia sulla regione degli Orfella, ten.col. Guido Bauer, 1° agosto 1934.
17. ISCOFE, FFB, Prima migrazione di masse per la colonizzazione demografica della Libia, 28 ottobre – 8 novembre 1938.
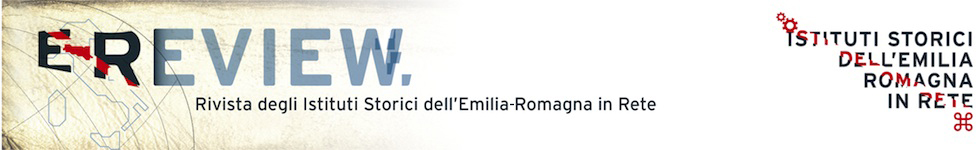
![Fig. 1. Italo Balbo in visita ad uno stabilimento della Fiat a Tripoli, 4 novembre 1939 [ISCOFE, FFB, serie di foto non catalogata].](./sites/default/images/articles/media/318/milizia_balbo_01.jpg)
![Fig. 2. Uno scatto dell’album dedicato alla visita di Vittorio Emanuele III in Libia, tra aprile e maggio 1938, [ISCOFE, FFB, serie di foto non catalogata].](./sites/default/images/articles/media/318/milizia_balbo_02.jpg)
![Fig. 3. Il bombardamento di un fortino di ribelli, verosimilmente da tanto tempo in disuso all’epoca dello scatto, 18 marzo 1937, [ISCOFE, FFB, serie di foto non catalogata].](./sites/default/images/articles/media/318/milizia_balbo_03.jpg)
![Fig. 5. Italo Balbo con un elefante ucciso durante un safari di caccia, [ISCOFE, FFB, serie di foto non catalogata].](./sites/default/images/articles/media/318/milizia_balbo_04.jpg)
![Fig. 4. Balbo consegna un attestato di cittadinanza speciale, 1939 [ISCOFE, FFB, serie di foto “Cerimonia della consegna italiana ai libici].](./sites/default/images/articles/media/318/milizia_balbo_05.jpg)
![Fig. 6. Balbo e la principessa di Piemonte Maria José del Belgio ad uno spettacolo notturno, tra il 29 aprile e il 9 maggio 1935, [ISCOFE, FFB, album “Viaggio in Libia delle LL.AA.RR. i principi di Piemonte”].](./sites/default/images/articles/media/318/milizia_balbo_06.jpg)
![Fig. 7. Balbo con il capo tuareg di Ghat, nel sud-ovest della Libia, tra il 15 e il 28 giugno 1931, [ISCOFE, FFB, album “Il volo al Tibesti”].](./sites/default/images/articles/media/318/milizia_balbo_07.jpg)
![Fig. 8. Balbo tiene un discorso nel centro di Tripoli per i coloni italiani appena sbarcati in Libia, 1938, [ISCOFE, FFB, album “Prima migrazione di masse per la colonizzazione demografica della Libia”].](./sites/default/images/articles/media/318/milizia_balbo_08.jpg)
![Fig. 9. Il collage d’apertura dell’album “Prima migrazione di masse per la colonizzazione demografica della Libia”, [ISCOFE, FFB].](./sites/default/images/articles/media/318/milizia_balbo_09.jpg)
![Fig. 10. Balbo saluta alcuni dei ventimila coloni arrivati in Libia nel 1938, [ISCOFE, FFB, album “Prima migrazione di masse per la colonizzazione demografica della Libia”].](./sites/default/images/articles/media/318/milizia_balbo_10.jpg)



