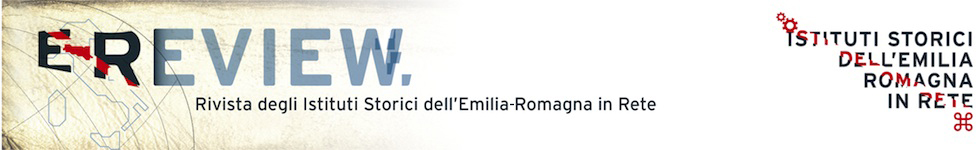Parlando di manuali di storia è bene ricordare che fino al 1960 i programmi ufficiali si arrestavano al 1918, al momento di unanimità costituito dalla vittoria nella “quarta guerra d’indipendenza” e dal completamento dell’unità nazionale. Per contro era recepita la convinzione o il timore che non fosse ancora opportuno occuparsi in maniera spassionata del periodo successivo e che, in sostanza, di fascismo era meglio non parlare. È un fatto isolato che un autore come Armando Saitta abbia aggiunto un capitolo finale sugli anni 1918-22, per concludere che la “Marcia su Roma” era un mito e che non c’era stata allora nessuna rivoluzione ma solo «un silenzioso colpo di stato della Corona» [Saitta1953].
Fatta questa premessa, nel modo di trattare il fascismo da parte dei testi scolastici – ci occupiamo qui solo di quelli destinati ai licei e alle altre scuole superiori – si fanno individuare quattro periodi sufficientemente distinti; è quanto verificheremo su un campione di una quindicina di opere uscite fra il 1960 e il 2014.
Lettura del fascismo come negazione della libertà
Il primo periodo è quello che occupa i primi anni Sessanta e che possiamo chiamare della lettura del fascismo come negatore della libertà. Ciò che prima del 1960 i programmi in vigore avevano prescritto di escludere dai temi adatti all’insegnamento (il fascismo, l’antifascismo, la resistenza), poteva e doveva invece entrare a far parte del comune sentire fondativo della Repubblica. Partendo da una visione dell’antifascismo che dopo il 1945 era apparsa come compatta o quasi, si poteva dire che la resistenza aveva riportato la libertà e la democrazia. Il fascismo era appunto il regime che era giunto al potere come nemico dell’una e dell’altra e che subito le aveva soppresse: è il giudizio che si ritrova anche in testi pubblicati (naturalmente con un tono ben diverso) già negli anni Trenta e poi debitamente aggiornati. Divenuto inevitabilmente alleato del nazismo, il regime aveva quindi provocato la grande tragedia della guerra mondiale. La storia del fascismo era tutta inscritta nel suo inizio, nel 1922 e poi nel 1924-25 con la ripresa delle violenze degli esordi. Giorgio Spini scriveva perciò [Spini 1961 – l’edizione precedente la riforma dei programmi risaliva al 1947] che dopo essersi accattivati gli industriali nel breve periodo “legalitario” il fascismo era tornato al suo volto autentico nelle elezioni del 1924, avvenute in un «clima di sanguinose intimidazioni coperte dall’appoggio della polizia».
Erano seguiti gli anni della dittatura segnati, diceva ancora Spini, da questi caratteri: la soppressione di ogni libertà di critica e discussione; la fine delle elezioni sostituire dalla pura designazione; «la rapacità e inettitudine» delle gerarchie fasciste; l’uso del terrore sistematico unito alla propaganda, con le «parate e cerimonie destinate a dare l’impressione di unanimità ed entusiasmo» ma in realtà manipolate dal partito e il controllo capillare su ogni aspetto della vita (non compare qui, contro quanto ci aspetteremmo, l’idea di “totalitarismo”, già usata dal fascismo stesso per autodefinirsi prima ancora di diventare una categoria politologica); il favore dato alle «tendenze parassitarie della grande industria» e alle «concentrazioni a carattere monopolistico; l’autarchia, il culto della romanità e la politica demografica, il tutto in vista della preparazione alle guerra; infine la subordinazione al nazismo, con l’adozione di «fogge naziste» e delle leggi razziali.
La visione del fascismo in termini di regime sempre identico a sé stesso, senza fasi interne e soggetto a un unico giudizio si ritrova anche in Saitta [Saitta1960]. Gli anni 1922-1943 sono compattamente quelli «foschi della dittatura fascista» che condusse subito a mettere fuori della legalità tutti i partiti e movimenti politici e a imbavagliare la stampa: una dittatura senza nessun programma reale, al di fuori della «libidine di potere». Non era stato Mussolini stesso a dichiarare che i fascisti non hanno dottrine precostituite e che l’azione doveva essere posta prima di ogni dottrina? Quanto alle manifestazioni di consenso al regime, si trattava solo di una «facciata di cartapesta». È certo esistita un’Italia fascista, ma accanto a questa vi era anche un’Italia apolitica – maggioritaria, si può suppore – e una nettamente antifascista.
Lettura classista
Definendo il secondo periodo attraversato dai manuali quello della lettura classista dell’epoca fascista, occorre tenere presente che già nel testo di Saitta del 1960 si parlava di una «controrivoluzione preventiva della grande borghesia». Gli agrari e gli industriali avevano finanziato il fascismo degli esordi ed erano stati ripagati facendosi consegnare «mani e piedi legata» la classe operaia e contadina. Fu però con il procedere degli anni Sessanta e nel decennio successivo che questa visione si impose sempre più nei manuali (insieme a un crescente prestigio del marxismo anche al di fuori dello schieramento comunista ufficiale). Un simile mutamento è certamente legato a una più diffusa nuova percezione della Resistenza, diversa da quella che era stata celebrata fino ad allora: non solo una lotta contro la tirannide fascista e per la libertà democratica ma, nella sua parte più attivamente schierata, un moto con un significativo contenuto sociale, l’avvio di una vera e propria rivoluzione (in seguito però “tradita” o almeno svalorizzata e incanalata sulla ben diversa via della semplice “ricostruzione”).
C’è una evidente coerenza fra questo aspetto e quanto gran parte della storiografia aveva peraltro sempre sostenuto: di fronte alla paura della rivoluzione, quella del 1919-20, la borghesia si era servita del fascismo per mantenere il suo potere. Il fatto nuovo è che questa convinzione si trasferì dalle opere degli storici ai manuali, in principio un po’ più cauti: e ciò in corrispondenza con l’attività di divulgazione nelle scuole condotta da storici e testimoni (un esempio precoce sono le lezioni su Fascismo e antifascismo 1962). Fra chi si impegnò in questa direzione va segnalato Guido Quazza, che intitolò “Fascismo e capitalismo” un paragrafo centrale del suo Corso di storia, affermando che il fascismo si era proclamato “regime di massa”, ma aveva semplicemente tutelato gli interessi e i profitti dei gruppi capitalistici [Quazza 1967].
Per un buon quindicennio questa è diventata la tesi prevalente. Così Rosario Villari argomentò che i gruppi del grande capitale (agrario, industriale e finanziario) avevano messo al loro servizio tanto il regime e il partito fascista quanto lo stato [Villari 1970]. L’intera politica fiscale ed economica del fascismo si era svolta secondo la sua essenza classista, dietro lo schermo ingannevole della collaborazione tra classi che doveva segnare il sistema corporativo. L’articolato giudizio di Franco Gaeta [Gaeta 1974; Gaeta e Villani 1967] è che uno stato autoritario aveva usato e giocato il fascismo dei primi anni, una forza che si proclamava “sovversiva”, contro le forze effettivamente rivoluzionarie; il corporativismo, che voleva rappresentare una terza via fra capitalismo e comunismo, era stato poi «uno strumento di dirigismo statale attuato all’insegna del profitto dei maggiori gruppi industriali», con molte vuote parole d’ordine anticapitalistiche e un «elefantiaco burocraticismo». La media e la piccola borghesia ebbero l’illusione di essere élite: in realtà furono messe al servizio degli interessi dei gruppi conservatori tradizionali.
Lettura post-defeliciana
Già però quest’ultima notazione suscita una domanda. Come si realizzò la partecipazione attiva della piccola borghesia alla vita e ai rituali del fascismo? Anche se concludiamo che era solo illusoria, questa partecipazione fu consistente quanto basta per non poter assimilare il fascismo al tipo dello stato autoritario e oppressivo che nelle situazioni di crisi riporta l’ordine imponendo su tutti un regime di terrore. Con ciò entriamo in una fase nuova, che possiamo chiamare sinteticamente quella della lettura post-defeliciana e che dalla fine degli anni Settanta obbligò per una paio di decenni i manuali se non proprio a convertirsi al “revisionismo” storiografico – non necessariamente un tentativo di “riabilitazione” – per le meno a fare i conti con i suoi assunti. La pubblicazione della grande opera biografica di Renzo De Felice era già cominciata nel 1965; fu dal 1974 che passò nel campo “uso pubblico della storia” con il volume Gli anni del consenso, seguito nel 1975 da Intervista sul fascismo [De Felice 1974; De Felice 1975]. Erano molte le questioni che si trovarono ad essere ridiscusse. Il fascismo fu solo al servizio della borghesia? Si può parlare di rivoluzione fascista? Il fascismo portò al potere una nuova classe, diversa da borghesia e proletariato? Aveva una sua ideologia, una sua cultura? Ebbe un suo sviluppo coerente? Riuscì a imporsi sui poteri concorrenti (la monarchia, la Chiesa)? L’elenco può farsi assai più lungo – ne discute Emilio Gentile nei saggi del 1974-1996 [Gentile 2002] – ma fu intorno alla parola “consenso” che negli Settanta e Ottanta si svolsero in tono più acceso le dispute storiche e giornalistiche.
Con tutto il sistema della propaganda e le sue organizzazioni di massa, il fascismo aveva prodotto solo una accettazione passiva del nuovo ordine: questa era la tesi accolta dai manuali. Giampiero Carocci invece, pur negando con buoni argomenti che vi fosse mai stata una rivoluzione fascista, prese le distanze da questa tesi [Carocci 1985]. Sotto il paragrafo “Il fascismo come regime di massa” esaminò «le grandi adunate di folla plaudente», con tutti i loro aspetti «tronfi e retorici» destinati oggi ad apparire ridicoli; ma sentì di dover aggiungere: «allora queste immagini suscitavano l’entusiasmo sincero di milioni di italiani». Anche Franco Della Peruta, assai poco propenso ad accettare la nuova vulgata defeliciana, parlò di regime reazionario di tipo nuovo con una «particolare abilità nell’utilizzare i mass media», vecchi e nuovi, ed esita di fronte all’opposizione fra consenso di facciata e consenso di massa [Della Peruta1991].
Per Giovanni Sabbatucci il fascismo è diverso dai vecchi sistemi assolutisti «perché non si accontentava di reprimere e controllare, ma pretendeva di inquadrare nelle proprie organizzazioni» [Sabatucci 1988]. Ed è diverso in particolare dai regimi autoritari privi di una base di massa che si imposero in Europa negli anni Venti, dal Portogallo alla Polonia. Bisogna distinguere fra un regime che abolisce le elezioni libere e i sindacati e instaura il partito unico e quello che aspira a penetrare nel privato e riesce a mobilitare la masse: il primo si basa sulla paura, la polizia e l’esercito, il secondo invita con successo a scendere nelle piazze e a farsi inquadrare in molteplici organizzazioni.
Mentre un testo come quello di Saitta intitolava il paragrafo centrale “L’organizzazione della dittatura”, un manuale di questo periodo si sarebbe chiesto anche come fu realizzata “L’organizzazione totalitaria del consenso”. Se la qualificazione corretta è allora quella di totalitarismo, si deve però ammettere – come pensa Sabbatucci – che quello fascista fu solo un «totalitarismo imperfetto», a mezza strada fra reazione dei ceti dominanti e tentativo di occupare lo stato e la società, e che dietro il preteso consenso attivo ci fu una buona dose di reale passività.
Al posto di categorie che si rivelano improprie o generiche, come tirannide, dittatura, o assolutismo occorre mettere non solo l’opera di coinvolgimento totalitario delle masse ma il progetto di «modernizzazione autoritaria della società», come fece Alberto De Bernardi dedicando inoltre un esame particolareggiato alle interpretazioni del fascismo, da Benedetto Croce a Renzo De Felice [De Bernardi 1993]. Questo richiamo alla “modernizzazione” è in fondo anche un invito a non fare del tema del consenso l’unico o il principale che deve attrarre le nostra attenzione. È vero che sono numerose e stridenti le contraddizioni del regime: l’industrializzazione con la connessa mobilità geografica in competizione con il ruralismo e l’avversione all’inurbamento; il mito dell’uomo nuovo e il tradizionalismo della politica della famiglia e della donna; il modernismo affermato insieme al culto della romanità. Per il nuovo indirizzo della discussione non c’è dubbio che fra i due poli sia il primo a qualificare più nettamente il fascismo.
Non significa farsi ingannare dalle parole d’ordine e dalla propaganda dell’epoca chiedersi, per esempio, se gli interessi della borghesia furono protetti in sé o in funzione di quelli dello stato fascista e del suo programma di politica economica. In altre parole, è esistita o no una dottrina economica propria del fascismo? In maniera emblematica nel 1974 Franco Gaeta aveva trovato molto dubbia la risposta positiva a questa domanda [Gaeta 1974]. L’interventismo statale nell’economia fu in realtà imposto dalla crisi piuttosto che essere attuato in conformità a una precisa dottrina. Di corporativismo si era cominciato in effetti a parlare – ma non più che a parlare – ben prima della grande crisi, mentre lo statalismo nell’economia divenne consistente solo dal 1931.
Anche per Sabbatucci trova scarsa conferma nella realtà l’idea di una «fascistizzazione dell’economia» capace di scalfire davvero le imprese capitalistiche. La nascita dello stato imprenditore e banchiere non si può però ricondurre a qualcosa dettato solo dalla contingenza. È ugualmente notevole che la direzione di questi centri strategici sia stata affidata a tecnici esponenti dell’alta borghesia e non a personale fascista in senso stretto, e che in questo settore il peso dello stato sia superiore a quello della gerarchia del partito. Come ha notato De Bernardi, quando il protezionismo (ovvero “l’autarchia”) e l’interventismo statale si aggiunsero al gran parlare di corporativismo come terza via, si ebbe allo stesso tempo il salvataggio del capitalismo e il «coronamento di tutta la politica economica fascista».
Lettura distaccata
Non appena si è trattato di tener conto della nuova storiografia, dopo il 1975, il tono tenuto dalla discussione nei manuali si è necessariamente allontanato dalle asserzioni, non false ma troppo semplici, sul fascismo liberticida e tirannico o sul regime fascista al solo servizio della borghesia. Ripetute per un paio di decenni, le interpretazioni che integravano o correggevano ampiamente quelle classiche e originarie hanno infine condotto a una quarte fase. Troviamo così una lettura distaccata che presenta la parabola del fascismo senza voler risolvere le sue contraddizioni, nei suoi miti e nella sua realtà, nelle sua ideologia più o meno illusoria. Diventano correnti anche affermazioni che, a partire dalla stessa scelta delle parole, negli anni Sessanta e Settanta sarebbero sembrate azzardate.
Roberto Vivarelli ha potuto sostenere, quanto al fascismo delle origini, che si trattò di una reazione alla «fragorosa campagna rivoluzionaria condotta dai socialisti in modo sconsiderato e gravemente offensivo dei sentimenti nazionali» [Vivarelli 1996]. Con ciò si spiega il vasto consenso fra i ceti medi e il successo ottenuto alle elezioni del 1924, non riconducibile al solo uso dell’intimidazione, come invece in maniera emblematica aveva a suo tempo asserito Spini: il listone formato da fascisti, nazionalisti e rassicuranti esponenti del vecchio ceto politico liberale ottenne il 65% dei voti, ben oltre il 25% previsto della “legge truffa” per accedere ai 2/3 dei seggi. Alberto M. Banti collega gli esordi del fascismo con il finanziamento degli industriali, ma aggiunge: accanto alle tecniche squadriste bisogna mettere «l’eredità nazional-patriottica», che condusse a presentarsi come «nazione contro l’anti-nazione» [Banti 2009]. L’appoggio padronale mirava essenzialmente a «rimettere al loro posto braccianti e operai»; se il fascismo non stava ovviamente dalla parte del proletariato, neppure si può dire però che si adattasse ad essere subordinato alla borghesia, dato che la polemica antiborghese è un elemento centrale della sua ideologia.
Vivarelli trova molto dubbia l’applicabilità della nozione di totalitarismo: il fascismo si contentò di un consenso passivo e formale, e non si allontanò dai valori tradizionali fatti di Dio, patria e famiglia. Il prototipo del fascista non era “l’uomo nuovo”, ma il conformista. Ciò non impedisce a un autore come Banti di notare come siano riusciti a convivere l’orientamento tradizionalista e antifemminista – donne a casa e tenute a procreare – e la mobilitazione anche femminile – donne presenti anche nello sport e in divisa nel coinvolgimento guerriero. Ugualmente, sul piano della politica economica, i manuali più recenti non trovano più necessario adottare una interpretazione univoca. Come fa Vivarelli, si può dare poco credito al programma corporativo, qualificato come una «costruzione cartacea» che si risolse in un grande apparato burocratico con scarsa incidenza sulla reale vita economica. Ma allo stesso tempo, come fa Banti, si può notare che «lo stato finì per controllare direttamente una quota di imprese superiore a quella di ogni altro stato ad eccezione dell’Unione Sovietica».
Si può dire che la vocazione che ha finito per affermarsi sia quella di una descrizione più minuta che in passato e lontana da qualsiasi schema che voglia essere troppo coerente. Alberto De Bernardi nota che di fatto l’autarchia e dipendenza dall’estero crebbero di pari passo e intitola un paragrafo alla “complessità dell’universo culturale fascista” [De Bernardi 2014]. Giovanni De Luna presta quasi maggiore attenzione alla società e alla vita quotidiana che alle strutture socio-economiche; considera necessaria un’analisi attenta e oggettiva degli strumenti della comunicazione di massa e della loro modernità, a cominciare dal cinema e dalla radio, e lascia che siano i fatti stessi a segnare il confine fra realtà e messa in scena [De Luna 2000].
Bibliografia
- Banti A. M. 2009
L’età contemporanea. Dalla Grande guerra ad oggi, Bari-Roma: Laterza - Carocci G. 1985
L’età contemporanea, Bologna: Zanichelli - De Bernardi A. 1993
Storia del mondo contemporaneo, Milano: Bruno Mondadori - De Bernardi A. 2014
La realtà del passato, vol. III, Milano: Bruno Mondadori - De Felice R. 1974
Gli anni del consenso, Torino: Einaudi - De Felice R. 1975
da Intervista sul fascismo, a cura di Michael Leeden, Bari: Laterza - De Luna G. 2000
Codice storia, vol. III, Torino: Paravia - Della Peruta F. 1991
Storia del novecento. Dalla Grande guerra ai giorni nostri, Firenze: Le Monnier - Fascismo e antifascismo. Lezioni e testimonianze 1962, Milano: Feltrinelli
- Gaeta F. 1974
Corso di storia, Milano: Principato - Gaeta F. e Villani P. 1967
Documenti e testimonianze, Milano: Principato - Gentile E. 2002
Fascismo. Storia e interpretazioni, Bari-Roma: Laterza - Quazza G. 1967
Corso di storia: per i licei e istituti magistrali, Torino: Petrini - Sabbatucci G. 1988
L’età contemporanea, Roma-Bari: Laterza - Saitta A. 1953
Il cammino umano, Firenze: La Nuova Italia - Spini G. 1961
Disegno storico della civiltà, Roma: Cremonese - Villari R. 1970
Storia contemporanea, Bari: Laterza - Vivarelli R. 1996
L’età contemporanea, Firenze: La Nuova Italia
Risorse online
- Video della relazione al convegno Narrare il fascismo (Predappio, 20-21 gennaio 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=U1uXLX1r-bo