1. Asciugare le acque, creare le terre
La Riforma agraria prese avvio in Italia sulla base della cosiddetta legge stralcio n. 841 del 21 ottobre 1950 [1]. Attesa da tempo, la riforma anelava a trasformare la struttura agraria del paese (all’epoca, precedentemente al Boom economico, ancora cuore economico del paese), passando da un quadro dominato dai latifondi o comunque dalla grande proprietà terriera e lavorato da affittuari o braccianti a una nuova realtà fatta di piccoli proprietari.
I comprensori della Riforma riguardarono principalmente il Mezzogiorno; l’area più settentrionale coinvolta nel programma, nonché l’unica padana, era rappresentata dal delta del Po, nei suoi settori sia veneto, sia emiliano-romagnolo. Ma se nel sud del paese la Riforma si sviluppò in massima parte secondo uno schema di esproprio dei terreni ai grandi proprietari e loro ridistribuzione ad assegnatari, a loro volta poi destinati a diventarne proprietari, la traiettoria seguita nel delta padano risultò assolutamente eccentrica nel panorama nazionale.
In quest’ultima area il problema era letteralmente la terra: il paesaggio deltizio era infatti dominato da vaste lagune dolci o salmastre (le “valli”), di proprietà pubblica, relitti delle configurazioni storiche del Po in zone subsidenti, mentre le terre emerse risultavano ben poca cosa per una popolazione residente in continuo aumento, sino ad allora impiegata principalmente nella pesca.
Nel delta del Po, e soprattutto nel suo settore ferrarese, la Riforma agraria operò quindi nella direzione di “creare” nuove terre, drenando le aree umide deltizie tramite imponenti macchine idrovore.
I lavori erano gestiti dall’Ente per la colonizzazione del delta padano (più comunemente citato come Ente delta padano, Edp), con sede a Bologna e giurisdizione sulle province di Venezia, Rovigo, Ferrara e Ravenna, istituito, con un’impressionante rapidità per gli standard italiani, a un solo anno di distanza rispetto alla legge stralcio (Dpr n. 69 del 7 febbraio 1951), della quale si proponeva come il “braccio operativo” locale [Dagradi 1979].
Le idrovore aspiravano e sollevavano le acque di alcuni metri, per poi reimmetterle in canali posti a quote più elevate, attraverso cui raggiungere il mare per forza di gravità; le draghe operavano un primo livellamento dei fondali fangosi in corso di drenaggio. Una volta asciugate le valli, i passaggi successivi vedevano la realizzazione di ulteriori livellamenti, della rete scolante, delle opere di urbanizzazione primaria, di correzione pedologica dei suoli neocreati (torbosi e spesso salati, in conseguenza della natura salmastra della maggioranza delle valli), e infine delle case rurali seriali, costruite per gli assegnatari [Piastra 2011a; Piastra 2013]. Dopo un periodo minimo di residenza e lavoro, gli assegnatari avrebbero potuto riscattare, a un prezzo simbolico e calmierato, le terre assegnate, divenendone quindi proprietari [Sciaudone 2025]. In alcuni casi si provvide alla fondazione di nuovi villaggi rurali, di dimensioni molto limitate [Pedrazzini 2003; Biolcati Rinaldi, Alberti 2011]. Sul piano sociale, furono vari i progetti-pilota allo scopo di favorire i fruitori della Riforma agraria, a partire dalla creazione di Cooperative di assistenza e servizi fra assegnatari (Casa) [Menzani 2019, 94-95].
Non si trattava in assoluto di un processo nuovo per il delta, che, tralasciando qui le più antiche bonifiche a scolo naturale e per colmata, aveva già conosciuto una prima fase tardo-ottocentesca di bonifiche meccaniche, connesse a imprenditori privati, e una seconda fase di drenaggi durante il periodo fascista, al cui interno si mescolavano finalità socio-economiche, ma anche politiche e propagandistiche. Ora però, a partire dagli anni Cinquanta del Novecento, il progresso tecnologico (idrovore più potenti e, in questa stagione, elettriche, draghe, bulldozer, ecc.) rese questi interventi enormemente più rapidi e imponenti: in circa un ventennio (1950-1970 circa) vennero asciugati, nel delta padano emiliano-romagnolo, oltre 25.000 ettari di valli, poi destinati all’agricoltura.
Simmetrico al gigantismo dell’opera fu il suo costo: il drenaggio della sola valle del Mezzano (la più ampia; circa 20.000 ettari) [Piastra 2011b] era stimato, negli anni Sessanta, in circa 36 miliardi di lire, assorbendo la massima parte del budget complessivo dedicato ai drenaggi (circa 41 miliardi di lire).
Si trattava di una cifra enorme: prendendo come anno di riferimento il 1960 per una sua attualizzazione, circa 570 milioni di euro odierni secondo i calcolatori automatici di inflazione storica [2]. Ma in quel periodo circolavano altre cifre sui costi reali della bonifica della valle del Mezzano (non sappiamo se realmente fondate o meno): lo scrittore Francesco Serantini (1889-1978) parlava di un costo di 3 milioni per ettaro qui bonificato [Piastra 2010a, 1069], da moltiplicare per i 20.000 ettari dell’estensione di questa valle, per un totale presunto di circa 60 miliardi di lire del tempo.
Il programma prevedeva originariamente una bonifica integrale dell’intero sistema vallivo comacchiese: il paesaggio anfibio del delta storico, fra acque e terre, avrebbe dovuto essere del tutto cancellato, lasciando spazio a un ex delta ora asciutto.
Tale progetto fu definitivamente accantonato dall’Edp nel 1965 [Piastra 2012, 162], risparmiando dunque dal drenaggio le valli salmastre di Fossa di Porto, Lido di Magnavacca, Campo e Fattibello, a ridosso dell’Adriatico. Tra le ragioni di questo cambio di rotta figuravano le opposizioni a un drenaggio completo, sia di matrice ambientalista (si stava asciugando la più estesa area umida italiana, nonché una delle maggiori d’Europa), sia economiche (i residenti volevano mantenere almeno una parte di aree umide, in cui continuare a pescare). Le finalità igienico-sanitarie delle bonifiche, in primis la lotta alla malaria, erano inoltre da tempo venute meno. Il dibattito su questo tema si spostò poi anche in Parlamento. Aldo Spallicci (1886-1973), deputato dell’Assemblea costituente e poi senatore della Repubblica italiana nelle prime due legislature (1948-1953; 1953-1958) per il Partito repubblicano, già nel 1957 (quindi con la Riforma ancora nella sua acme) rimarcò con forza, in un suo intervento al Senato, l’inopportunità di una bonifica integrale del delta padano emiliano-romagnolo, adducendo argomenti conservazionistici e socio-economici [Spallicci 1996, 549-551]:
EVITARE LA DISTRUZIONE DELLE VALLI
Il disegno di legge parla di esproprio graduale, quindi dà facoltà all’Ente Padano di proseguire a suo talento nell’opera di distruzione delle valli. E non sembra che ci si voglia attenere ad una tattica prudenziale. […] Non seguite gli esempi del regime fascista che, volendo bonificare la palude Pontina, abbatté tutto il Bosco Circeo e appoderò indiscriminatamente tutto il comprensorio immettendo coloni tanto nelle zone fertili come nelle sterili col desolante risultato di vedere abbandonata la terra da quei coloni che non trovavano nessuna possibilità di vita su terreni ingrati. E poi non creda il Governo di acquistare le valli di Comacchio, proprietà di quel Comune (nella dannata ipotesi di una bonifica totalitaria ed integrale) allo stesso prezzo con cui acquistò quelle di Moceniga e di Mea cioè a 120 mila [lire] all’ettaro. […]
FERMARSI ALLA BONIFICA DELLA VALLE DEL MEZZANO
Comprendiamo che non si potrà impedire oggi che i lavori iniziati per la bonifica della Valle del Mezzano, che ha una estensione di 17 mila ettari e per la quale si è già creato l’argine di Agosta, non siano portati a compimento. Si raccomanda di non andare oltre. E poi perché affidare a questo Ente padano [l’EDP] il compito dei prosciugamenti quando esistono i Consorzi di bonifica magnificamente attrezzati a questo scopo? Perché accentrare in questo Istituto tutto il governo dei terreni espropriati e non concederli alle Cooperative di lavoro che formano come dei compartimenti stagni e compensano i braccianti esclusi dalle assegnazioni? Perché, teniamolo ben presente, lo assegnatario di cinque o anche dieci ettari (a seconda dell’entità del nucleo famigliare) non chiamerà il bracciante per quei lavori campestri che vorrà ben compiere da solo. Necessità quindi di provvedere ad assegnare un’adeguata estensione di terra anche agli enti cooperativistici. […]
LA MISERIA NON PUÒ ATTENDERE
Cari colleghi, quelli di voi che appartennero alla precedente legislatura [la I legislatura repubblicana, 1948-1953] rammenteranno la viva commozione che si comunicò a tutti noi quando parve che giungesse sin qui l’eco dello stormo delle campane di Comacchio che salutavano la progettata bonifica integrale delle valli. Quelle campane parevano interpretare il grido di speranza di quelle popolazioni in un avvenire di migliori condizioni di vita. Pareva giunta d’un tratto l’ora della redenzione, della liberazione dalla miseria secolare e dagli stenti inenarrabili (Pensate che questa popolazione fu persino un tempo ormai lontano minacciata dalla lebbra). Non rimandiamo quell’ora di redenzione a venti o a trenta anni. La miseria non può attendere. Mettiamoci subito al lavoro dando a Comacchio quella che è stata la sua industria tradizionale con una rinnovata coltura [ossia, la vallicoltura] delle sue antiche valli.
Ma fu l’ormai mutata congiuntura storica a incidere forse in misura ancora maggiore: negli anni Sessanta, il Boom economico italiano era ormai un fatto conclamato e il settore primario sempre più residuale; risultava perciò insostenibile il portare sino in fondo un programma costosissimo, ma che ormai non era più al centro degli interessi e dei bisogni del paese.
Già nel 1961, con le bonifiche ancora in pieno corso, il geografo Mario Ortolani aveva sottolineato il palese anacronismo del processo [Ortolani 1961, 34]:
[…] la fame di terra si è andata attenuando. L’assorbimento di manod’opera [sic] avventizia appare addirittura insignificante. Potenti trattori che d’estate si sentono ronzare anche nelle notti di luna, sostituiscono le folte schiere di braccianti che operavano nelle bonifiche del passato. […] Poiché le famiglie da insediare non potranno essere qui [nelle bonifiche di Valle Pega, Rillo e Zavalea, a sud di Comacchio] più di 340, ogni famiglia graverà sull’erario, soltanto per le opere di trasformazione, con lire 7.235.000, come media generale. […] Il Mezzano è sei-sette volte più esteso di quel comprensorio, e perciò le spese assolute di trasformazione cresceranno per lo meno nel medesimo rapporto. Si tratta di somme sbalorditive, per risultati dubbi, che non possono non lasciare perplesso chiunque abbia a cuore i problemi della finanza e della economia nazionale.
Più sintetico, ma altrettanto efficace, Indro Montanelli nel 1964 [Montanelli 1964]:
La bonifica del Delta Padano è stata condotta con criteri tecnicamente encomiabili; ma non è servita affatto allo scopo che si proponeva: infatti quando le terre sono state bonificate la popolazione se n’era già andata a lavorare nelle fabbriche delle città vicine. Morale: la medicina era buona, ma il malato non c’era più.
Si noti come le critiche di Ortolani e di Montanelli si basassero sul solo piano economico; non una parola è da loro dedicata alla questione ecologica connessa alla scomparsa delle aree umide.
L’Ente delta padano fu ufficialmente chiuso nel 1976 dopo 25 anni di attività: esso lasciava dietro di sé un sistema deltizio completamente mutato nei suoi lineamenti paesistici, con una superficie umida ormai molto ridotta nel settore ferrarese; soprattutto, la qualità ambientale, specie delle acque, risultava decisamente peggiorata e, in seguito ad essa e alla correlata diminuzione dell’habitat vallivo, la pesca si avviò a un rapido declino. Di converso, le “terre nuove”, poco fertili e con pezzatura eccessivamente limitata per il sostentamento della famiglia assegnataria, tradirono le grandi aspettative iniziali: queste stesse campagne, così come nel resto d’Italia, iniziarono ben presto a spopolarsi a soli dieci anni circa di distanza dalla loro “creazione” e appoderamento [Crainz 2013, 93; Nani 2016, 285].
2. Sullo sfondo: la Guerra fredda
La nascita e gli sviluppi della Riforma agraria italiana si situano cronologicamente per intero entro la stagione della Guerra fredda. Ma la connessione tra i due fenomeni non è solo temporale o incidentale, bensì strutturale: grazie agli studi di Emanuele Bernardi [Bernardi 2006], conosciamo infatti i dettagli e le interconnessioni relativi al finanziamento della Riforma attraverso il Piano Marshall. Tale programma rappresentò un gesto di liberalità statunitense, ma dalle implicite implicazioni politiche: l’obiettivo, tramite un progetto che andava a redistribuire terre ai contadini, era quello di coagulare sempre maggiore consenso attorno al governo democristiano al potere, il quale, proprio per sbloccare i finanziamenti americani, nel 1947 aveva optato per l’esclusione del Partito comunista italiano (Pci) dall’esecutivo De Gasperi IV.
L’Italia costituiva infatti un paese strategico nel contesto della Guerra fredda, in quanto confinante con la “Cortina di Ferro” (la Jugoslavia) e contraddistinto dal più grande Partito comunista dell’Europa occidentale. E proprio l’Emilia-Romagna, che ospitava un importante distretto della Riforma e il cui ente di gestione (l’Edp) aveva sede a Bologna, vedeva un elevato consenso verso il Pci. Da parte americana, le riforme agrarie erano inoltre considerate in questa stagione, in Italia come altrove, come una delle forme più efficaci di influenza indiretta sul voto nella direzione voluta dagli Usa, e per questo appoggiate e finanziate [Kapstein 2017].
Alla luce di quanto sin qui discusso, assumono una più chiara rilevanza, nel quadro della Guerra fredda, le varie pubblicazioni italiane degli stessi anni della riforma dedicate alle dinamiche elettorali nel delta padano, i riferimenti ora sempre più frequenti, entro la letteratura italiana di ispirazione cristiano-sociale e non solo, a testi anglosassoni sulla questione fondiaria, la simmetrica attenzione della ricerca americana verso gli sviluppi del programma nell’area deltizia, la sua rappresentazione in filmati statunitensi.
Luciano Mazzaferro dedicò un intero volume agli impatti della Riforma sul voto del delta del Po [Mazzaferro 1956], comparando gli esiti delle elezioni del 1953 con quelli del 1948, precedenti al nuovo corso fondiario.
Pur analizzando il tema da studioso, e non da politico, e quindi sottolineando l’assenza di un nesso meccanicistico e proporzionale diretto tra gli interventi di drenaggio o di esproprio e voto pro-Democrazia cristiana (Dc) [Mazzaferro 1956, 19], l’autore concludeva che
l’interessamento della popolazione del comprensorio per i problemi della riforma agraria ha determinato, nelle zone classificate, una dinamica elettorale diversa da quella dei territori contermini e […] il corso delle votazioni, dapprima sfavorevole alla D.C., ha successivamente consentito agli esponenti cattolici di reintegrare la defezione dell’ala destra con la convergenza di nuovi voti. Parte dell’elettorato, che nel ’51 e nel ’52 si era portato su posizioni di sinistra, condividendo le tesi delle consulte popolari e le critiche mosse all’amministrazione di riforma, converge nel 1953 verso il partito cattolico e mostra che l’attuazione della riforma agraria ha riscosso simpatie tra i votanti e riproposto revisioni di scelta politica [Mazzaferro 1956, 232-233].
Ma nella prefazione dello stesso volume, Manlio Rossi-Doria (1905-1988), una delle “eminenze grigie” della riforma, si spingeva già oltre, preconizzando, in una prospettiva filo-atlantica, una eradicazione progressiva del comunismo in queste terre tramite appunto la ridistribuzione fondiaria. Egli infatti affermava:
Le terre del Delta Padano - terre di bonifica e di preminente caratterizzazione bracciantile - dopo esser state in passato uno dei focolai maggiori del riformismo italiano, avevano ricevuto in questo dopoguerra una impronta radicale ed estremista [ossia, comunista], che nel 1950 appariva ancora compatta e stabile. Non è forse arrischiato affermare che - al di là delle sue specifiche realizzazioni nel complesso interessanti una minoranza delle masse agricole del Delta - l’effetto profondo ed essenziale della riforma risulterà quello di avere definitivamente riaperto le strade del riformismo moderato e costruttivo su quelle terre. In questa veste, perciò, la riforma rappresenta solo il primo atto di un processo del quale la conquista di nuove terre alla cultura [sic], la modifica dei rapporti contrattuali, la riorganizzazione sindacale, gli sviluppi cooperativi e così via rappresenteranno i successivi sviluppi negli anni a venire obbligando le forze politiche operanti nella regione ad una gara riformistica, al termine della quale può esserci solo la riunificazione e l’intesa tra le stesse organizzazioni sindacali e politiche dei lavoratori. È una previsione questa forse arrischiata, specie se fatta (come è il caso) da chi non ha vissuto e non conosce a fondo la realtà del Delta Padano, ma è una previsione giustificata alla luce dell’esperienza narrata in questo volume [Rossi-Doria 1956, XI-XII].
A circa cinquant’anni di distanza dalla chiusura dell’Edp, raffrontando il dato rispetto alle aree contermini poste all’esterno del comprensorio degli interventi, il fatto che la Riforma agraria abbia avuto, nel delta, un reale impatto almeno di medio periodo sul voto locale indirizzandolo verso la Democrazia cristiana, come già sostenuto in itinere da Mazzaferro, è confermato da studi più recenti [Caprettini, Casaburi, Venturini 2023].
All’incirca negli stessi anni (1955) usciva poi l’edizione italiana di The Farming Ladder dell’inglese George Henderson, intitolata Guadagnarsi la terra [Henderson 1955]. Il volume, uscito in prima edizione nel 1944, aveva costituito un piccolo caso editoriale nel Regno Unito, con ben 14 edizioni tra l’anno di stampa e il 1950 [Einaudi 1955, X, nota 1]: la tesi del libro, basato sull’esperienza personale dell’autore, era quella di sottolineare come l’agricoltura potesse fornire possibilità di arricchimento e realizzazione personale ancora alla metà del XX secolo, e come la chiave del successo dipendesse dalla volontà e dalle capacità del piccolo proprietario fondiario.
Era chiaro come l’edizione italiana, curata da Giuseppe Medici (1907-2000) [Einaudi 1955, IX], altro “padre” della Riforma agraria, e pubblicato dalle Edizioni agricole a Bologna (città sede dell’Edp), volesse confermare l’utilità del nuovo programma fondiario nel nostro paese e intendesse fungere da sprone e da motivazione per gli assegnatari. Questa opera anglosassone era quindi assurta ad emblema, sin dal titolo italiano, di un approccio liberale, in cui l’intraprendenza personale portava al successo e in cui il singolo agricoltore diventava “fabbro” della sua fortuna: l’opposto dell’approccio sostenuto dal Pci.
La prefazione alla medesima edizione italiana, affidata a Luigi Einaudi (1874-1961), che proprio nell’anno di stampa del libro (1955) aveva concluso il suo settennato alla Presidenza della Repubblica, esplicitava ulteriormente il quadro, liberale e liberista, della riforma [Einaudi 1955, XXXIV-XXXV]:
Dopo un secolo di predicazione sociale rivolta contro il bersaglio sbagliato di una inesistente lotta fra lavoratori e capitalisti, è giunto il momento nel quale i lavoratori ed i risparmiatori, falsamente denominati proletari e capitalisti gli uomini dell’invenzione e del rischio, i fautori delta moltiplicazione indefinita dei beni e dei servigi comprenderanno la necessità di rivolgere i loro colpi contro i restrizionisti, contro i monopolisti, contro gli uomini delle combinazioni e delle formule, contro tutti coloro i quali sono pronti a trarre vantaggio privato dalla più spedita, universale ed accettata maniera di arricchirsi, che è il ristabilimento e l’incremento dei vincoli, delle frontiere e delle barriere.
Va comunque ricordato come, in relazione allo spirito profondo della Riforma, all’interno della stessa Democrazia cristiana le sensibilità e i punti di vista (e forse anche la piena e matura consapevolezza circa l’origine e le implicazioni dei finanziamenti americani alla base del progetto) risultassero talvolta molto distanti tra loro: in virtuale antitesi alle parole di Einaudi, il politico romagnolo Giordano Marchiani (1924-1996), deputato della Repubblica e direttore dell’Edp, affermava come il governo centrista avesse compiuto, tramite la legge stralcio, la sua «piccola Rivoluzione d’Ottobre» [Cazzola 2011, 13], tratteggiando dunque il programma come un nuovo corso quasi figlio della lotta di classe. Sebbene non democristiano, anche il già citato Aldo Spallicci fu ispirato dall’edizione italiana del volume di Henderson. Sulla scia di Einaudi, il senatore romagnolo rimarcava come la redistribuzione fondiaria dovesse ancorarsi a criteri meritocratici («la terra a chi la merita»), e non alla mera fede politica degli assegnatari, paventando una deriva assistenzialista dell’intero programma di riforma (timore che poi si materializzò concretamente) [Spallicci 1996, 499-502; l’intervento si data al 1955]:
In questi giorni è stato pubblicato un volume di grande interesse, che io consiglio alla lettura dei colleghi [Senatori]. È un libro di un inglese, George Henderson, dal titolo The farming ladder (Guadagnarsi la terra nella traduzione italiana), traduzione dovuta al senatore Medici in una edizione bolognese. Vi si legge una calda prefazione di Luigi Einaudi. L’autore del libro, che è un pioniere dell’agricoltura dice in sostanza che non si debbono fare dei regali sociali: i doni sociali sono sempre un errore. […] Non regali politici adunque, ci si ammonisce. […] Forse che il bracciante italiano non lo ha maturato [il diritto alla terra] in una secolare servitù della gleba, con lunghe tribolazioni e lunghi digiuni? È possibile non riconoscerglielo questo diritto? Certo che sì, subordinandolo però ad una opportuna selezione. La terra, proclama Henderson che odia i titoli accademici e le scuole agrarie, bisogna soprattutto amarla, amare i frutti, le erbe, con spirito francescano. […] L’Henderson ha in uggia gli uomini che fan tutto di contraggenio, ha in uggia i «malavoglia». È un monito che è buono per tutti, serve soprattutto per noi italiani per cui è di moda essere sempre scontenti della propria condizione […]. Non il gentiluomo di campagna adunque, ma neanche il bracciante neghittoso che non conosce, che non ama, che non ha fede nella terra. Anzitutto dunque amore alla terra, ci insegna Henderson […].
Ma il nesso fra Riforma agraria, bonifica e Guerra fredda non si limitò al solo campo pubblicistico.
La neocreazione di nuove terre in seguito al drenaggio delle valli portò, a cascata, alla necessità di una toponomastica di neoinvenzione.
Nel caso della bonifica di valle Pega (Comacchio), iniziata già nel 1951 agli esordi della Riforma, rivisitando in un contesto ora democratico pratiche simili del Ventennio fascista si optò per una toponomastica nazionalistica, tesa a ricreare qui i territori già italiani dell’Istria e della Dalmazia che erano stati ceduti alla Jugoslavia (il paese comunista confinante) successivamente alla Seconda guerra mondiale. Troviamo quindi strade di bonifica e poderi denominati (significativamente, col solo toponimo italiano, e non con quello odierno slavo) Istria, Capodistria, Buiedistria, Portorose, Pola, Dalmazia, Arsia, Fiume, Monte Nevoso [Piastra 2022].
Un’ulteriore strada della bonifica di valle Pega venne denominata “Trieste”: per quasi un decennio, tra il 1947 e il Memorandum d’intesa di Londra (1954), la città, oggetto di disputa fra Italia e Jugoslavia, fu costituita come un territorio indipendente (“Territorio libero di Trieste”), e solo dopo il 1954 ufficialmente assegnata all’Italia.
Se quella sin qui analizzata è la prospettiva italiana circa la Riforma agraria nel delta e la Guerra fredda, esiste una simmetrica “prospettiva americana” al riguardo.
Il mondo della ricerca statunitense, spesso su commissione governativa, si mostrò infatti interessato circa lo sviluppo del nuovo corso fondiario italiano. Nel 1966 il geografo George Kish dell’Università del Michigan, su incarico dell’Office of Naval Research, dedicò un intero report alla Riforma agraria nel nostro paese, frutto di ripetuti sopralluoghi sul terreno (1951-1952 grazie al Programma Fulbright; 1959; 1960). Al suo interno è analizzata anche la realtà del delta padano [Kish 1966, 64].
Pochi anni più tardi, Davis McEntire dell’University of California, Berkeley, si mosse nella stessa direzione: in Italia nel 1959-1960 e poi ancora nel 1968 di nuovo grazie al Programma Fulbright, elaborò un report su incarico della United States Agency for international development (Uusaid), con cenni circa il delta [McEntire 1970, 25].
Gli studi americani più interessanti in relazione al tema che qui interessa vanno però individuati in quelli del geografo David Laurie Wheeler.
Allievo di Kish presso l’Università del Michigan, fu da questi inviato in Italia per studio tra gennaio e agosto 1960.
Nel 1962 erano completati un suo articolo generale sulla Riforma agraria in Italia [Wheeler 1962b], ma soprattutto la sua tesi di dottorato, inedita, da noi recuperata presso la biblioteca dell’Università del Michigan, Ann Arbor [Wheeler 1962a].
L’analisi di Wheeler si concentra su quattro comuni dell’Ente delta padano (Rosolina, Jolanda di Savoia, Comacchio, Ravenna; tre comuni su quattro sono quindi emiliano-romagnoli).
A Comacchio, l’autore affronta in modo particolare la già citata bonifica di valle Pega, forse perché una delle prime intraprese dall’Edp e quindi, al momento del suo lavoro sul terreno (1960), andata a regime. Wheeler ne pubblica una carta in relazione all’utilizzo del suolo e al sistema di sollevamento e scolo idraulico funzionale a mantenerla asciutta (pompe, canali), sottolineando il carattere salino dei suoi suoli nonostante, successivamente al drenaggio delle originarie acque salmastre, ripetuti riallagamenti e svuotamenti con acqua dolce [Wheeler 1962a, 104].
Ma i capitoli forse più significativi in chiave politica sono quelli relativi a Jolanda e Ravenna in relazione alla realtà cooperativa. Qui il geografo americano mette a confronto quelle che lui chiama, in italiano, «comunioni risicole» di Jolanda [Wheeler 1962a, 136; cf. anche King 1973, 93], da interpretarsi come un collettivo agricolo [Menzani 2007], con quello che lui definisce il «Communist Cooperative Movement» di Mezzano (Ravenna) [Wheeler 1962a, 171].
La prima era una formula di gestione delle terre decisamente meno comune dell’assegnazione nel contesto della Riforma nel delta, che l’Edp adottò principalmente per le risaie ospitate in terreni già da tempo bonificati. In questo caso, il lavoro manuale, la gestione delle fasi di allagamento e asciugatura delle camere risicole e i macchinari necessari per portare avanti tale coltura scoraggiavano infatti la parcellizzazione in piccoli poderi e la conduzione familiare, propugnate invece nelle terre neo-asciugate.
Wheeler visitò la «comunione risicola» (altrove, «rice community») Gea [Wheeler 1962a, 140-148], posta a nord di Jolanda di Savoia, a cui dedicò un articolo specifico successivamente alla tesi di dottorato [Wheeler 1963].
Il geografo americano nutriva seri dubbi sulla sua sostenibilità economica e sociale nel medio periodo, appoggiando implicitamente l’approccio fondiario “individualistico” abbracciato nel resto del delta [Wheeler 1962a, 146-148; concetto ribadito in forma più sintetica anche in Wheeler 1963, 316]:
In spite of Gea’s relative prosperity, two families quit the community between January and July 1960. At least two other families left before them. Since 1953, then, four families have found life in the community unsatisfactory. The example of Gea is not isolated. Records of the Po Delta Agency Social Service in Iolanda indicate that between 1953 and July 1960, 108 families, 604 people in all, have left the twenty-five rice communities of Iolanda. Gone with them are the imposing ideals concerning harmony, self-discipline, and knowledge of oneself. In their place are the sometimes harsh realities of communal living. The Po Delta Agency [l’EDP] is reluctant to reveal the reasons why so many people leave the communities. One is discouraged from probing too deeply into the difficulties of communal life. Yet it is readily enough apparent why the people leave. Communal living and working is contrary to the independent nature of the Italian farmer. Most families are strangers to one another when they arrive at a community, and they are far from being a homogeneous group: their places of origin vary, they differ in experience, knowledge, ideals, and even dialect. Yet they are thrown together with little regard given to their compatability or to their personal backgrounds. They are told where to work, in some cases, how to work, and how long to work. The only measure of freedom is the individual’s vote. In the weekly debates on communal policy bitter animosities are sometimes aroused. The fate of the community depends upon harmony in relations among fellow members. The individual must place group and communal interests before himself. He must think in terms of “we” rather than in terms of “I”. […] The Po Delta Agency, the technicians in Iolanda [Jolanda di Savoia], and the farmers themselves are almost unanimous in agreement that the rice communities are the best means of solving the agronomic problems presented by irregular soils. From the social standpoint, however, the communions leave much to be desired. Under the present circumstances it seems questionable that the rice communities can endure. The gravity of the situation can best be summed up in the words of a farmer in a recent letter: “Agriculture is in a crisis here” [lettera privata di Fiorindo Cavallini, lavoratore presso Gea, a Wheeler, con cui era in contatto: Wheeler 1962a, III].
La «comunione risicola» Gea fu messa a confronto con una cooperativa “rossa” ubicata a Mezzano, frazione posta presso i confini comunali di Ravenna e Bagnacavallo, come specificava Wheeler «directed and administrated by the Communist Party» [Wheeler 1962a, 171, 174].
Sebbene sia implicito un certo grado di prevenzione rispetto all’orientamento politico, l’autore ne registrava un certo successo, collegandolo lucidamente all’adesione ideologica dei lavoratori:
Yet the Cooperative of Mezzano cannot offer its members new homes, or the amenities of the service center of San Romualdo in Bosco [un borgo della Riforma agraria, neofondato nei dintorni]. In spite of that fact, the Communist cooperative movement is apparently a success [Wheeler 1962a, 178].
Wheeler concludeva quindi che
What will be the future of the Cooperative of Mezzano is a question that lies more in the realm of politics than in geography. The attraction of Mezzano has not been an offer of a better life or superior agricultural practices. Rather the attraction has been political ideology. Yet Mezzano has been of service to the comune in reducing the agricultural pressure on the land and in offering work opportunities to day laborers who might not otherwise have been employed. The failure of Mezzano will not be due to agricultural malpractice, but from governmental stultification or ideological disenchantment [Wheeler 1962a, 179].
Nel 1965 l’autore dedicò un ultimo articolo alla Riforma agraria nel delta padano, concentrandosi questa volta sull’opera di drenaggio [Wheeler 1965]. Qui egli si concentrava su un primo bilancio costi-benefici delle operazioni, mostrando implicitamente alcuni dubbi al riguardo, fugati però, a suo modo di vedere (e diversamente dalla visione di Ortolani, discussa sopra), dal carattere simbolico e ispirazionale del programma:
Reclamation and colonization of the remaining lagoons which comprise the Valli di Comacchio will cost in excess of 57 million dollars. Critics believe that the benefits derived by so few will hardly justify the expense. But whatever the cost, whatever the long term result, the people of Comacchio have at least a hope for the future [Wheeler 1965, 382].
Sullo sfondo dei lavori di Wheeler sembra inoltre stagliarsi un’idea delle bonifiche nel delta come ultima prospettiva per l’agricoltura italiana, verosimilmente sulla scia di un’attualizzazione della corsa verso l’ovest e del concetto di frontiera americani.
Quasi a chiudere il cerchio, Alison Sànchez Hall dedicò il suo Dottorato di ricerca in Antropologia culturale all’University of California, Santa Barbara, alla cooperazione agricola nel comprensorio dell’Edp. La sua area di studio fu localizzata presso Longastrino, centro esattamente al confine tra le province di Ravenna e Ferrara (Alfonsine e Argenta), dove risiedette per circa due anni (1972-1974). Partita dagli Usa con una tesi di partenza, ossia il dimostrare sul campo l’insostenibilità e l’inevitabile fallimento del modello cooperativo agricolo (assioma superficiale, quanto diffuso, negli Stati Uniti del tempo, figlio a sua volta della Guerra fredda) [Sànchez Hall 2019, 29; Albonetti 2019, 11], l’autrice si convinse invece rapidamente del successo di un tale approccio. In un suo recente volume, in cui rilegge in retrospettiva la sua esperienza di Dottorato di ricerca a circa 50 anni di distanza e il cui titolo originale, All or None. Cooperation and Sustainability in Italy’s Red Belt, significativamente contiene un riferimento politico, Sànchez Hall si chiede anzi, con una certa dose di provocazione, se esso non possa essere esportato negli Usa [Sànchez Hall 2019, 207-208].
Ma anche in questa storia di cambiamento in corsa nella valutazione della cooperazione nel delta è comunque ravvisabile un ultimo “colpo di coda” della Guerra fredda. L’autrice ricorda infatti come rimase delusa dall’apprendere che il suo tutor collaborava col governo americano in relazione al prevenire le rivoluzioni contadine in America Latina [Albonetti 2019, 12]: appare quindi lecito ipotizzare un interesse “politico” da parte di quel docente statunitense verso la Riforma nella “regione rossa” per antonomasia e nell’indirizzare la sua dottoranda verso lo studio di tale tema.
Lato americano, oltre alla produzione scientifica, esiste inoltre una dimensione di rappresentazione della Riforma agraria nel delta.
Risale al 1951 (l’anno di fondazione dell’Edp) un breve filmato statunitense, intitolato Emilia, sviluppato sotto l’egida dell’Economic cooperation administration (Eca), ente di gestione del Piano Marshall, e prodotto dalla Vittorio Gallo films, Roma [Longo 2012, 20].
Esistono due versioni, digitalizzate e caricate on line, del video, una più breve priva della sezione dedicata al delta padano [3], e una più estesa, la cui seconda parte è appunto focalizzata sulla Riforma nel territorio deltizio [4].
In quest’ultima, si parte dai quadri ambientali ex ante la Riforma nel delta, dominati dalle aree umide (connotate, con evidente pregiudizio, come geneticamente portatrici di degrado e povertà), per poi mostrare i vasti lavori di bonifica intrapresi. La visione si sofferma sulle nuove strutture nel delta esplicitamente edificate grazie all’European recovery program (Erp), nome ufficiale del Piano Marshall. Nel finale compaiono già i risultati delle bonifiche: al posto delle acque stagnanti troviamo nuovi campi.
È evidente la dimensione propagandistica del filmato, pensata in funzione dell’audience americana e quindi, in prima battuta, a giustificare presso l’elettorato statunitense le ingenti spese per il Piano Marshall.
Il preconcetto negativo in relazione alle aree umide veniva da lontanissimo, in relazione ad alcuni aspetti risalente addirittura al mondo greco-romano: Giusto Traina ha infatti analizzato come, già in età antica, il successo delle aree urbane ubicate presso lagune fosse considerato un miraculum [Traina 1988, 94], o come il modello geografico greco-romano ponesse le paludi ai “confini del mondo”, relegandole a luoghi marginali per antonomasia [Traina 1988, 129-132]. Più tardi, nel Medioevo, la “lotta alla palude” diventò poi un caposaldo dell’opera, materiale e al contempo spirituale (a ricreare l’“ordine” del Creato), di ordini religiosi quali i benedettini e i cistercensi.
Tale pregiudizio risultava (e spesso ancora oggi risulta) ancorato, in Italia come altrove, a cliché letterari, a problemi sanitari ormai superati in ambito italiano negli anni Cinquanta del Novecento (la malaria) e a luoghi comuni duri a morire, quale l’improduttività delle lagune rispetto ai terreni agricoli, quando invece le valli di Comacchio avevano conosciuto, per secoli, una florida economia imperniata sulla pesca e sulla produzione salina [Pozzati 1996].
Il livello di propaganda nel video risulta elevato anche perché esso è datato 1951, ossia l’anno stesso di fondazione dell’Edp: nella realtà, l’opera di bonifica era, a quel tempo, appena iniziata e non erano ancora visibili sul terreno risultati concreti; Emilia si erge quindi a profezia di sé stessa, anticipando e dando come già acquisiti gli interventi e le realizzazioni che sarebbero poi state realmente portate avanti solamente negli anni seguenti.
Lo scarto è evidente rispetto agli omologhi filmati (comunque filo-governativi) dell’Istituto Luce, dedicati al lavoro dell’Ente delta padano negli stessi anni [5]: in essi, il finanziamento del programma tramite il Piano Marshall non è nemmeno citato, a evitare possibili critiche entro il dibattito italiano relative alla dimensione sotterranea, atlantista, del progetto.
In relazione al nesso tra produzione cinematografica americana, Guerra fredda e delta padano, segnaliamo infine come l’Edp possedesse entro il suo archivio (oggi presso la cineteca del Comune di Bologna), vari cortometraggi, documentari e cartoni statunitensi, adattati in italiano per il pubblico del nostro paese, verosimilmente da proiettare durante eventi pubblici itineranti nel delta: C’era una volta... (The Impressionable Years: American Children and the Public Library) di Peter Elgar (1952), Giovani per i giovanissimi, Una manciata di terra, Conservazione della terra e dell’acqua di Carl Pryer e il cartone animato I secoli dell’agricoltura di Don Towsley, animatore per Disney e Hanna & Barbera [Zorzin 2008-2009, 128-131]. Si tratta di prodotti direttamente o indirettamente collegati al mondo agricolo, rivolti a un pubblico giovanile o poco scolarizzato, funzionali a illustrare presso gli assegnatari e i loro figli i successi di un settore primario moderno come quello americano e l’importanza dell’istruzione.
3. Acque e terre fra passato, presente e futuro
Oggi, a circa cinquant’anni dalla chiusura dell’Edp, il territorio del delta padano è di nuovo al centro di sfide cruciali, gestionali e quindi politiche. Non si tratta più della contrapposizione tra Dc e Pci degli anni della Guerra fredda.
Sono semmai emerse in modo eclatante le “promesse non mantenute” della Riforma agraria nel delta padano: l’isolamento di questa area non è stato realmente rotto; gli indici sociali e demografici mostrano tuttora segnali preoccupanti (alti livelli di disoccupazione, emigrazione); la struttura della piccola proprietà fondiaria, figlia delle assegnazioni, è oggi in gran parte scomparsa, conoscendo anzi, proprio negli appezzamenti drenati, la ricomposizione della grande proprietà; l’agricoltura nelle terre bonificate continua a mostrare evidenti criticità circa la salinità dei suoli, il loro carattere torboso, la tendenza alla subsidenza. Ai nostri giorni, il delta può, cioè, essere assurto a uno dei vari «territori scartati» della penisola [Piastra 2021], e questo nonostante non si tratti di un territorio interno, anzi sia ubicato nei pressi del mare.
Acclarato un bilancio con molti limiti delle bonifiche e del tentativo di trasformare artificialmente un paesaggio anfibio in un paesaggio agrario, proprio le acque, ossia i lineamenti paesistici originari del delta, costituirebbero oggi l’unica vera risorsa, identitaria, culturale ed economica, su cui tentare un rilancio per questa zona, in funzione del turismo e della pesca.
Sebbene suggestivo, appare però pura utopia immaginare di “riportare indietro le lancette dell’orologio” del territorio in toto, riallagando tutte le aree drenate nel passato recente: i costi di riacquisto delle terre da risommergere, ora private, sarebbe elevatissimo; lo stesso dicasi per i residenti da ricollocare, sebbene essi siano pochi; anche sul piano politico e sociale, ossia del consenso delle comunità locali all’operazione, sembra arduo trovare una quadra.
La prospettiva più realistica, almeno nel breve periodo, ci appare quindi quella della mitigazione delle scelte passate, di rinaturalizzazione parziale e di conservazione di quanto sopravvissuto. L’ipotesi di riallagamento, in funzione dell’acquacoltura e del turismo, andrebbe concentrata in primis sulla ex valle del Mezzano, ai confini tra i territori comunali di Comacchio, Argenta, Portomaggiore e Ostellato, molto ampia e tuttora priva di popolamento rurale; limitate valli bonificate, ancora mantenute asciutte, potrebbero essere riconvertite a “laboratorio a cielo aperto” lasciandole alla rinaturalizzazione totale, in modo da studiarne tempi e dinamiche in pianura (ambiente solitamente ad altissima antropizzazione); altri territori drenati potrebbero a loro volta diventare una risorsa turistica, incentrata su quelli che, a distanza di secoli o decenni, sono diventati i valori culturali della bonifica, ossia un paesaggio artificiale, punteggiato da siti di archeologia industriale (le idrovore storiche) [Piastra 2010b; Piastra 2014]. A tal proposito, al fine di mantenere viva la memoria della “epopea della bonifica” in questi territori [Piastra 2017] [6], sarebbe auspicabile l’istituzione di un Centro di documentazione sulla stagione della Riforma agraria nel delta, nei suoi aspetti materiali e immateriali: una simile struttura fu inaugurata anni fa nel delta veneto [Milan, Perini, Tognon 2004], ma ebbe vita breve, mentre sul lato emiliano-romagnolo essa è rimasta allo stadio di mera proposta [Piastra 2011c].
Sul piano colturale sarebbe teoricamente praticabile, nelle terre bonificate emiliano-romagnole, il ritorno oppure l’introduzione su vasta scala del riso, con il conseguente riaffacciarsi, in settori del delta già asciugati, di un paesaggio allagato per vari mesi all’anno. Allo stesso tempo, è inutile negare, riguardo alla realizzazione pratica di una simile ipotesi, il problema dell’approvvigionamento di acqua dolce per l’allagamento periodico delle risaie: le risorse idriche funzionali a ciò non potrebbero che provenire dal Po, fiume però sempre più in profonda crisi, le cui acque sono da decenni derivate e convogliate sino al Riminese per fini di irrigazione tramite il Canale emiliano-romagnolo (Cer).
Appaiono ulteriormente implementabili le azioni portate avanti in relazione alla salina storica di Comacchio: già oggetto di un importante recupero ambientale, ora sito centrale per il birdwatching e le attività educative, la produzione di sale qui reintrodotta da alcuni anni a questa parte può aumentare i propri volumi e il proprio impatto micro-economici (vendita, mestiere del salinaro, ecc.) [7].
E ancora: una grande prospettiva riguarda il possibile ritorno, in futuro, di un importante comparto della pesca di anguilla (Anguilla anguilla), in passato al centro di una vera e propria “cultura” nelle valli di Comacchio [Sorella anguilla 1990], specie da tempo (come detto, anche a causa delle bonifiche) in crisi a livello locale, e dal 2020 inserita nella lista rossa (pericolo critico) dall’Iucn [8]. La sua riproduzione in cattività, da sempre problematica, da vari anni è al centro della ricerca, ora con risultati positivi nella direzione di incrementarne sensibilmente lo stock ittico complessivo nel delta padano [Artificial reproduction 2020].
Sullo sfondo di tutte queste ipotesi gestionali (e politiche) si situa il ruolo dei due parchi regionali che qui insistono, uno in Veneto e uno in Emilia-Romagna: da tempo si susseguono appelli per la creazione di un unico parco nazionale, a proteggere, con maggiore efficacia e in una prospettiva unitaria, quella che, nonostante secoli di bonifica, è tuttora la più ampia area umida italiana, nonché Riserva di biosfera Mab e Patrimonio dell’umanità Unesco [9], ma ad oggi senza effetti concreti [Piastra 2021, 144-145].
Se quanto sin qui discusso risulta valido per il breve periodo, nel medio e lungo periodo per il delta padano si profilano all’orizzonte nuove e ancora più complesse sfide.
Da un lato, il cambiamento climatico, con piogge sempre più intense in tempi sempre più ristretti, sta mettendo e metterà ancora di più in futuro alla prova un sistema idraulico artificiale, e quindi di per sé più fragile, che ha l’arduo compito di mantenere asciutti terreni spesso posti al di sotto del livello del mare.
Ma, soprattutto, tutto questo progetto, portato avanti negli anni del Boom, quando l’energia non veniva considerata un problema, ha un costo energetico attualmente elevatissimo: idrovore imponenti che sollevano le acque, azionate elettricamente tramite linee dedicate dell’alta tensione, in azione tutto il giorno, ogni giorno dell’anno. Visti l’enorme problema energetico mondiale in relazione al futuro esaurimento dei combustibili fossili, la ancora nebulosa “transizione verde”, il continuo aumento dei consumi energetici stessi e, simmetricamente, l’aumento dei costi dell’energia, un mercato sempre più globale dei prodotti agricoli, non appare inverosimile, in futuro, lo spegnimento delle idrovore per risparmiare sui loro costi, a fronte di una produzione agricola limitata nelle terre bonificate o comunque facilmente rimpiazzabile da prodotti provenienti da altrove.
Se tale scenario si verificherà, a quel punto si giungerà realmente a un progressivo riallagamento delle valli deltizie già bonificate, non dettato però da finalità ecologiche o di ripristino ambientale, bensì da una ben più cogente scelta di risparmio economico.
In sintesi, più che una futura sommersione marina delle bonifiche del delta legata all’innalzamento del livello dell’Adriatico, a sua volta causato dal cambiamento climatico, così come recentemente rappresentato in ambito letterario [Dal Sito 2020; Wu Ming 1 2024, 92] o giornalistico [Liberti 2021, 93], ci sembra maggiormente realistico un futuro ritorno, entro le valli già asciugate, delle acque dolci provenienti da monte, non più sollevate dalle idrovore perché il bilancio costi-benefici dei drenaggi sarà giudicato insoddisfacente.
Bibliografia
- Albonetti 2019
Pietro Albonetti, Introduzione, in Alison Sànchez Hall, “Tutti o nessuno”. La rivoluzione cooperativa dei braccianti di Romagna, Ravenna, Pozzi, 2019, pp. 11-14. - Artificial reproduction 2020
Pietro Emmanuele, Antonio Casalini, Daniela Pisati, Rebecca Andreini, Niccolò Guercilena, Albamaria Parmeggiani, Annalisa Zaccaroni, Oliviero Mordenti, Artificial reproduction of Anguilla anguilla: evaluation of biometrics characteristics of a population from Valle Campo Lagoon, Comacchio (Italy), in «Aquaculture International», 27 (2020), pp. 777-790. - Bernardi 2006
Emanuele Bernardi, La riforma agraria in Italia e gli Stati Uniti. Guerra fredda, piano Marshall e interventi per il Mezzogiorno negli anni del centrismo degasperiano, Bologna, Il Mulino, 2006. - Biolcati Rinaldi, Alberti 2011
Maurizio Biolcati Rinaldi, Francesco Alberti, Paesaggi della riforma agraria. Azioni integrate per l’interpretazione morfologica del progetto urbano, Firenze, Alinea, 2011. - Caprettini, Casaburi, Venturini 2023
Bruno Caprettini, Lorenzo Casaburi, Miriam Venturini, Harvesting Votes: The Electoral Effects of the Italian Land Reform, Working Papers 202408, Riverside, University of California, Department of Economics, https://ideas.repec.org/p/ucr/wpaper/202408.html. - Cazzola 2011
Franco Cazzola, La riforma agraria nel Delta Padano, in Terre nuove. Immagini dell’archivio fotografico dell’Ente Delta Padano, a cura di Priscilla Zucco, Stefano Pezzoli, Isabella Fabbri, Bologna, Compositori, 2011, pp. 11-13. - Crainz 2013
Guido Crainz, Storia del miracolo italiano, Roma, Donzelli, 2013. - Dagradi 1979
Piero Dagradi, Bonifica e riforma agraria nel Delta Padano, in Ricerche geografiche sulle pianure orientali dell’Emilia-Romagna, a cura di Bruno Menegatti, Bologna, Pàtron, 1979, pp. 15-39. - Dal Sito 2020
Moira Dal Sito [pseudonimo collettivo], Quando qui sarà tornato il mare. Storie dal clima che ci attende, a cura di Wu Ming 1, Roma, Alegre, 2020. - Einaudi 1955
Luigi Einaudi, Esiste una frontiera?, in Henderson 1955, pp. VII-XXXV. - Henderson 1955
Giorgio [George] Henderson, Guadagnarsi la terra, Bologna, Edizioni Agricole, 1955 (trad. it. di Id., The Farming Ladder, Londra, Faber & Faber, 1944). - Kapstein 2017
Ethan B. Kapstein, Seeds of Stability. Land Reform and US Foreign Policy, Cambridge, Cambridge University Press, 2017. - King 1973
Russell King, Land reform: The Italian Experience, Londra, Butterworth, 1973. - Kish 1966
George Kish, Land Reform in Italy: Observations on the Changing Face of the Mediterranean. Final Report, Ann Arbor, University of Michigan, 1966. - Liberti 2021
Stefano Liberti, Terra bruciata. Come la crisi ambientale sta cambiando l’Italia e la nostra vita, Milano, Rizzoli, 2021. - Longo 2012
Regina M. Longo, Between Documentary and Neorealism: Marshall Plan Films in Italy (1948-1955), in «California Italian Studies», 2, 2 (2012), pp. 1-45. - Mazzaferro 1956
Luciano Mazzaferro, Geografia elettorale del Delta Padano, Bologna, Il Mulino, 1956. - McEntire 1970
Davis McEntire, Land Reform in Italy, (Agency for International Development), Berkeley, University of California, 1970. - Menzani 2007
Tito Menzani, «L’anticamera del “kolkhoz” sovietico». I collettivi agricoli nell’Emilia-Romagna del secondo dopoguerra, in «Rivista di Storia dell’Agricoltura», XLVII, 1 (2007), pp. 131-152. - Menzani 2019
Tito Menzani, Passato prossimo. Storie di ieri, sguardi sull’oggi e progetti per il domani del movimento cooperativo ferrarese, Bologna, Clueb, 2019. - Milan, Perini, Tognon 2004
Daniele Milan, Lorenza Perini, Cristina Tognon, Prima di cominciare, in Progettare la terra, progettare la società. L’attività dell’Ente Delta Padano negli anni ’50, Ariano nel Polesine, Parco regionale del Delta del Po Veneto, 2004, p. 5. - Montanelli 1964
Indro Montanelli, Riformare i riformatori, in «La Domenica del Corriere», 66, 6, 9 febbraio 1964, p. 5. - Nani 2016
Michele Nani, Migrazioni bassopadane. Un secolo di mobilità residenziale nel Ferrarese (1861-1971), Palermo, New Digital Press, 2016. - Ortolani 1961
Mario Ortolani, Scompariranno le Valli di Comacchio?, in «Natura e Montagna», s. II, I, 3 (1961), pp. 28-34. - Pedrazzini 2003
Immagini della Riforma Agraria. Interventi di Pierluigi Giordani nel Delta Padano e dintorni (1952-1975). Esperienze contestuali di edilizia pubblica e privata, a cura di Alberto Pedrazzini, Ravenna, Longo, 2003. - Piastra 2010a
Stefano Piastra, Spunti paesistici nell’opera di Francesco Serantini, in «Studi Romagnoli», LXI (2010), pp. 1061-1071. - Piastra 2010b
Stefano Piastra, Land Reclamations in the Po and Danube Deltas: Similar Backgrounds, Different Future Perspectives?, in Bacini territoriali e bacini culturali nello sviluppo delle piccole e medie imprese, a cura di Massimo Bianchi, Laura Del Bene, Laura Tampieri, Sinisa Zaric, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2010, pp. 305-315. - Piastra 2011a
Stefano Piastra, Dall’acqua alla terra. La metamorfosi antropogenica del delta padano emiliano-romagnolo, in Terre nuove. Immagini dell’archivio fotografico dell’Ente Delta Padano, a cura di Priscilla Zucco, Stefano Pezzoli, Isabella Fabbri, Bologna, Compositori, 2011, pp. 15-22. - Piastra 2011b
Stefano Piastra, La bonifica della valle del Mezzano tra memoria e progetto: percezione presso le comunità locali, rappresentazioni letterarie e filmiche, problemi e prospettive gestionali, in Il paesaggio della bonifica. Architetture e paesaggi d’acqua, a cura di Chiara Visentin, Roma, Aracne, 2011, pp. 129-138. - Piastra 2011c
Stefano Piastra, Terre nuove. Bonifica e memoria a sessant’anni dall’istituzione dell’Ente per la colonizzazione del delta padano, in «IBC», XIX, 4 (2011), pp. 36-38. - Piastra 2012
Stefano Piastra, Riforma agraria e bonifica nel delta padano emiliano-romagnolo. Appunti per una rilettura, in Riforma fondiaria e paesaggio, a cura di Gabriella Bonini, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. 155-168. - Piastra 2013
Stefano Piastra, Paesaggi della riforma agraria nel Delta padano emiliano-romagnolo, in Paesaggi agrari del Novecento. Continuità e fratture, a cura di Gabriella Bonini, Antonio Brusa, Rossano Pazzagli, Gattatico, Istituto Alcide Cervi, Biblioteca Archivio Emilio Sereni, 2013, pp. 85-92. - Piastra 2014
Stefano Piastra, Le “larghe” e il paesaggio della bonifica nel Delta padano emiliano-romagnolo: valori storico-culturali e temi gestionali a cinquant’anni di distanza dalla Storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni, in Paesaggi in trasformazione. Teorie e pratiche della ricerca a cinquant’anni dalla Storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni, a cura di Gabriella Bonini, Chiara Visentin, Bologna, Compositori, 2014, pp. 167-172. - Piastra 2017
Stefano Piastra, La Riforma agraria nel delta padano emiliano-romagnolo tra passato e presente. L’esperienza del documentario Dall’acqua ai campi, dai campi al silenzio, in I paesaggi della Riforma agraria. Storia, pianificazione e gestione, a cura di Fausto Carmelo Nigrelli, Gabriella Bonini, Gattatico, Istituto Alcide Cervi, Biblioteca Archivio Emilio Sereni, 2017, pp. 365-372. - Piastra 2021
Stefano Piastra, In pianura e presso il mare, eppure scartato. Il delta del Po, in Paesaggi scartati. Risorse e modelli per i territori fragili, a cura di Fausto Carmelo Nigrelli, Roma, Manifestolibri, 2021, pp. 135-148. - Piastra 2022
Stefano Piastra, Invented toponymy for invented lands. Place names and reclamation in the Emilia-Romagna sector of the Po River Delta (Northern Italy), 1920s-1960s, in Permanence, transformation, substitution and oblivion of geographical names, Andrea Cantile, Helen Kerfoot Editors, (Proceedings of the 3rd International Scientific Symposium of the United Nations Group of Experts on Geographical Names - Romano-Hellenic Division, Naples, 22nd - 24th September 2021), Firenze, IGM, 2022, pp. 213-223. - Pozzati 1996
Francesco Pozzati, Comacchio tra piscicoltura e società, Ferrara, Gabriele Corbo Editore, 1996. - Rossi-Doria 1956
Manlio Rossi-Doria, Prefazione, in Luciano Mazzaferro, Geografia elettorale del Delta Padano, Bologna, Il Mulino, 1956, pp. IX-XII. - Sànchez Hall 2019
Alison Sànchez Hall, “Tutti o nessuno”. La rivoluzione cooperativa dei braccianti di Romagna, Ravenna, Pozzi, 2019 (trad. it. di Id., All or None. Cooperation and Sustainability in Italy’s Red Belt, New York, Berghahn Books, 2018). - Sciaudone 2025
Antonio Sciaudone, La formazione della proprietà coltivatrice: un originale modello di attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, libertà e democrazia, in Riforma agraria. Trasformazione economica e democrazia nelle campagne, a cura di Stefano Masini, Roma, Donzelli, 2025, pp. 123-153. - Sorella anguilla 1990
Sorella anguilla. Pesca e manifattura nelle valli di Comacchio, a cura di Folco Cecchini,
Bologna, Nuova Alfa editoriale, 1990. - Spallicci 1996
Aldo Spallicci, Opera Omnia, VII, Scritti e discorsi politici, Rimini, Maggioli, 1996. - Traina 1988
Giusto Traina, Paludi e bonifiche del mondo antico, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1988. - Wheeler 1962a
David L. Wheeler, Land Reform and Reclamation in the Po River Delta, University of Michigan, Unpublished PhD Thesis in Geography, 1962. - Wheeler 1962b
David L. Wheeler, Land Reform in Italy: Progress and Problems, in «Bulletin of the Illinois Geographical Society», 4, 1 (1962), pp. 13-21. - Wheeler 1963
David L. Wheeler, An Experiment in Cooperative Agriculture: The Rice Communities of The Po River Delta, in «Journal of Geography», 62, 7 (1963), pp. 310-316. - Wheeler 1965
David L. Wheeler, Land Reclamation in the Po River Delta of Italy, in «Land Economics», 41 (1965), pp. 376-382. - Wu Ming 1 2024
Wu Ming 1, Gli uomini pesce, Torino, Einaudi, 2024. - Zorzin 2008-2009
Renato Zorzin, “Per terre nuove uomini nuovi”. La propaganda cinematografica dell’Ente Delta Padano, Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea Specialistica in Discipline del cinema, Tesi di Laurea in Cinema europeo (rel. Roy Menarini), Anno Accademico 2008-2009.
Risorse
- Documentario Dall’acqua ai campi, dai campi al silenzio (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=Zb0rRv4tAKM - Documentario Emilia (1951), versione breve
https://footagefarm.com/reel-details/industry/ford/post-wwii---1950-italy--marshall-plan-documentary---emilia#/ - Documentario Emilia (1951), versione completa
https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/1060042596 - Filmati dell’Istituto Luce dedicati ai lavori dell’Ente delta padano
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/search/result.html?temi=%22Ente%20Delta%20Padano%22&activeFilter=temi - La Salina di Comacchio
https://www.salinadicomacchio.it/ - Pagina dedicata al delta del Po, sito Unesco
https://www.unesco.org/en/mab/po-delta
Note
1. Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.
2. https://inflationhistory.com; https://rivaluta.istat.it.
3. https://footagefarm.com/reel-details/industry/ford/post-wwii---1950-italy--marshall-plan-documentary---emilia#/.
4. https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/1060042596.
5. https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/search/result.html?temi=%22Ente%20Delta%20Padano%22&activeFilter=temi.
6. Si veda anche: https://www.youtube.com/watch?v=Zb0rRv4tAKM.
7. https://www.salinadicomacchio.it/.
8. https://www.iucnredlist.org/species/60344/152845178.
9. https://www.unesco.org/en/mab/po-delta; https://whc.unesco.org/en/list/733/.
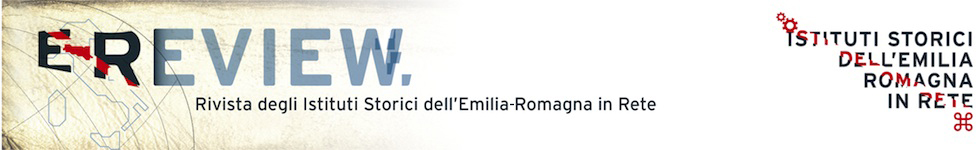
![Fig. 1. Manifesto di propaganda dell’Edp, primi anni Cinquanta. Realizzato da Emidio Adriani. Nell’immagine, all’originario ambiente anfibio, al confine fra terre e acque e costellato da abitazioni in erbe palustri, si sovrimpone ora il nuovo paesaggio agrario, asciutto e ordinato, creato dalle bonifiche della Riforma agraria. In basso a destra è rappresentato uno degli “agenti fisici” di tale trasformazione, ossia un bulldozer. La didascalia enfatizza la futura soluzione del cronico problema abitativo nel delta padano [https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/0500659580].](./sites/default/images/articles/media/326/piastra_delta_01.jpg)
![Fig. 2. Fototeca del Settore patrimonio culturale della regione Emilia-Romagna, Bologna. Lo stand dell’Edp presso un evento pubblico degli anni Sessanta del Novecento. I materiali esposti indicavano i costi e le estensioni delle bonifiche intraprese nel delta del Po durante la Riforma agraria e le rappresentavano cartograficamente [Archivio dell’Ente regionale per lo sviluppo agricolo per l’Emilia-Romagna].](./sites/default/images/articles/media/326/piastra_delta_02.jpg)
![Fig. 3. L’originario programma di bonifica integrale delle valli di Comacchio [Wheeler 1962a].](./sites/default/images/articles/media/326/piastra_delta_03.jpg)
![Fig. 4. Uso del suolo ai primi anni Sessanta del Novecento nella bonifica di valle Pega (Comacchio), drenata durante la Riforma Agraria [da Wheeler 1962a].](./sites/default/images/articles/media/326/piastra_delta_04.jpg)
![Fig. 5. Uso del suolo, ai primi anni Sessanta del Novecento, entro il collettivo risicolo Gea (Jolanda di Savoia), istituito durante la Riforma agraria [Wheeler 1962a].](./sites/default/images/articles/media/326/piastra_delta_05.jpg)
![Fig. 6. Un fotogramma tratto dal documentario americano Emilia (1951), realizzato sotto l’egida dell’Eca. Le valli di Comacchio prima delle bonifiche della Riforma agraria [https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/1060042596].](./sites/default/images/articles/media/326/piastra_delta_06.jpg)
![Fig. 7. Un fotogramma tratto dal documentario americano Emilia (1951). I lavori di bonifica della Riforma agraria nelle valli di Comacchio [https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/1060042596].](./sites/default/images/articles/media/326/piastra_delta_07.jpg)
![Fig. 8. Un fotogramma tratto dal documentario americano Emilia (1951). Un edificio realizzato nel contesto della Riforma agraria nelle valli di Comacchio: il pannello ricorda il suo finanziamento tramite il fondo Lire Erp [https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/1060042596].](./sites/default/images/articles/media/326/piastra_delta_08.jpg)
![Fig. 9. Un fotogramma tratto dal documentario americano Emilia (1951). I terreni bonificati nel territorio comacchiese nel contesto della Riforma agraria e già messi a coltura [https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/1060042596].](./sites/default/images/articles/media/326/piastra_delta_09.jpg)
![Fig. 10. Fototeca del Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, Bologna. La costruzione di un argine, funzionale al confinamento e quindi al drenaggio di un’area umida del delta padano emiliano-romagnolo. Tardi anni Cinquanta del XX secolo [Archivio Ersa].](./sites/default/images/articles/media/326/piastra_copertina.jpg)



