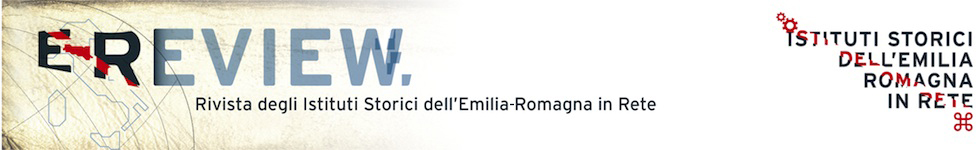Scheda biografica di Franco Piro (pdf)
Si è assistito di recente a una nuova fioritura di studi storici sul “modello emiliano”, con uno sforzo encomiabile di rintracciarne le origini nel lungo periodo. Fra gli esempi da segnalare, nel dicembre 2010 si è tenuto a Palazzo d’Accursio il convegno Bologna Futuro. Socialità, sviluppo, uguaglianza: il “modello emiliano” alla sfida del XXI secolo [De Maria (ed.) 2012], cui hanno fatto seguito un primo approfondimento nell’ottobre 2011, sempre a Bologna [Chiaricati 2012], e un secondo nel maggio 2012, a Modena, presso la Facoltà di Economia “Marco Biagi” [Giordani 2012].
1. Alle origini del “modello emiliano”
Uno studioso che si è particolarmente impegnato nella descrizione e nell’interpretazione del “modello” nella storia d’Italia è Carlo De Maria, secondo il quale le origini sono da rintracciare nelle conseguenze della riforma elettorale del 1889 e nella nuova dinamica fra società civile e rappresentanza politica. Senza alcun dubbio quello fu un crinale di svolta che consente di comprendere una caratteristica essenziale: il “modello emiliano” si è definito, con caratteristiche diverse, nelle fasi di sviluppo, come avvenne durante tutta l’età giolittiana. Tuttavia, pare a me che le caratteristiche principali dell’origine “politica” del modello siano da rintracciare nello sviluppo delle forme associative - il sindacato e la cooperazione, prima di tutto - e successivamente nella “conquista” delle amministrazioni comunali.
Ecco, la prima fase del “modello emiliano” ha avuto una caratteristica fondamentale, determinata dal ruolo “secondario” della struttura politica rispetto a quella sociale. Il partito politico era uno strumento delle associazioni operaie e contadine, la dinamica stessa delle sue decisioni era determinata spesso dall’insieme dei pesi e contrappesi che maturavano nelle organizzazioni sociali. Si viveva un mondo a parte e del resto il cooperatore Giuseppe Massarenti, diventato per questo sindaco di Molinella nel 1906, rivolgeva numerosi appelli ad Andrea Costa per indurlo a lasciare la “palude romana”. Eravamo di fronte alla costruzione del socialismo... in un solo comune!
L’alfabetizzazione di massa, la partecipazione delle mondine al duro lavoro dei campi portava anche il segno della liberazione dei costumi e dell’oppressione delle donne, la cooperativa di consumo serviva a contenere i prezzi, la distribuzione dei farmaci combatteva le malattie della miseria. Qui vi è una particolare caratteristica che distingue nettamente le origini del modello dalla sua evoluzione, anche se un filo rosso ne accompagna tutta la storia: il produttivismo, l’attenzione al lavoro come valore e la convinzione profonda di essere capaci di produrre più e meglio dell’organizzazione capitalistica della produzione. Era quanto Massarenti rivendicava nei confronti di Missiroli. Ma vi era nel vecchio riformismo un primato delle organizzazioni sociali che stride con il primato del partito che si affermò nel secondo dopoguerra. Pur considerando le immense differenze, soprattutto nello sviluppo della società dell’informazione, è del tutto evidente che le esperienze del socialismo prima della guerra producevano un cambiamento profondo che investiva i rapporti economici, sociali, umani. Le “oasi” di socialismo fondavano le diversità del modo di vivere, capace di propagarsi con la forza dell’esempio: un altro mondo era possibile e viveva della sua alterità contrapposta.
2. Il “modello emiliano” nel secondo dopoguerra
Tuttavia le realizzazioni pratiche dell’utopia non avevano retto alle contraddizioni interne, ai settarismi che avevano favorito il fascismo emergente, e poi vittorioso, proprio nelle terre del riformismo. L’analisi di Togliatti era impietosa ma coerente: la mancanza di una direzione politica, l’intransigenza settaria - ma non era stata il pretesto della scissione del 1921? -, la carenza di una visione organica che fosse capace di tenere insieme interessi che potevano contrapporsi, fondavano la riflessione su “Ceto medio ed Emilia Rossa”, avviata nel famoso discorso del 23 settembre 1946. Allora venne dichiarata non solo la strategia delle alleanze ma anche la coesistenza tra la gestione dell’esistente e l’attesa dell’ora X. Qui soccorre una certa visione provvidenzialistica della storia, che tiene insieme una pratica riformistica di controllo dei conflitti sociali all’interno del partito e la visione ideologica del mondo che verrà. Per tutto il dopoguerra il cemento dell’organizzazione di partito si resse su due pilastri: il buon governo e l’attesa della rivoluzione. Il precipitare della situazione internazionale nel 1956 fece intuire la necessità del cambiamento. Diventava sempre più difficile presentare l’Unione Sovietica, che denunciava i crimini di Stalin e poi reprimeva gli insorti d’Ungheria, come “patria del socialismo”. C’era il rischio concreto dell’accorciamento degli orizzonti, con una deriva “riformistica”.
Una prima soluzione a questo dilemma, che provocava forti contrasti, fu nella conferenza del giugno 1959, che in seguito Guido Fanti avrebbe ricordato in termini chiari: in quella occasione «la questione essenziale, certamente generale per tutto il Pci, ma di particolare rilevanza in Emilia, non poteva non essere la piena conquista politica e ideologica dei comunisti, a partire dai gruppi dirigenti, alla via italiana al socialismo» [Fanti 1973]. Secondo Fanti bisognava liberarsi degli ostacoli che frenavano lo slancio al rinnovamento della società. E questi ostacoli consistevano «nel permanere in importanti settori di attività di posizioni riformistiche e massimalistiche». In discussione era «la prospettiva incerta sul modo come accedere al potere, prospettiva dominata per molti anni dall’attesa di eventi risolutivi». I tre ostacoli che Fanti indicava erano:
a) visioni di carattere strumentale nella politica di alleanza verso i ceti medi; b) atteggiamenti che oggettivamente assumono carattere corporativo e di riformismo spicciolo; c) concezioni dell’organizzazione di partito come attività a sé stante e non come il necessario strumento per realizzare la linea politica del partito, alimentando così chiusure conservatrici e settarie, e non favorendo una più adeguata formazione ideologica e culturale dei numerosi quadri [Fanti 1973].
Se si leggono in controluce le parole ovattate dal gergo del centralismo democratico è evidente che la conferenza del 1959 rappresentò un vero e proprio punto di svolta. I ceti medi non erano più visti come oggetti di alleanze strumentali ma come soggetti del programma politico. Come ha scritto Fausto Anderlini [1990], si trattava di un passaggio dalla strategia delle alleanze a quella, più propriamente gramsciana, di blocco sociale.
3. Il “modello emiliano” negli anni del centro-sinistra
Tuttavia, per evitare le tendenze al “riformismo”, il processo doveva essere tenuto saldamente in mano dal partito. Ma, al contempo, il partito doveva evitare le tendenze “conservatrici”, e dunque di mera riproduzione ideologica dei quadri lungo tendenze “settarie”. Che, evidentemente, c’erano. E in che cosa consistevano?
La ferrea disciplina non riguardava solo il legame con l’Unione Sovietica, che veniva presentata come socialismo realizzato. Comportava anche problemi pratici di disciplina del comportamento sindacale. Era in atto in quel momento la grande trasformazione dell’Italia. Specialmente nel settore della piccola impresa e dell’impresa artigiana, nata spesso dai licenziamenti politici dei quadri operai che mantenevano un forte legame ideologico col partito, si era rilevato un fenomeno diffuso. Si trattava della collaborazione sul luogo della produzione che dipendeva in particolare dalla moderazione salariale che il sindacato doveva praticare. Nella conclusione della conferenza emiliana del 1959, Togliatti affermava:
Io inviterei tra l’altro i compagni che guidano il lavoro sindacale a considerare con una certa attenzione il problema, cui si è accennato, della posizione che i sindacati devono prendere nelle lotte del lavoro rispetto al piccolo artigiano, che si serve di due o tre operai e naturalmente non è paragonabile al grande capitalista. Riconosco che si tratta di un tema difficile. Ma se i dirigenti dei sindacati lo considerassero con una certa attenzione forse potrebbero trovare delle soluzioni [Togliatti 1974].
Si può immaginare quale effetto moltiplicativo di adesioni poteva determinare questo modo di utilizzare il sindacato come cinghia di trasmissione non verso il lavoratore dipendente ma verso gli imprenditori interessati. Il sindacato dunque doveva tener conto della natura dell’impresa che, se piccola, diventava per definizione antimonopolistica. Ben prima del “piccolo è bello”, che Ernst Schumacher pubblicò nel 1972, si teorizzava una dimensione della collaborazione nella piccola impresa. Quali erano le conseguenze sui lavoratori?
Dietro le parole di Togliatti si individua una tendenza che pochi anni dopo venne resa esplicita da una ricerca di Camillo Daneo [1967], allora responsabile dell’Ufficio studi della Camera del lavoro di Bologna. In questa ricerca si faceva osservare che l’Emilia Romagna aveva salari inferiori del 5,7% alla media nazionale e dell’11,5% rispetto alla media dell’Italia settentrionale. Certamente il dato era figlio della debolezza del sindacato in un’area produttivamente frammentata. Ma non era solo un fatto oggettivo. C’era anche una volontà soggettiva che sacrificava il salario diretto nella strategia delle alleanze. Questo era possibile se il salario indiretto, sotto forma di servizi, veniva integrato e se esistevano altre forme di reddito integrativo. La composizione della classe operaia risentiva necessariamente di processi di trasformazione che mantenevano comunque un forte legame con la terra (apparivano allora le prime ricerche sui “metal-mezzadri”). Come scrisse con una frase felice Ezio Raimondi, «gli operai ancora odorano di farina».
Tuttavia, il Pci si fece interprete di un meccanismo che traeva dalle antiche condizioni mezzadrili sia una propensione imprenditoriale nei ceti medi urbanizzati, sia un legame per quale il salario non era l’unico reddito degli operai. Nelle fasi più intense del lavoro dei campi, quando si trattava di grano, di barbabietole o di uva, si assisteva a picchi di assenteismo largamente tollerati e concordati. Il basso livello dei salari non dipendeva solamente dalla struttura sociale. Un grande economista, particolarmente impegnato in quell’epoca nel sostenere l’insufficienza della domanda aggregata, richiamava l’attenzione su una circostanza qualitativa. La media dei salari era più bassa non solo rispetto al triangolo industriale, ma anche rispetto alla Toscana e al Veneto, dove - specialmente nell’ultimo caso - la struttura produttiva era analoga [1]. Da questi dati Beniamino Andreatta traeva la conclusione che il sindacato aveva una scarsa autonomia.
Qual’era la base sulla quale si poteva estendere il consenso? La conferenza del 1959 si svolse in un momento decisivo dell’evoluzione del quadro politico. La destalinizzazione aveva illuminato pagine buie. La denuncia dello stalinismo al XX Congresso del Pcus e la successiva invasione dell’Ungheria avevano aperto anche in Italia una fase nuova. Negli enti locali i rapporti si erano fatti difficili. La contrapposizione con Dossetti nelle elezioni del 1956 venne superata recuperando nuovi modelli di partecipazione, con il decentramento amministrativo. Ma, soprattutto, occorreva adottare una nuova politica di spesa ed era per questo che nella presentazione del nuovo piano di sviluppo di Bologna, approvato il 5 aprile del 1963, si annunciava, per la prima volta, il deficit di bilancio. Tutto questo era reso possibile dal nuovo clima creato con il centro-sinistra, che aveva allentato i vincoli amministrativi che costringevano al pareggio e comportavano forme di disciplina tese ad evitare intrusioni del governo centrale. Fanti aggiungeva:
Ci è sembrato di dover dare un incremento alla spesa pubblica locale nei settori dinamici. Ciò è da un lato ineccepibile teoricamente; il finanziamento in deficit, come è chiamato dalla moderna letteratura economica, è uno strumento riconosciuto come fattore di sostegno e di sviluppo e tale è del resto la politica finanziaria dello stato italiano.
Questo è un punto centrale. L’espansione dei servizi - ed in qualche caso la loro demagogica gratuità - fu possibile nel quadro nuovo garantito dal centro-sinistra, che ridusse notevolmente i poteri centrali sugli enti locali, fino a giungere all’istituzione delle Regioni. Il salario indiretto e dunque la minore pressione sul salario di impresa rappresentavano un potente fattore di coesione sociale, poiché innestavano su un quadro nuovo le antiche tradizioni: si assisteva a un’espansione dell’occupazione femminile, si mantenevano le condizioni competitive di costi del lavoro più bassi, si favoriva la creazione di una rete di infrastrutture che aumentava la produttività media del sistema regionale. Altrove ho scritto che «è la politica dell’Ente locale, specie per ciò che attiene all’erogazione di salario sociale sotto forma di servizi, che consente una minore pressione dei bisogni operai sul profitto di impresa» [Piro 1976].
4. Il “modello emiliano” nella crisi degli anni Settanta
All’inizio degli anni Settanta il “modello emiliano” conobbe il suo apogeo. Mentre sulle grandi fabbriche cresceva la pressione salariale, l’Emilia era pronta a ricevere il suo decentramento produttivo. La nuova organizzazione della grande impresa era una vera e propria delocalizzazione e provocò una grande discussione. Esemplare fu l’analisi del decentramento compiuto dalla Fim-Cisl [1974] - e nel sindacato bolognese l’apporto più penetrante venne dato da Claudio Sabbatini [Baldissara e Pepe 2010] - che però aveva un forte limite: si insisteva sulla subordinazione della piccola impresa alla grande e non si coglieva appieno che esisteva da tempo una struttura produttiva che autonomamente era in grado di conquistare mercati internazionali [2]. In generale veniva sottovalutato anche il ruolo politico delle imprese cooperative, che sovente erano considerate residuali e non protagoniste.
Tuttavia, il sistema funzionava fino a quando il capitalismo italiano si espandeva. La doppia pressione sui salari e sulle materie prime e il venir meno della stabilità monetaria dopo l’inconvertibilità del dollaro nel 1971 avevano creato una situazione nuova. Dopo che Berlinguer enunciò la teoria del “compromesso storico” e quella dell’“austerità”, che era cosa ben diversa dalla “società diversamente ricca” di cui parlava Riccardo Lombardi [Patrignani (ed.) 2012; Ventura 2012], il Pci inaugurò a livello nazionale la politica delle “larghe intese”, delle quali i comunisti emiliani erano stati antesignani.
Il 1975 segnò il trionfo elettorale e politico del Pci con la conquista del predominio a livello regionale. Nell’anno successivo il consenso aveva riguardato un terzo dei cittadini nelle elezioni politiche nazionali, tanto da far dire ad Alberto Asor Rosa che Turati e Lenin erano ormai nello stesso partito [3]. Forse non era davvero così. Ma il “compromesso storico” sembrava una strategia capace anche di contenere le aspirazioni sociali la cui mancata soddisfazione poteva in fondo essere scaricata sulle altre forze con le quali si contraeva il patto. In quel momento, soccorreva l’esperienza storica del “modello emiliano”, con la sua pratica consociativa.
Sta di fatto che il modello si affermò proprio in contrapposizione alla crisi che investiva il sistema nazionale, e che nella contrapposizione faceva crescere beni pubblici, come i servizi sociali, e beni relazionali che si nutrivano della “diversità”. Quel che successe con l’ingresso del Pci nell’area di governo fu che sembrò esaurirsi la rendita di posizione derivante alla politica regionale dalla critica alla politica nazionale. Adesso la virtù e il vizio non potevano facilmente essere ricondotti agli schemi tradizionali.
Contemporaneamente la spinta all’urbanizzazione e le stesse trasformazioni del settore produttivo facevano emergere nuove figure di ceti medi intellettuali che non avevano la stessa radice, la stessa provenienza sociale dei ceti medi produttivi. E inoltre il sistema, anche quello regionale e non solo quello nazionale, produceva la marginalizzazione degli strati sociali che non avevano rappresentanza nelle organizzazioni tradizionali. Perciò alcuni intellettuali - come Federico Stame, Vittorio Boarini, Salvatore Sechi - si espressero con toni critici.
Poi le cose precipitarono. L’11 marzo 1977 venne ucciso Francesco Lorusso, il 14 si svolsero i suoi funerali in periferia, il 16 marzo la manifestazione istituzionale in piazza Maggiore fu imponente ma si svolse senza dare la parola a Giovanni, il fratello di Francesco. E molti giovani si allontanarono sotto i portici, segnando una profonda divisione che sembrava consegnare un tragico dilemma: le istituzioni potevano diventare asfittiche e chiudersi in se stesse; i movimenti potevano diventare impotenti e rifluire verso le soluzioni più disperate. Pochi mesi dopo, a settembre, Bologna fu in grado di accogliere il dissenso politico. In quella vicenda fu importante l’apertura manifestata dal sindaco di Bologna, Renato Zangheri. Era chiaro che si era aperta una crisi profonda e quella crisi andava analizzata, compresa e interpretata.
5. Il convegno del Psi sul “modello emiliano”
Il Partito socialista ritenne di organizzare una riflessione ampia e una parte degli atti furono poi raccolti in un volume [Babbini e Ferrarini (eds.) 1979]. Il convegno si svolse nell’ottobre del 1978 e riprendeva temi e problemi presentati in una pubblicazione periodica della Federazione bolognese del Psi [4]. La critica socialista muoveva dal tentativo di superare le contrapposizioni che erano venute delineandosi nell’analisi del modello. Da un lato, l’interpretazione trionfalistica tipica del Pci, e dall’altro l’interpretazione pauperistica tipica della nuova sinistra [5]. L’analisi trionfalistica aveva «messo in evidenza i dati relativi al reddito familiare medio, all’aumento dell’occupazione (compresa quella femminile), alla capacità della struttura imprenditoriale locale (piccole e medie aziende, tessuto cooperativo) di far fronte agli effetti della crisi economica, alla flessibilità della forza lavoro e delle imprese di fronte all’evoluzione della domanda, alla migliore qualità della vita, alla spinta keynesiana dell’ente locale». A essa si contrapponeva l’analisi pauperistica che metteva «l’accento prevalentemente sugli aspetti negativi dell’esperienza emiliana: debolezza strutturale delle micro-imprese, subordinazione al grande capitale nazionale e straniero, sfruttamento, lavoro nero, politica sindacale degli sconti».
Quali erano le evidenze che ne discendevano? L’alleanza coi ceti medi era stata favorita da un’espansione economica che aveva allargato i consumi sociali in forma aggiuntiva e la mediazione fra i diversi strati sociali andava in crisi quando vacillava la sua base, cioè l’espansione economica ininterrotta. Ci voleva dunque una maggiore considerazione per i beni pubblici. Negli enti locali emiliani si era realizzato il centro-sinistra, tramite 1) la politica urbanistica che era stata vincolo e salvaguardia piuttosto che realizzazione e attuazione; 2) la politica di intervento nei settori economici «oscillante tra il faticoso tentativo di realizzare alcune strutture portanti e non solo infrastrutture serventi» e le tendenze «ad accogliere tutte le richieste corporative attraverso contributi a pioggia»; 3) lo sviluppo, soprattutto quantitativo dei servizi sociali, con il blocco delle tariffe per tutti gli utenti e non solo per i ceti più deboli, favorendo aggregazioni burocratiche dietro l’intervento sociale territoriale; 4) la politica istituzionale che contrastava il centralismo della legislazione ma poi lo riproduceva a livello locale.
Il rapporto con l’ambiente era affrontato con grave ritardo, mentre il territorio regionale subiva un grave dissesto idrogeologico. Infine, un riflesso particolarmente negativo proveniva dalla tendenza conformistica e dalla riproduzione ripetitiva di tradizionali eventi, cioè «dalla staticità che si determina[va] in particolare per quanto riguarda[va] gli aspetti innovativi, di sperimentazione sociale e di elaborazione culturale». La critica diventava quindi esplicitamente politica:
Il Pci nella sua cultura politica stenta ad affrontare i problemi del nuovo tipo di conflitto sociale e urbano in una società a capitalismo maturo e dei nuovi e diversi soggetti di questo conflitto. Di fronte allo squilibrio tra domanda della società civile e offerta delle istituzioni [...], di fronte all’esplosione delle contraddizioni, il Pci tende a bloccarle, a impedirne il riprodursi nel sociale, non a risolverle e a mediarle in positivo.
Il rischio dunque era che a un partito forte corrispondessero istituzioni deboli. Il conflitto, mediato all’interno del partito, rischiava di riprodursi nella società ad un livello allargato e non comprimibile.
Si è tentato cioè da parte del Pci, in questi ultimi anni, di disciplinare dall’origine l’esprimersi dei soggetti sociali e delle nuove spinte conflittuali. E questo può avvenire solo nel centralismo del partito in cui vengono pericolosamente convergendo e unificandosi Stato e società.
In buona sostanza, la critica socialista riguardava l’immobilismo che si determinava per il riflesso conservatore che derivava alla società regionale dalla riconduzione alle mediazioni interne a un partito, o, date le “larghe intese”, al sistema dei partiti, delle nuove dinamiche dell’economia e della società. Secondo me, la critica coglieva nel segno. Nella società che si modificava venivano alla luce nuovi soggetti che non si riconoscevano né nelle consolidate alleanze, né nel blocco sociale, né nel sistema dei partiti.
L’esplosione dell’università di massa faceva emergere strati intellettuali di tipo nuovo, più legati alla società dei servizi e anche refrattari alla burocratizzazione. Nell’anno di prima operatività degli accessi (1969) l’Università di Bologna aveva meno di trentamila iscritti. Nell’anno accademico 1976-77 gli iscritti erano diventati sessantamila. La questione giovanile e la questione meridionale apparivano insieme, in forme conflittuali con la memoria tradizionale.
Contemporaneamente, l’analisi dei comportamenti elettorali compiuta da un dirigente socialista mostrava che i ceti medi avevano ormai una funzione decisiva nella dinamica elettorale di Bologna e della regione [Degli Esposti 1976]. E quindi si doveva presumere che erano in atto profonde modificazioni nella struttura economica. Non era vera l’ipotesi del decentramento produttivo come semplice manifestazione di arretratezza alla ricerca di bassi salari e minore conflittualità sociale. Emergeva un tessuto sociale di imprenditori che contribuivano all’integrazione sociale e che avevano ormai un loro ruolo autonomo nel mercato nazionale e internazionale.
La circostanza veniva sottolineata da Vittorio Capecchi [1980]:
L’elevatissimo saldo positivo della bilancia commerciale con l’estero [...] indica chiaramente quale sia l’orientamento delle attività produttive e come negli ultimi anni vi sia stato un mutamento qualitativo rilevante nei tipi di prodotti esportati: mentre infatti nel 1963 l’Emilia Romagna esportava soprattutto prodotti a bassa tecnologia (maglieria e prodotti agricoli) nel 1976 i primi due prodotti esportati sono quelli dell’industria metalmeccanica (caldaie e macchine meccaniche, vetture auto e trattori).
Il ruolo delle piccole imprese nel mercato internazionale era sostanzialmente sottovalutato. In seguito, gli studi di Sebastiano Brusco [1980; 1982] mostrarono la forza del distretto industriale come molla autopropulsiva dello sviluppo.
In una certa misura, la critica socialista apriva la strada a una maggiore comprensione di fenomeni nuovi. Alla fine di un corposo saggio, Franco Degli Esposti e Mauro Gori [1979] scrivevano: «può risultare proprio il ceto politico conservatore dei partiti di sinistra un elemento di freno delle trasformazioni sociali della nostra regione». I due dirigenti socialisti vedevano ritardi di un ceto politico incapace di capire le nuove dimensioni con le quali bisognava misurarsi, innanzitutto la crescente integrazione europea.
Certo, l’egemonia del Pci era stata perseguita con un modello nazionale e con gli ancoraggi tradizionali che a poco a poco si erano venuti orientando verso il miraggio dell’eurocomunismo. Ma Carrillo e Marchais c’entravano poco con Bologna. In Emilia si perseguiva più concretamente la ricerca di legami con le socialdemocrazie europee. Era il sindacato tedesco a far parte dell’azionariato dell’Unipol. Se il Pci aveva interamente compiuto la sua trasformazione da partito ideologico a partito gestore della mediazione fra gli interessi, era inevitabile ricercare rapporti con le socialdemocrazie europee, un tempo vituperate.
Nella critica di Togliatti al riformismo, pur nella profondità dell’analisi, vi è l’incapacità di cogliere la differenza principale tra riformismo socialista e riformismo comunista, vale a dire il diverso modo con cui affrontare il problema del potere. La critica di Togliatti al riformismo, nei suoi elementi principali del localismo o particolarismo e del settarismo, ne coglie i limiti, ma ne trascura un valore di fondo, che è quello di vedere il problema della conquista del potere collegato alla trasformazione del potere dal basso. [Babbini e Ferrarini 1979, 53]
In questo senso, il pragmatismo del Pci regionale superava il rischio del localismo che si rintracciava nelle esperienze municipalistiche dell’antico riformismo socialista. Ma trascurava le esperienze di base, la spontaneità dei movimenti, le realizzazioni pratiche che nel riformismo socialista trovavano risposte mentre nella tradizione comunista venivano guardate con diffidenza. Oggi, porre i problemi in questi termini può sembrare tipico di una microstoria delle subalternità, salvo scoprire poi, di tanto in tanto, che anche gli sconvolgimenti elettorali più recenti sono nati in questa regione e la loro successiva affermazione ha colto di sorpresa.
In termini diversi, capitò anche allora di veder contrapposte le due società, quella garantita e quella non garantita. In uno dei notevoli contributi posto all’attenzione del convegno dell’ottobre 1978 si scriveva:
Il ’68 è un fenomeno nazionale [...] e di fronte ad esso la “via emiliana” può ancora far valere la carta della sua “diversità”, dimostrando di essere in grado di assorbirlo [...]. Il fatto è che il Pci, ancora schierato all’opposizione, può seppur cautamente associarsi alla contestazione o almeno non deluderla scopertamente [...]. Il ’77 è invece un fenomeno soprattutto “nostro”: per la prima volta nella storia sociale emiliana, è avvenuta una immigrazione e una concentrazione di lavoratori; non cambia sostanzialmente il fenomeno, anzi lo rende più esplosivo, il fatto che si tratti di lavoratori della fascia intellettuale, e per di più dell’ultima generazione, pieni quindi di utopia, di esuberanza, di temerarietà. Tutta la realtà sociale, economica culturale della nostra città è impreparata ad accogliere, a dialogare con loro, a comprenderli, anche per la buona ragione che essi [...] hanno assunto modelli addirittura postindustriali. Altro che la paciosità, la saggezza contadina, il buon senso dei nostri costumi atavici. Inevitabile quindi lo scontro, la crisi di rigetto da parte della comunità cittadina nei confronti di questa comunità di vasto respiro culturale, addirittura allineata su schemi internazionali. È inevitabile anche che i giovani se la prendano in primo luogo con il Pci, in cui vedono la forza che ha ereditato in tutto e per tutto l’ambito emiliano di ritardo paleo umanistico, di agio affabile, di ideologia del benessere e dell’efficienza, ma a beneficio esclusivo degli inseriti, cioè in pratica della comunità che da sempre vive sul nostro territorio sfruttandone le buone opportunità. Oggi ci stiamo persuadendo che il futuro non sarà più della grande industria ma [...] si assisterà allo sviluppo di industria di piccole dimensioni versate nel settore della tecnologia “soffice” e altamente sofisticata di specie elettronica: le piccole imprese emiliane domani potrebbero trovarsi all’avanguardia, e quindi costituire un modello. [Barilli, Colombari e Emiliani 1979]
La critica al “modello emiliano”, all’inizio mal tollerata, produsse l’effetto di una salutare riflessione. Sarebbe impossibile dar conto di tutti gli aspetti che furono messi in luce [Bonora e Giardini 2003]. Comunque, nelle elezioni politiche del 1987 divenne palese che gli incrementi del Psi erano «molto correlati, seppure meno che proporzionalmente, con le perdite comuniste» - come si legge nell’analisi più ampia compiuta sull’intero ciclo elettorale nella regione rossa [Anderlini 1990, 222-3].
Dietro quei dati, evidentemente, c’erano tendenze ravvisabili nel ciclo politico nazionale. Tuttavia, emergeva una difficoltà del partito comunista dell’Emilia Romagna a ricondurre alla continua espansione elettorale, come era stato negli anni Settanta, le nuove tendenze sociali che si erano delineate negli anni Ottanta. Con qualche ingenuità pretendevo allora che “la socialdemocrazia orientale” diventasse effettivamente capace di trasformarsi, per contrastare le tendenze altrimenti disgregatrici del “capitalismo reale”. Così Michel Rocard aveva enunciato un paradosso: certi partiti comunisti erano stati quelli più vicini alla socialdemocrazia di tipo tedesco nell’Europa meridionale. O, come diceva Antonio la Forgia nel 1980, «l’intervento a Bologna è stato a valle dello sviluppo e nel migliore dei casi ha cercato di correggerne gli effetti, non di incidere per contribuire a crearne uno diverso» [Piro 1983, 13].
In fondo, la critica del modello riproponeva un’antica questione: si possono immaginare le trasformazioni sociali necessarie, nella gestione pur avveduta dell’esistente?
Bibliografia
- Anderlini F. 1990
- Terra Rossa. Comunismo ideale socialdemocrazia reale. Il Pci in Emilia Romagna, Bologna: Istituto Gramsci
- Babbini P. e Ferrarini G. 1979
- Riformismo socialista e riformismo comunista. Analisi critica del modello emiliano, Milano: Sugarco
- Baldissara L. e Pepe A. 2010
- Operai e sindacato a Bologna. L’esperienza di Claudio Sabattini (1968-1974), Roma: Ediesse
- Barilli R., Colombari L. e Emiliani A. 1979
- La cultura in Emilia tra tradizione e dissenso, “La Squilla. Quaderni”, 14-15
- Bonora P. e Giardini A. 2003
- Orfana e claudicante. L’Emilia postcomunista e l’eclissi del modello territoriale, Bologna: Baskerville
- Brusco S. 1980
- Il modello Emilia: disintegrazione produttiva e integrazione sociale, “Problemi della transizione”, 5
- Capecchi V. 1980
- Lavoro e condizione giovanile, “Problemi della transizione”, 4
- Chiaricati F. 2012
- Il “modello emiliano” nella Storia d’Italia, “Storia e Futuro”, 28
- Conti S., Lungarella R. e Piro F. 1979
- L’economia emiliana nel dopoguerra, Venezia: Marsilio
- Daneo C. 1967
- Livello e andamento dei salari in Emilia Romagna, Bologna: Camera del lavoro
- Degli Esposti F. 1976
- Voto e classi sociali: un esame della realtà emiliano-romagnola negli anni ’70, Bologna: La Squilla
- Degli Esposti F. e Gori M. 1979
- Classi sociali e politica delle alleanze nel dopoguerra emiliano, “La Squilla. Quaderni”, 14-15
- De Maria C. (ed.) 2012
- Bologna futuro. Il “modello emiliano” alla sfida del XXI secolo, Bologna: Clueb
- Fanti G. 1973
- Il partito in Emilia, “Critica marxista”, 5-6
- Fim-Cisl 1974
- Piccola azienda, grande sfruttamento. Note sul decentramento produttivo, Verona: Bertani
- Giordani S. 2012
- Ancora sulle tracce del “modello emiliano”, “Storia e Futuro”, 29
- Patrignani C. (ed.) 2012
- Diversamente ricchi. Via d’uscita da un modello di società creato dal neocapitalismo finanziario, Roma: Castelvecchi
- Piro F. 1976
- Utopia e realtà del modello emiliano, “Quaderni del territorio”, 2
- Piro 1983
- Comunisti al potere. Economia, società e sistema politico in Emilia Romagna, 1945-1965, Venezia: Marsilio
- Prodi R. 1966
- Modello di sviluppo di un settore in rapida crescita. L’industria della ceramica per l’edilizia, Milano: Franco Angeli
- Prodi 1977
- L’economia emiliana: un modello di industrializzazione con larga pluralità di protagonisti, “I mesi”, 2
- Sechi S. 1978
- Il Pci e le contraddizioni del suo blocco sociale in Emilia, “Unità proletaria”, 3
- Togliatti P. 1974
- Politica nazionale e Emilia rossa, a cura di Arbizzani L., Roma: Editori Riuniti
- Ventura A. 2012
- La trappola. Radici storiche e culturali della crisi economica, Roma: L’asino d’oro
Note
1. Relazione di Beniamino Andreatta all’Unione regionale delle Camere di commercio, 13 maggio 1965. Cfr. anche Piano di Sviluppo dell’Emilia Romagna, proposto dal Comitato Regionale della Dc, Roma 1968, p.16.
2. Io stesso ho sottovalutato questo problema: si veda, oltre a Piro 1976, anche Conti, Lungarella e Piro 1979. Il caso più evidente di autonomia dei futuri distretti industriali è quello delle ceramiche, già descritto da Prodi 1966, e poi ripreso in Prodi 1977.
3. “L’Unità”, 25 giugno 1976.
4. “La Squilla. Quaderni”, in particolare n.1, Bologna. Economia e territorio; n.3, I fatti di Bologna:perché?; n.4, La sinistra e il dopo settembre; n.6, Trent’anni di politica urbanistica; n.9-10, Progetto socialista e modello emiliano.
5. Le due interpretazioni vennero delineate da Sechi 1978, in un saggio poi pubblicato anche come introduzione a Conti, Lungarella e Piro 1979.