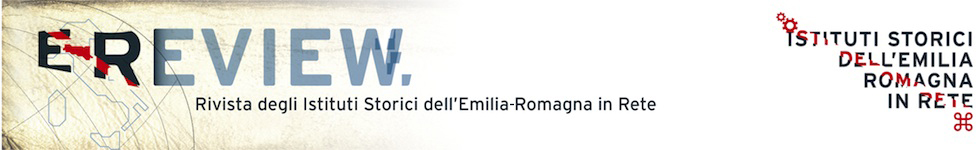[[figure caption="Foto di Emanuele Torti" align="right" width="400px"]]articles/media/51/trapani_2014_01.jpg[[/figure]]Cent’anni dalla Prima grande guerra, però, sono proprio tanti. Per i tedeschi forse troppi, evidentemente, perché appunto quel capitolo in Germania non si vuole ricordarlo appieno. Strano ma vero! La pretesa sarebbe, più che altro, di avere uno sguardo oggettivo sul passato, eventualmente motivati nell’orizzonte di un triennio tra l’altro importante (come per l’Italia) che però sta assorbendo tutti sul fronte della Seconda grande guerra con un maggior piglio, certamente motivato. Tuttavia anche la Prima guerra mondiale ha impresso un marchio indelebile sul cuoio di questa Europa, lasciando tutto pronto per la Seconda. Era dunque lecito sperare in un degno ricordo: cento anni! E giacché un giubileo più si attempa e più ci si crede, noi ci credevamo almeno nel centenario. L’ultima speranza utile pareva la Sessantaquattresima Berlinale inaugurata nel febbraio scorso, nelle cui sezioni si è cercato di carpire il barlume di un intento, senza trovarne riverberi neanche tra i sott’intesi: Il Festival di Berlino nel centenario è scivolato su quelle pagine storiche, come il pittore Emilio Vedova ebbe a dire, «sarebbe passato incolume su ‘sta merda di mondo’». La questione è dirimente: di questa storia si vuol veramente far giubileo? Per l'Europa c’è ben poco da festeggiare del suo declino. Il ricordo tuttavia serve sempre, specie alla Storia. Sennò, perché all’esame di maturità ci facevano studiare fino alla Prima grande guerra e mai - tranne qualche dispensa fotocopiata dell’ultimo minuto - la Seconda grande? La Prima guerra mondiale che scoppiò nell'estate del 1914 può essere considerata gloriosa alla luce di alcune singole nazioni e del loro irredentismo che, come per l'Italia, portava a compimento il Risorgimento; ma fu davvero funesta per i destini della civiltà. Dalla Prima guerra mondiale ebbe origine il nazismo, mentre da noi nacque il fascismo. Con la Prima guerra mondiale cominciò il tramonto delle potenze europee, comprese le vincitrici in ambedue i conflitti mondiali. E divampò quella guerra civile europea, come la chiamò Nolte, che dilaniò l'Europa e finì col 1945 (pregiudizi a parte). Da qui fu un susseguirsi di effetti in effetti, generati da cause su concause belliche, incominciate prima del 1914 in una preistoria che poi si eclissò dovutamente, portando alla polverizzazione dell'homo europeus col proletario e l'homo sovieticus; le folle nazionalsocialiste e fasciste dell'homo ideologicus; le masse consumiste dell'homo americanus; e quelle autarchiche dell’homo asiaticus, che si è comprato i debiti pubblici «au début du siècle chinois». E tutto questo si ricorda solo in sé senza ciò che l’ha approvvigionato? Pare impossibile, vero? Un universo d’immagini e produzioni cinematografiche documentarie sulla prima Guerra mondiale, da fare impallidire, rigettate tutt’al più non solo dall’intera Berlinale, ma anche dalla stupenda sezione chiamata Retrospektive, diretta da Rainer Rother, che avrebbe potuto farci sognare. E invece quasi apposta - ci viene di ragionare a rischio d’illazione - ha estromesso ogni barlume irritando pure, fin dal titolo solo evocativo Aesthetics Of Shadows 1915 – 1950, colpendo e affondando l’intero doppio arco bellico: da leccarsi le dita… Incoraggiati e illusi, invece, quando dal polverone (amaro) emergevano solo due titoli datati ma innocui dagli anni deputati (tra titoli ancora più innocui): The Cheat (1915) e Blind Justice (1916), rispettivamente dagli USA e dalla Danimarca. Punto! E dalla Seconda guerra mondiale nella stessa sezione? Che domanda retorica. Risposta: un tripudio di presenze, anche d’attualità filmiche e documentarie di allora: Air Force (USA 1943); The War at Sea from Hawaii to Malay (Giappone 1942), per citare i più importanti e avvincenti anche, con le loro retoriche belliche di pura ideologia. La Germania stessa a questa Berlinale s’è estromessa, leziosa e ospitale spingendoci a riderne, come con il concierge lecchino del film che ha aperto quest’ultima edizione The Grand Budapest Hotel, tale Monsieur Gustave, interpretato da Ralph Fiennes e diretto da Wes Anderson, sempre a ridosso della Seconda guerra mondiale con i nazisti; che sono da sempre qui il trampolino della presa di coscienza tedesca al festival del politicamente corretto. Il racconto del Budpest Hotel è di Stephan Zweig, che guarda caso occulta la Germania scomparsa all’orizzonte di Budapest, trucca i nazisti lasciandoceli intuire senza chiamarli tali (evviva le allegorie) per un padrone di casa, tenuto a dare il meglio nella logistica e tutto lo spazio politico al resto, piuttosto che al dovuto in questo 2014 del centenario. Ma Zweig è morto nel 1942, avesse saputo… Caro presidente della Berlinale, Dieter Kosslick, come va letta questa mossa? È vera incuria? Dobbiamo crederci? Lei che per anni ha portato la sciarpetta rossa alla Benigni davanti a tutte le telecamere del pianeta? Lei che è il direttore del festival del cinema più grande e importante d’Europa (specie per cittadini di lingua tedesca in questo continente) come mai ha omesso la Prima grande guerra? Anche alla conferenza stampa di gennaio, prima del festival, proprio lei Kosslick (l’ho creduta ironico) ha fatto cadere a tutti le braccia, quando a domanda diretta, da parte di una giornalista sua connazionale, ha dato risposta altrettanto diretta e galvanizzante: «non ci siamo affatto preparati!» (a parlare di Prima grande guerra). Forse perché manca il materiale filmico? Un quesito che non meriterebbe risposte, se non per dovere di cronaca. Certo che c’è tanto materiale, non lo si appronta da un anno all’altro, ma ci si stava nel centenario. Come fa da anni il Festival di Cannes, se non ci sono film recenti su un tema nazionale, a corollario il buon vecchio Jill Jacob organizza giornate della critica intorno al tema dentro il festival stesso, con tutto quello che si trova di artisticamente in giro. E poi, veramente nessuno gira film sulla Prima guerra mondiale? Steven Spielberg nel 2011 presentò, non alla Berlinale, il mediocre War Horse: sorta di Furia Cavallo del West a colori ma con la guerra in corso. Prima ancora uscì, tratto dal celebre romanzo di Ian McEwan, diretto da Joe Wright, Espiazione (2007) con la medesima guerra a far da sfondo a un tragico amore tra un’aristocratica britannica e il suo coetaneo giardiniere, entro il più sociologico binario in corsa del lento declino di un’inutile aristocrazia, incapace di accorgersi della rampante ascesa culturale delle classi fino a quel momento considerate basse; un film dei primordi, base forse per le più celebri quattro serie inglesi di Downton Abbey (dal 2010).
Si fosse fatto prestare Rother dal Toronto Film Festival Passchendaele (2008) di Paul Gross, tra l’altro mai uscito in Europa, quantomeno non avrebbe dato adito alle accuse di una presunta voluta omissione del tema. Vi si racconta la battaglia di Passchendaele del 1917, dove ci fu una massiccia offensiva delle truppe alleate canadesi e britanniche guidate dal generale Douglas Haig contro l'esercito tedesco. Ostacolate nell'avanzata dalle pessime condizioni del terreno, trasformatosi per le piogge in un mare di fango, le truppe alleate furono sottoposte all'incessante fuoco di sbarramento tedesco e ai gas tossici. La battaglia, che si concluse agli inizi di novembre con l'inutile presa del villaggio ormai distrutto di Passchendaele, costò la vita a circa 300.000 soldati alleati. Volendo andare fino in fondo, il limite che trapela da tutto ciò è di carattere sociologico. La società tedesca da sempre impegnata nella rimozione degli eventi legati al nazismo hitleriano, ha un’immagine della guerra piuttosto particolare. Aldilà delle cause e delle colpe ormai centenarie di quel primo conflitto, i tedeschi non lo trovano dirimente in sé, quanto una sorta di primo capitolo propedeutico ed essenziale per continuare a parlare del secondo. In fondo è vero: gli esiti e la crisi umilianti seguiti a quella prima sconfitta generarono le ignominiose conseguenze per l’avvicendarsi sul piano politico di una terribile dittatura, il cui ricordo è equiparabile a un’ossessione. Dentro questa ossessione non può esserci spazio per analisi storiche ulteriori, non c’è più nulla da carpire del primo conflitto, visto che tra l’altro la storiografia nazionale tedesca ha ben affrontato e riletto il blocco relativo al 1914 – 1918, lasciando aperti ben pochi quesiti. Semmai risolvibili con l’analisi ancora in atto della Seconda guerra mondiale. Per noi, però, questa voluta mancanza di ricordo in terra tedesca ha il peso negativo della trascuratezza e insieme del paradosso. Perché se è vero quanto detto, sarebbe stato altrettanto utile per un continente come quello europeo, coagulatosi ormai politicamente ed economicamente e in preda alla crisi, ritrovarsi al festival tedesco a evocare attraverso il cinema una tragedia immane incominciata cento anni or sono, nella quale sono morti maciullati milioni di soldati.
Il clou della Storia non esiste perché esiste tutta la Storia. Tant’è che a quest’ultima Berlinale, colmo dei colmi - non ci resta che prenderne ironicamente atto - sono passate tutte le guerre importanti, (ma proprio tutte, anche la seconda guerra cecena del 1999 col film Macondo in concorso, diretto dall’iraniana Sudabeh Mortezai) tranne la Prima guerra mondiale. Iniziamo dal profondo e incredibilmente analitico film del francese Yann Demange ’71 ambientato nell’Irlanda del 1971, appunto, durante la guerra civile tra protestanti e cattolici. Il film - acquistato da un distributore italiano - uscirà presto in Italia e ha un gran valore non solo artistico quanto di significato poiché accusa tutta la guerra, dalla cui inutilità continuano a generarsi mostri di violenza non solo fisica ma anche dirimenti per l’identità di una cultura, spinta così alla paranoia e soprattutto a dividersi tra posizioni contrapposte. Nel concorso c’era poi The Monuments Men di George Clooney e non si capisce come mai. Il film che ha unito all’unisono la critica nel farsi definire «inguardabile», «ridicolo», «sciatto» .... Peccato, perché la storia, quella vera da cui è tratto deve essere stata avvincente; triste che a ricordarcela sia un’opera talmente incresciosa e imbarazzante nel suo esserlo, da non meritare nessuna indulgenza (meno che meno dal pubblico). Un gruppo di critici d’arte, negli ultimi due anni della Seconda guerra mondiale, coordinato dal professor Frank Stokes (George Clooney) ha il compito di salvare e recuperare tutte le opere d’arte che i nazisti hanno rastrellato dai paesi occupati, tra Francia, Italia e Polonia. Il richiamo dei colleghi al servizio da parte di Stokes è il seguente: «se un morto vale molto di più di un’opera d’arte distrutta, è anche vero che noi la guerra la stiamo combattendo per salvare le origini della nostra cultura». Se chi il film l’ha confezionato avesse realmente dato peso a questa bella frase, non ci avrebbe certamente consegnato una sceneggiata con errori storici, talmente grossolani, da non sembrar veri. Iniziamo con il plastico del mai edificato Führermuseum attribuito nel film ad Albert Speer (vero), da costruire a Linz (vero), città di Hitler (vero) che nella Storia - quella vera - avrebbe invece dovuto chiamarsi Hitlermuseum. In una scena, con una bella diapositiva di Montecassino distrutta, ci dicono nel marzo del 1944 (falso: è stata bombardata dagli Alleati tra il 15 e il 18 febbraio del 1944) ce ne fanno poi vedere un’altra con l’Italia e la situazione dei fronti nel medesimo anno, nulla da eccepire fino all’ubicazione di Firenze, talmente a nord da sembrarci più corretto mettere alle automobili la targa di Milano. Il film è una commedia o vuol narrarci una tragedia umana di eroi per l’arte? Non si capisce… La stampa - che ha resistito in sala oltre la prima ora di film - è stata costretta nel vortice schizofrenico del riso e del pianto convulsi, a tratti addirittura sovrapposti nemmeno contigui, fino al cinismo. Poi c’è la sequela dei cliché: i nazisti cattivi e gli americani buoni (ok); i nazisti ladroni e gli americani onesti (anche questo può starci); i nazisti ignoranti e gli americani di cultura (stop!). Mai soprassedere se la Storia ci va di mezzo: i nazisti erano raffinati assassini, non capre. Lo dimostra l’impalcatura politica che costruirono. Non regge nemmeno la teoria - ben espressa nella stessa pellicola - dell’idiozia tedesca di quegli anni, anche nel combattere, rispetto agli americani bonari e ironici; e seppur imbranati, inamovibili nell’essere sicuri del fatto loro. I sovietici barbari predatori di opere (anche loro non risparmiati) e dunque: «ci mancavano pure loro, adesso!». Ditelo a Sparta, verrebbe voglia di aggiungere.
Torniamo al sorprendente concorso: uno stupore causato dalla triste qualità dei film scelti, pur appartenendo a registi di tutto riguardo. Come l’austriaca Feo Aladag, che ha presentato Inbetween Worlds, perfettamente in linea con quanto testé annunciato: brava lei, molto apprezzata tra Germania e Austria, ma il film sembra tralasciare una serie di interessanti occasioni, probabilmente per superficialità o forse per troppa concentrazione su un soggetto, che s’ispessisce a un certo punto nei meandri soggettivo-psicologici del suo personaggio principale, in una guerra che invece è riconosciuta per il suo carattere corale. Un ufficiale dell’esercito tedesco (Ronald Zehrfeld) si trova in Afghanistan (Kunduz) durante una missione contro terroristi talebani, che si svolge nella stessa area in cui è morto il fratello. Si è fatto mandare proprio in quel reparto per dare un valore alla sua divisa: continuare quello che il fratello non può più fare; ergo, difendere la popolazione locale dalle angherie fondamentaliste. Lo affianca come traduttore, per una missione (presumiamo) molto delicata tra i villaggi al fronte, il giovanissimo Tarik (Mohsin Ahmady) che fa il docente d’inglese, quando non deve tradurre a rischio della propria vita. Lui studia anche il tedesco, proprio per essere sempre più utile, forse anche per un sogno nel cassetto, ma ha il problema di una sorella mal tollerata in città perché – donna - studia all’università (Saida Barmaki). Entrambi poi sono minacciati a causa di questo suo lavoro a servizio di un esercito visto come occupante, arrogante nel dettar legge, dove certamente sarebbe utile averne una, ma non di marca occidentale. Tra il comandante e il giovane traduttore nasce simpatia pur nell’evidente differenza culturale e reciproca diffidenza. Sul piano personale il film sonda i caratteri in modo certosino, ma è il contesto bellico a essere lasciato a se stesso. Un peccato, perché è quello che più ci interesserebbe. Come mai i tedeschi sono proprio lì? E la brigata di giovani soldati protagonista della storia, che cosa pensa di questa guerra impossibile ad armi impari e a nostro svantaggio per l’imperscrutabilità geografica? La politica del film non è quella di farci capire, ma di raccontare la solita vicenda di guerra strappalacrime e romanzata, che si snoda intorno a un eroe tra ordini evasi, paura della morte e vincoli etici - o presunti tali - disancorati sociologicamente da tutti noi spettatori, in luoghi e culture affascinanti e ormai vicini, seppur a causa di conflitti. Non vale nemmeno l’appiglio logico dell’essere troppo anzitempo agli eventi stessi, per averne una giusta distanza d’analisi. Non ha proprio senso raccontare la missione antitalebana con gli ingredienti - forse in passato avvincenti - triti e ritriti da film di guerra hollywoodiano.
Un occhio inusitato sul Giappone c’è giunto dal capolavoro di Yoji Yamada Chiisai Ouchi (The Little House) che, in tutta la sua semplice bellezza, certamente va a aggiungere molto sia alla Storia, sia a quella del cinema. Siamo nell’Impero, a Tokio, a ridosso dell’attacco a Nanchino (1937) da parte dell’esercito imperiale giapponese e in una piccola villa dal tetto rosso vive una famiglia squinternata, accudita dalla giovanissima governante Taki (Haru Kuroki, vincitrice tra l’altro dell’Orso d’argento come migliore attrice) che diventa un po’ il fulcro di tutti gli equilibri - più squilibri in verità - dell’intera casa. Il capofamiglia, orgoglioso proprietario di un’importante fabbrica di giocattoli in metallo, spera che con l’invasione della Cina - essendo i cinesi proprio tanti - il boom di guadagni lo renda milionario. La moglie (Takako Matsu) s’innamora, ricambiata, dell’altrettanto strambo collega del marito Shoji (Takataro Kataoka), disegnatore per la fabbrica di giocattoli con il sogno nel cuore di diventare il più grande fumettista giapponese. Frattanto la stampa, ne racconta tante, tacendone altre e facendo credere al popolo che questa guerra sarà per l’Impero una passeggiata. Così nella piccola casa rossa, si spera molto nel successo e altrettanto nella politica aggressiva di Hirohito (1901 - 1989), anche quando il cibo incomincia a essere razionato perfino a Tokio e i giocattoli non son più di metallo, ma di legno… Gli anni trascorrono e la guerra pure con tutta la sua capacità di distruzione, fino al tragico epilogo di Hiroshima (6 agosto 1945) e Nagasaki (9 agosto 1945). Alla fine tutto si rivela il racconto che Taki ha lasciato al nipote, prima di morire. La narrazione è piana, ma caustica, impietosa verso il Giappone di quegli anni e il suo popolo, irriso dal regista Yamada per la sua incondizionata e trasognata fiducia nei sogni più strambi. Un popolo capace di abboccare alla conquista del pianeta, alla guerra totale, raccontate all’opinione pubblica con picchi di tragicità Kabuki, redenzioni emotive, entusiasmi banzai, su scenari alla Mazinga, per lettori di Manga. Fino all’amara, agghiacciante sveglia con Enola Gay.
Ecco narrate tutte le annose guerre alla sessantaquattresima Berlinale, non potendo dir nulla della Prima: buon centenario!