Il saggio intende analizzare una delle prime esperienze italiane in cui si è sviluppato un progetto partecipato, quello promosso dall’organizzazione di volontariato Modena per gli altri (Moxa), all’interno del quale università, associazioni e tessuto cittadino hanno contribuito a riscoprire e ripensare l’esperienza coloniale [Bertella Farnetti 2007a, 2007b, 2009, 2010; Bertella Farnetti, Mignemi, Triulzi 2013]. A Modena, nei primi anni Duemila, la sinergia tra soggetti differenti, pubblici e privati, ha portato alla creazione del Centro documentazione Memorie coloniali [1] (Cdmc), che ha consentito di raccontare il colonialismo attraverso le fonti messe a disposizione direttamente dalla cittadinanza in modo del tutto volontario. L’esperienza ha fatto da apripista a una metodologia di ricerca e a riflessioni che continuano tutt’oggi e che sono diventate un modello per diverse città italiane. La conquista fascista dell’Etiopia è stata il punto di partenza dal quale ha preso le mosse un’attività che nel tempo si è strutturata in un vero e proprio archivio per la raccolta e lo studio di materiali inediti di vario tipo (fotografie, diari, filmati, ecc.), provenienti in prevalenza da soggetti privati, e all’organizzazione di iniziative pubbliche dedicate alla memoria del colonialismo.
Il presente contributo si avvale delle riflessioni di Paolo Bertella Farnetti, referente scientifico del progetto e docente di storia contemporanea, raccolte dall’autrice di questo articolo nel corso di un’intervista. A una prima contestualizzazione generale degli studi sull’esperienza coloniale italiana e sulla sua memoria, seguono la ricostruzione della genesi del progetto e delle principali iniziative che lo hanno caratterizzato, nonché il confronto con altri progetti che si sono occupati, e in alcuni casi continuano a occuparsi, di risignificare la memoria sia pubblica sia privata di quel periodo.
1. Sul colonialismo: una ricostruzione in divenire
Per decenni, il colonialismo italiano è stato in gran parte ignorato o trascurato nella memoria collettiva del paese e la ricerca storica ha faticato a inquadrarne l’oggetto e a raccontarne la complessità. Fino agli anni Settanta la storiografia italiana ha ridimensionato in larga parte il ruolo dell’Italia nel più ampio quadro delle politiche coloniali e imperialiste messe in atto dalle nazioni europee ai danni dei territori e delle popolazioni dell’Africa a partire dalla fine dell’Ottocento. Le narrazioni dominanti nel dopoguerra tendevano, infatti, a enfatizzare l’immagine dell’Italia come vittima del fascismo e della guerra più che come una potenza coloniale colpevole di violenze e oppressioni [Pes 2023]. Un processo fatto di silenzi e dimenticanze che hanno contribuito a offuscare la portata delle atrocità compiute dagli italiani, come l’uso di gas chimici in Etiopia, la creazione di campi di concentramento in Libia e la repressione brutale delle popolazioni locali; e che ha portato gli storici a parlare di “rimozione”, concetto che nel corso del tempo ha assunto significati molteplici – e talvolta persino controversi – in relazione alla memoria del colonialismo [Proglio 2018]. Per lungo tempo si è preferito mettere in risalto un presunto paternalismo e una volontà “civilizzatrice”, presentata come più benevola rispetto a quella che animava le altre nazioni imperialiste, omettendo le violenze sistematiche e le politiche razziste adottate in Africa.
Su questo tema la storiografia ha subito un’evoluzione significativa nel corso del tempo, dai primi e pionieristici studi [Del Boca 1965, 1976; Rochat 1972] alle ricerche che hanno progressivamente affrontato il tema in modo più critico e approfondito [Del Boca 1992; Labanca 2002] fino alla recente apertura a nuove prospettive di ricerca [Stefani 2007; Dominioni 2008; Pes 2010; Calchi Novati 2011]. La storiografia sul colonialismo italiano ha compiuto grandi progressi nell’ultimo mezzo secolo, passando da una visione apologetica a una ricostruzione più accurata, capace di andare oltre le teorie assolutorie [Deplano, Pes 2024]. In anni recenti si è assistito a un vero e proprio cambio di paradigma nei confronti del colonialismo: a una maggiore attenzione per la dimensione storica si è affiancata l’analisi delle politiche memoriali dei paesi europei, comprese quelle che hanno riguardato, o più spesso hanno ignorato, la memoria coloniale [Focardi, Pes 2023]. Tuttavia, l’emergere di questi nuovi orientamenti storiografici non ha prodotto una messa in discussione e una decostruzione del modo in cui è stato raccontato quel passato nel dibattito pubblico, tanto che il colonialismo rimane un argomento scarsamente trattato al di fuori del contesto specialistico. Infatti, l’oblio che ha caratterizzato questa esperienza violenta non ha condotto a una riflessione critica su come le esperienze coloniali abbiano modellato l’identità nazionale e abbiano condizionato i rapporti dell’Italia con le proprie ex colonie dopo il processo di decolonizzazione.
Il colonialismo è stato un processo complesso e multiforme, che ha determinato l’incontro, nella maggior parte dei casi sotto forma di scontro, tra popoli e paesi molto differenti e anche laddove l’esperienza coloniale si è protratta per un lasso di tempo minore rispetto ad altre nazioni, ha lasciato segni evidenti sul lungo periodo, lasciando tracce tanto nei colonizzati quanto nei colonizzatori. Anche per ciò che riguarda la storia italiana, l’esperienza coloniale ha costituito un aspetto cruciale della storia nazionale e ha contribuito alla formazione dello Stato, oltre ad essere stata uno degli elementi con cui nel tempo è stata costruita la rappresentazione che l’Italia ha voluto dare di sé. Da un lato, l’Africa e la sua popolazione sono state descritte come un mondo lontano e completamente diverso, dall’altro queste narrazioni sono state uno degli strumenti per costruire le comunità nazionali e rinsaldare i processi di nation building. Dalla fine dell’Ottocento i cittadini italiani, così come quelli dei principali paesi europei, sono stati sottoposti a immagini, discorsi e costruzioni culturali, che non sono rimasti circoscritti agli ambienti militari o amministrativi, ma che sono circolati e continuano talora a circolare nella cultura cosiddetta popolare [Deplano, Pes 2014].
Tuttavia, mentre la storiografia sta lavorando con attenzione su questi aspetti, resta ancora molto lavoro da fare per integrare queste riflessioni nel discorso pubblico. Solo in anni recenti, infatti, sono emersi e si sono diffusi movimenti postcoloniali e antirazzisti che hanno portato il tema del colonialismo italiano ad essere maggiormente discusso nello spazio pubblico, mettendo a confronto il punto di vista degli italiani con quello degli afrodiscendenti. Negli ultimi decenni vari progetti e iniziative culturali, nati autonomamente in diversi contesti [2], hanno lavorato per portare alla luce la complessità della memoria del colonialismo attraverso mostre, conferenze e pubblicazioni. Queste iniziative mirano a sensibilizzare la popolazione sull’impatto duraturo del colonialismo e a promuovere una riflessione critica su come questo passato abbia un’influenza anche sulle dinamiche sociali e politiche contemporanee, specialmente in relazione alle migrazioni e ai rapporti tra l’Italia e i paesi ex-coloniali. Stereotipi e false ricostruzioni storiche persistono con forza nella memoria pubblica, la quale ancora oggi continua a fare i conti con i miti e le rimozioni che hanno caratterizzato il discorso italiano sul colonialismo; solo attraverso un dialogo aperto e una riflessione condivisa sarà possibile arrivare a una comprensione più completa e inclusiva di questa pagina della storia.
2. Tra pubblico e privato: Modena riscopre il colonialismo negli archivi famigliari
Modena ha una lunga storia nel campo della cooperazione internazionale. Un’esperienza che si è rafforzata e consolidata nel tempo attraverso il lavoro svolto dalle numerose associazioni presenti sul territorio. Tra queste si è distinta l’associazione di volontariato Modena per gli altri (Moxa), che è impegnata dal 2003 in progetti di cooperazione internazionale in Etiopia. Nel corso della sua attività, Moxa si è dovuta confrontare con le difficili eredità che il passato coloniale ha lasciato nel paese africano; retaggi di cui in Italia per un lungo periodo si è parlato poco. Da qui è nato il crescente desiderio di riflettere sull’aggressione italiana all’Etiopia, sulle conseguenze da essa prodotte e su come il rapporto tra i due paesi sia cambiato nel tempo.
L’idea di Moxa prende forma nel 2006 con il progetto Modena - Addis Abeba andata e ritorno, coordinato sotto l’aspetto scientifico da Paolo Bertella Farnetti, docente di storia contemporanea dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Chi scrive ha avuto la possibilità di dialogare direttamente con Bertella Farnetti su questi temi: nel prosieguo dell’articolo si farà perciò in più occasioni riferimento alle considerazioni emerse durante l’intervista. Il progetto di Moxa aveva come obiettivo promuovere presso un pubblico vasto la ricerca e la conoscenza di materiali documentali e fotografici relativi al periodo coloniale italiano, provenienti da archivi privati modenesi. Si trattava di un unicum in Italia, soprattutto perché il progetto si fondava sulla collaborazione e sul coinvolgimento di cittadine e cittadini allo scopo di individuare fotografie, diari, oggetti appartenuti a parenti che, a vario titolo, avevano preso parte alla conquista fascista dell’Etiopia. L’intento dichiarato, ha spiegato Bertella Farnetti, era quello «di fare soprattutto una storia sociale dal basso, di dare voce alle persone, di non citare soltanto documenti».
Mentre «tutto il discorso pubblico sul colonialismo italiano del secondo Novecento è leggibile come una forsennata corsa all’oblio da parte delle classi dirigenti» [Montanari 2024, 62], nelle soffitte e nei vecchi scatoloni degli italiani le immagini e i ricordi del colonialismo resistono al tempo e acquisiscono una rinnovata centralità. A Modena la chiamata pubblica ha generato un interesse esteso e imprevisto, tanto nelle proporzioni quanto nella varietà e nella qualità del materiale “ritrovato”: migliaia tra immagini e libri che raccontavano la conquista italiana con gli occhi di militari, ovviamente, ma anche di medici, pittori, esploratori e giornalisti.
Il racconto fotografico della campagna di conquista dell’Etiopia non rappresentava di per sé una novità. I servizi foto-cinematografici dell’Istituto Luce, che per poter seguire ogni aspetto della campagna coloniale aveva creato un reparto apposito, hanno lasciato negli archivi migliaia di immagini [Del Boca, Labanca 2002]. Ma se quelle del Luce erano immagini pensate per essere sottoposte a Mussolini e poi, una volta approvate, per essere diffuse a scopo propagandistico in tutto il paese tramite i giornali e i cinegiornali, quelle richieste alla cittadinanza dal progetto di Moxa sono documenti privati, per lo più pensati e realizzati per essere fruiti dai loro autori o da una ristretta cerchia di persone. Dalle immagini private emerge spesso quello che dalle immagini ufficiali era accuratamente tralasciato, consentendo così di ampliare di molto il quadro del racconto. Il primo ad essere stupito dalla risposta della cittadinanza e dal tipo di lavoro che si prospettava è stato lo stesso Bertella Farnetti: «Fu un risultato del tutto inaspettato, una vera sorpresa. Alla chiamata pubblica hanno risposto un gran numero di persone e quello che ci hanno mostrato è stato un “tesoro” di assoluto interesse. Abbiamo scoperto che moltissima gente aveva conservato le tracce del proprio passato famigliare, e lo aveva fatto in modo attento e accurato. Una ricchezza che non ci aspettavamo di trovare, e che ha fatto riflettere il gruppo di lavoro su molti aspetti».
Di fronte alla quantità e al valore del materiale raccolto Moxa decide, come prima attività pubblica del progetto, di allestire una mostra dal titolo Modena - Addis Abeba andata e ritorno – Esperienze italiane nel Corno d’Africa, che si è tenuta nel 2007 a Modena, presso il Museo civico etnologico e il Fotomuseo Giuseppe Panini. A corredo della mostra è stato pubblicato un catalogo e uno studio monografico [Bertella Farnetti 2007a], in cui si sottolinea che
Uno dei risultati più importanti è stato quello di scoprire che la gente in casa conserva molti materiali che sono delle vere e proprie fonti. Si potrebbero definire quasi dei fondi o degli archivi che si rivelano strumenti significativi per fare storia. Mentre l’Istituto Luce ha raccolto le immagini che ritraggono momenti e occasioni ufficiali durante la spedizione in Etiopia del 1935, in questo caso abbiamo avuto accesso a fotografie che ritraggono in gran parte momenti privati e che sono state scattate da una varietà di soggetti: soldati, coloni, qualche ufficiale. In questo ha avuto un ruolo considerevole il fatto che proprio in quegli anni la macchina fotografica è diventata uno strumento di massa, economicamente accessibile e piuttosto semplice da usare, che si diffonde enormemente e che molti italiani utilizzano per inviare a casa ricordi e testimonianze di quello che stanno vivendo.
Se i cinegiornali e i materiali prodotti dall’Istituto Luce offrono la possibilità di vedere cosa il regime voleva mostrare agli italiani e il modo con cui intendeva piegare la conquista dell’Etiopia alle finalità della politica di potenza fascista [Mancosu 2022], le fonti private consentono un punto di vista più esteso e variegato, in cui agli effetti della propaganda si uniscono sguardi e interessi peculiari. Tuttavia è bene sottolineare come, pur trattandosi di due fonti molto diverse tra loro, non sono da considerare necessariamente in contrapposizione l’una all’altra. Entrambe, infatti, veicolano una rappresentazione dell’Africa e della conquista coloniale voluta dal regime, che era l’unico modo con cui gli italiani potevano immaginare quelle terre lontane e sconosciute ai più. Se da un lato la fotografia ufficiale è strettamente definita dalle regole imposte dall’autorità, dall’altro lato quella privata non è vincolata a questi limiti e per questo motivo è in grado di documentare in maniera più libera aspetti e momenti dell’azione coloniale di cui non si trovano riscontri nell’altra, nonostante anch’essa sia partecipe della stessa mentalità di dominio e sopraffazione.
L’immagine fotografica, pubblica o privata che sia, non è mai neutra; deve sempre essere considerata una fonte fortemente connotata, capace di contenere una stratificazione di elementi che lo studio e l’analisi sono chiamati a decodificare. Qualunque sia la sua provenienza, la fotografia, soprattutto quella coloniale, è stata un mezzo per definire e insieme dominare l’“altro”, e come tale deve essere indagata [Palma 2013]. A differenza di quanto solitamente accade, la mostra Modena - Addis Abeba andata e ritorno non ha rappresentato la conclusione del progetto, bensì ha segnato l’inizio di una riflessione più ampia, che ha permesso di continuare ad analizzare il materiale emerso e le acquisizioni storiografiche che dagli anni Settanta hanno portato al centro del dibattito la violenza perpetrata dagli italiani durante le conquiste coloniali. Il lavoro e l’interesse scaturito hanno evidenziato le persistenze che gli eventi legati al colonialismo hanno lasciato nella contemporaneità e nella memoria pubblica e privata.
La guerra di conquista dell’Etiopia è una delle prime guerre, nella storia della fotografia, a essere fotografata in modo sistematico e diffuso; in questo contesto gli album privati diventano una sorta di diario visivo in cui le immagini raccolte nei mesi di guerra e occupazione costruiscono un racconto individuale, ma con effetti anche sulla collettività [Mignemi 1984].
La scelta di lavorare principalmente su fonti private ha permesso di mettere in luce un punto di vista diverso da quello delle fonti ufficiali del regime fascista o degli organi di stampa. Sono emerse, così, vicende solo all’apparenza “minori”, ma che in realtà hanno consentito di ricostruire il quadro articolato delle diverse esperienze di quanti avevano partecipato alla conquista dell’Etiopia. Se la propaganda colonialista, che si era fatta strada utilizzando letteratura, canzoni e film, aveva usato come temi cardine la missione civilizzatrice dell’Italia in Africa, l’arretratezza dei paesi conquistati, l’espansione demografica, la costruzione di infrastrutture nelle colonie, il richiamo all’imperialismo romano, l’esaltazione dell’eroismo e del “sacrificio” dei soldati e il disprezzo delle popolazioni native [Calchi Novati 2011], nelle foto private alla narrazione collettiva si affianca gli sguardi soggettivi dei singoli, che a volte confermano i motivi tipici della propaganda, altre sembrano intrattenere con essi rapporti complessi. Nelle fotografie, infatti, non si rintraccia soltanto la retorica della conquista e della grandezza italiane, ma emergono anche lo stupore, l’impreparazione, le difficoltà di uomini che per la prima volta si trovavano in Africa, in un contesto completamente diverso da quello a cui erano abituati, e che erano posti quotidianamente dinanzi alle difficoltà concrete della guerra. Nel caso delle fotografie private c’era una maggiore libertà nella scelta del soggetto da fotografare rispetto alle tradizionali foto propagandistiche. Tra i fattori che certamente potevano concorrere a condizionare la scelta vi erano gli interessi, l’estrazione sociale e la professione di chi scattava le foto: «la sensibilità, l’intelligenza, l’occhio capace di sintetizzare e di rappresentare la realtà attraverso la camera sono proprie dell’individuo, oltre che degli steccati culturali» [Goglia 1995, 34]. Queste fonti permettono anche di studiare il rapporto che i coloni avevano con le popolazioni colonizzate: negli album raccolti, ad esempio, non mancano foto di donne etiopi che venivano inviate a casa come una forma di vanto, perpetrando così l’immaginario della subordinazione femminile agli uomini italiani; ma ci sono anche immagini che raccontano temi assenti nella propaganda colonialista istituzionale, come episodi di tortura oppure fucilazioni di partigiani. Le autorità coloniali avevano emanato divieti espliciti affinché non venissero fotografate le esecuzioni capitali ed erano piuttosto preoccupate dalla circolazione che queste immagini avevano tra i militari, capaci di eludere il controllo della censura [Volterra 2014]. Ha raccontato Bertella Farnetti:
In alcuni casi abbiamo notato una tendenza a scattare fotografie anche macabre, con soldati ritratti accanto ai cadaveri. Si tratta di materiale estremamente delicato; dal punto di vista storiografico queste sono tracce molto interessanti, che non si vedono in altri contesti e che sono le testimonianze indiscutibili della violenza utilizzata nelle colonie, compreso l’impiego di gas illegali e mortali.
E ha continuato:
Faccio un esempio per aiutare a comprendere l’importanza di questa documentazione. Proprio mentre lavoravo su una foto di uno dei fondi acquisiti, uno storico scrisse che la mancanza di fotografie che ritraevano soldati italiani con le maschere a gas doveva essere considerata una prova del fatto che l’esercito non aveva usato armi tossiche. Ebbene, quel fondo raccolto da Moxa contiene immagini di soldati italiani, tutti ritratti con la maschera antigas. Non c’è prova più eloquente per smentire chi, ancora oggi, non crede che l’Italia abbia attaccato l’Etiopia senza nessun rispetto per la sua popolazione e in spregio dei trattati internazionali.
Una documentazione chiave, quindi, per ricostruire aspetti meno noti ma non meno importanti, basti pensare che della fucilazione del principale capo militare della resistenza libica, Omar al-Mukhtar, e uno dei momenti chiave nella sottomissione della colonia, non esistono immagini pubbliche ma solo fotografie private [Goglia 1995].
Si tratta di fonti peculiari, non sempre di facile lettura né conservazione, la cui importanza consiste nella capacità di fornire informazioni sulla «storia dal basso, la storia della gente comune, che è quella che interessa di più il pubblico e che leggiamo con più attenzione», sottolinea Bertella Farnetti. Per l’importanza e la delicatezza del materiale che è stato consegnato, il gruppo di lavoro ha continuato a collaborare per avviare un’analisi approfondita sulle fonti, che consentisse di esaminarne gli aspetti dal punto di vista scientifico e riflettesse sulla memoria del colonialismo italiano che emerge dalle fonti non ufficiali. Sul primo tema è stato proposto nel 2007 un incontro pubblico, con Adolfo Mignemi e Michele Smargiassi, in cui storici ed esperti si sono confrontati sulle fonti fotografiche, sul secondo caso è stata organizzata una tavola rotonda coordinata da Angelo Del Boca e Nicola Labanca. Nonostante l’apparente immediatezza e facilità di lettura, le immagini sono infatti un dispositivo costruito intorno a paradigmi e categorie ben precise e sono l’espressione di un punto di vista specifico. Sono un materiale potentissimo, non semplice da gestire, da maneggiare e da interpretare, che va costantemente contestualizzato. Nell’album fotografico si dà un particolare rapporto tra la dimensione privata e quella pubblica. Da una parte, infatti, l’album è un oggetto che pertiene alla sfera strettamente personale poiché in genere raccoglie materiali e documenti relativi all’esperienza di un singolo o dei suoi immediati vicini; dall’altra parte, nel momento stesso in cui si compone un album, gli si conferisce una determinata struttura, si dispongono le foto secondo un ordine e una gerarchia precisi, che evidentemente sono pensati non soltanto per la fruizione personale, ma anche perché siano congeniali per la consultazione da parte di un “pubblico” più o meno largo. Proprio questa disposizione dei documenti fa in modo che l’album finisca con l’attribuire alla fotografia un significato diverso – a volte anche molto distante – da quello originario, ossia da quello relativo al momento in cui è stata scattata. Nel vasto e composito mondo degli album fotografici, l’album coloniale è una forma del tutto peculiare. Da un lato, infatti, questa tipologia presenta analogie con album di tipo per così tradizionale: al suo interno confluiscono elementi dell’album di viaggio, in cui si adotta uno sguardo particolare sulle popolazioni “altre”; ma anche dell’album di ritratti delle popolazioni native, e dell’album di guerra. Due caratteristiche, però, in genere sono invece presenti negli album coloniali ma escluse dalla rappresentazione fotografica tradizionale: la violenza, attraverso le foto di aggressioni alle popolazioni coloniali, esecuzioni e corpi mutilati e uccisi, e l’erotismo, che deriva dall’esposizione e dalla nudità dei corpi femminili [Tomassini 2013].
L’immagine – in particolare quella scattata nelle colonie – porta con sé un aspetto peculiare ma determinante a cui prestare attenzione: fin dalla prima età moderna, con la scoperta delle Americhe, gli europei hanno iniziato a rappresentare attraverso le immagini l’alterità con cui venivano in contatto e nel fare ciò hanno utilizzato e riprodotto la visione egemonica eurocentrica, che li poneva al vertice del sistema economico e culturale. Scattare una fotografia dell’altro è, infatti, anche un atto di potere con cui «realtà complesse vengono contenute nella prospettiva di chi scatta la foto, di chi, cioè, detiene il potere di escludere elementi non funzionali al proprio sistema epistemico e valoriale, facendo invece risaltare quelli utili al dominio» [Mancosu 2023, 121]. Se di questo aspetto si deve tener conto in generale nella ricostruzione storica, tanto più vero è quando si indaga la memoria coloniale. Il rischio che si cela, talvolta, dietro i progetti di ricerca o di storia pubblica che riguardano il colonialismo è, infatti, quello di continuare a raccontare la storia attraverso un’unica prospettiva, quella occidentale, e di tralasciare il punto di vista delle popolazioni native, come esse abbiamo vissuto e raccontato quegli avvenimenti, se sia presente in loro una memoria di quei fatti e, nel caso, come sia stata preservata, rielaborata e proposta.
Come è stato notato:
Questo tipo di percorso della memoria – attraverso l’archivio coloniale – ha un tratto comune problematico: riguarda sempre e unicamente il potere dell’Europa bianca. […] L’archivio è al tempo stesso, il luogo simbolico del comando e dell’applicazione del potere europeo sulle colonie […]. Rovesciare l’immagine è una pratica che chiede di moltiplicare gli sguardi sulla memoria: di leggere l’archivio in controluce e di continuare a decostruire genealogie di poteri coloniali e postcoloniali; ma anche di rimanere in ascolto di altri linguaggi del ricordo, di cogliere le metafore della memoria non come segni ma quali universi di senso mnemonico ancora da interrogare [Proglio 2023, 119].
Un aspetto con cui si è scontrato anche il gruppo di lavoro modenese, che ha riflettuto a lungo sull’importanza del lavoro di decostruzione delle immagini. Per garantire una pluralità di sguardi, indispensabile come si è visto in questo genere di operazione, al lavoro svolto dall’Università di Modena e Reggio Emilia e da Moxa si è affiancata un’intensa attività di collaborazione con l’Istituto di cultura italiana di Addis Abeba. Ne è nato il progetto Etiopia per non dimenticare, il cui obiettivo era lavorare congiuntamente alla ricostruzione memoriale dagli anni in cui la storia dell’Etiopia è stata costretta, suo malgrado, a incrociarsi con quella dell’Italia. In quest’ottica, nel 2008 nella capitale etiope è stata esposta la mostra Modena - Addis Abeba andata e ritorno ed è stato organizzato un momento di approfondimento e confronto che ha coinvolto Bertella Farnetti, Shiferaw Bekele, professore di storia etiope dell’Università di Addis Abeba, l’ambasciatore italiano Raffaele De Lutio e il direttore dell’Istituto italiano di cultura Bruno Bellotto. Alla realizzazione di queste iniziative è seguita nel 2010 l’organizzazione, sempre ad Addis Abeba, della mostra Returning Memories. Pier Luigi Remaggi in Axum, 1935-36, promossa dall’Istituto italiano di cultura. La mostra era incentrata sul ricco fondo fotografico di Pier Luigi Remaggi, che fu ufficiale medico durante la guerra contro l’Etiopia. Le immagini spaziavano dalle mansioni svolte da Remaggi in ospedale a scene di vita militare, da ritratti di indigeni africani a fotografie di cerimonie tradizionali e attività lavorative nei villaggi, da monumenti ad animali e paesaggi.
Con il passare del tempo, però, la collaborazione tra Italia ed Etiopia a proposito del loro “passato comune” si è rivelata uno degli aspetti più problematici. La condivisione delle memorie, che nelle aspettative iniziali avrebbe dovuto essere il punto di partenza per un’analisi comparata del colonialismo italiano attraverso il progetto Returning and Sharing Memories, si è presto interrotta, come ha spiegato Bertella Farnetti, mettendo in evidenza uno degli elementi più complessi nel lavoro portato avanti insieme a Moxa:
Lo scambio, quello che nel titolo del progetto è rappresentato dal termine sharing, ha subito una battuta d’arresto. In Etiopia questi materiali non hanno avuto molta diffusione e il dialogo con le istituzioni etiopi si è arrestato, non permettendo di proseguire la condivisione dei materiali e il confronto sia in ambito scientifico sia nel dibattito pubblico riguardo alla memoria del passato coloniale.
Resta, però, di notevole importanza continuare a mantenere vivo un legame con l’università e con le istituzioni politiche e culturali etiopi, per fare davvero in modo che si prosegua in una riscoperta del passato capace di tener conto dei diversi punti di vista coinvolti.
Nell’opinione di Bertella Farnetti, uno dei possibili aspetti che rende difficile il dialogo su queste memorie è che:
A loro [i discendenti delle popolazioni colonizzate, nda] non piacciono quelle fotografie, perché in fondo ritraggono i loro antenati quando erano sottomessi, quando erano occupati. E poi bisogna fare molta attenzione anche al linguaggio: talvolta noi parliamo di impero, di conquista, usando termini un po’ pomposi, ma chi ha vissuto in quei luoghi sa benissimo che il regime fascista non è mai riuscito a conquistare tutta l’Etiopia. Più che una conquista coloniale, la consideravano un’occupazione da cui hanno provato a liberarsi in ogni modo.
3. Memorie coloniali: un centro di documentazione sul passato coloniale
La quantità e la ricchezza del materiale documentario ha spinto Moxa a creare un vero e proprio centro di documentazione digitale, il Centro documentazione Memorie coloniali – Cdmc, nato nel 2012, in cui i documenti messi a disposizione dalla cittadinanza sono digitalizzati e resi consultabili da parte degli interessati attraverso un portale online (www.memoriecoloniali.org). Il sito raccoglie i fondi documentari, le descrizioni archivistiche e altri materiali utili per la ricerca di studiosi e docenti, che possono così approfondire diversi aspetti della storia della colonizzazione italiana.
Nelle foto raccolte l’attenzione degli italiani che arrivano in colonia si posa su ciò che è diverso, attraente o sconosciuto, per documentare la nuova realtà e darne testimonianza a chi è rimasto in Italia; si tratta, quindi, di uno sguardo fortemente permeato dalla cultura europea e dalla soggettività dei colonizzatori, dalla loro professione e dalle loro ideologie.
Nel tempo le acquisizioni non si sono mai fermate e il lavoro di digitalizzazione e catalogazione dei nuovi materiali è proseguito ampliando anche gli avvenimenti presi in considerazione e l’arco cronologico a cui fanno riferimento. Dalla conquista fascista dell’Etiopia il patrimonio del centro di documentazione si è allargato anche alle campagne coloniali dell’Italia liberale, in particolare alla conquista della Libia del 1911-12, [3] e alla sottomissione del cosiddetto “Corno d’Africa”. Più recentemente è stato oggetto di indagine anche il rapporto tra l’Italia e l’Albania attraverso il progetto Italia - Albania, due sponde dello stesso mare, realizzato nel 2014. Con questa iniziativa si è aperta la raccolta di materiali relativi alla presenza italiana in Albania a partire dall’invasione fascista del 1939, che sono poi stati esposti pubblicamente attraverso la mostra Modena - Tirana andata e ritorno, proposta sia a Modena, nel 2015, sia a Tirana, a cui sono seguite conferenze e pubblicazioni sui rapporti tra i due paesi.
Tutto il materiale, prima di essere duplicato digitalmente, è catalogato cercando di rispettare il più possibile, quando questo è riconoscibile, il criterio ordinatore di chi ha prodotto i materiali, mentre le immagini sciolte sono ordinate e contrassegnate per l’archiviazione. Un lavoro molto delicato ma di fondamentale importanza. I fondi fotografici privati sono solitamente conservati all’interno di album oppure raccolti in buste o scatole, talvolta disposti secondo un certo ordine, altre volte riuniti in modo generico. A fare la differenza, tanto per quel che riguarda la conservazione quanto per l’analisi storica delle fonti, sono le informazioni che si riescono a raccogliere per ricostruire la storia del fondo fotografico stesso. Nella maggior parte dei casi si tratta di materiale consegnato da privati e appartenuto a familiari non più viventi, ed è questo un aspetto da non trascurare: la contestualizzazione e l’interpretazione delle immagini, sia dei soggetti rappresentati sia del luogo in cui sono scattate e delle ragioni per le quali sono state scattate, risulta decisamente più problematica laddove le informazioni sono sommarie; una questione che si applica a tutta la fotografia privata coloniale [Goglia 1995].
La documentazione è conservata su diversi tipi di supporti e, nel caso delle raccolte riguardanti l’Etiopia, una copia digitale è inviata anche agli archivi etiopi, così da consentire un’effettiva condivisione del materiale. Un lavoro attento e preciso che negli anni ha permesso al Centro di ampliarsi: «Il progetto Memorie coloniali è proseguito nel tempo e ad oggi è un vero e proprio centro di documentazione digitale; ha digitalizzato circa 16.000 fotografie che sono liberamente consultabili. Un patrimonio che non ha eguali sul tema del colonialismo» racconta Bertella Farnetti.
Si tratta di un’attività di raccolta a cui, sempre più spesso, si affianca anche quello di sensibilizzazione e divulgazione nei confronti della cittadinanza attraverso mostre, discussioni, incontri con le scuole e che nel tempo si è rivolta con attenzione crescente anche alla discussione e ridefinizione delle memorie pubbliche. Nel 2024 Moxa ha sostenuto il progetto partecipato Memorie consapevoli, promosso dall’Istituto storico di Modena e dal Comitato per la storia e le memorie del Novecento del Comune di Modena insieme a numerose associazioni locali. Il progetto aveva la finalità di rendere visibili i segni lasciati in città dal passato coloniale: attraverso reading, documentari, camminate storiche e visite guidate alle collezioni dei Musei civici provenienti dalle colonie, la cittadinanza è stata partecipe della scoperta e delle discussioni sul passato coloniale e sulle sue memorie pubbliche. Una rassegna di appuntamenti che si è inserita nelle iniziative della rete Yekatit 12-19 febbraio [4] e che ha coinvolto anche le comunità afrodiscendenti. Il progetto si è concluso, almeno per ora, con il posizionamento di una targa esplicativa in via Dogali, che racconta perché negli anni Trenta le autorità modenesi abbiano deciso di intitolare una via a questo luogo [Dodi, Negri 2023]. Un’azione mai avvenuta prima a Modena e che si inserisce nelle recenti riflessioni che hanno riguardato i nomi delle piazze e delle strade. L’odonomastica delle città italiane è uno degli ambiti in cui sono ancora oggi ben visibili le tracce del passato coloniale e, negli ultimi anni, sono stati numerosi i progetti che hanno lavorato per dare spazio al racconto di chi siano le persone o a cosa rimandino i luoghi che attualmente compongono gli indirizzi di migliaia di cittadini, rendendo esplicito l’intento celebrativo di violenze e crimini [5].
La quantità di materiale raccolto dal Cdmc è indice dell’importanza che quegli eventi hanno avuto nella vita di chi li ha vissuti direttamente, tanto da conservarne a distanza di decenni ricordi, o averne tramandato le memorie con cura alla famiglia. Sottolinea Bertella Farnetti:
È un quadro di una ricchezza unica soprattutto per chi si occupa di storia pubblica. La raccolta e la messa a disposizione di questi fondi è uno strumento straordinario che aiuta a democratizzare il rapporto tra la storia e il suo uso civile. La possibilità di conoscere e informarsi che oggi forniscono gli strumenti tecnologici sono un’importante occasione per far comprendere che ognuno è parte del divenire storico, dal momento che le vicende dei decenni passati hanno toccato direttamente i nostri genitori e i nostri nonni. I protagonisti delle vicende sono spesso uomini e donne comuni e riscoprire la storia passa anche dal ritrovamento di archivi privati e vecchi ricordi di famiglia.
4. Da ricordo privato ad azioni pubbliche: progetti partecipati per ripensare la memoria coloniale
Come ha sottolineato Bertella Farnetti
sta aumentando il numero di possibilità che la gente ha a disposizione per intervenire, per poter vedere queste foto, per fare considerazioni, per decidere, magari anche per partecipare e interagire con questo progetto. Un progetto che ha tante ramificazioni, sotto forma di convegni, seminari, incontri, saggi, ecc.
L’esperienza modenese ha fatto da apripista nell’incoraggiare l’ideazione e lo svolgimento di attività simili in altri contesti, come è accaduto, ad esempio, a Ivrea [6]. I progetti organizzati a Modena sono così diventati un punto di riferimento importante per gli studiosi del settore. Negli anni recenti l’attenzione e il modo con cui si affrontano la storia e la memoria del colonialismo sono mutati: grazie alla crescente attenzione del mondo accademico, ma soprattutto a partire dalle richieste della società civile, è aumentato l’interesse verso la ridefinizione del passato, in particolare quello più problematico e controverso, espressione di un sistema valoriale e di relazioni di potere considerati non più adeguati. In particolare è il lavoro svolto da collettivi, attivisti e enti culturali che si occupano di questo tema ad aver segnato un punto di svolta. Spesso a farsi portatrice della rivendicazione di un nuovo modo di pensare il passato è quella parte di popolazione, sempre più numerosa, che ha origine o discende da coloro che hanno subito la colonizzazione, e che è decisa a far sì che anche il suo punto di vista diventi parte della costruzione memoriale su questi temi. Si è così progressivamente assistito alla riconsiderazione in chiave critica della narrativa ufficiale sia tra gli specialisti sia nel dibattito pubblico. Sono nati in diverse zone d’Italia, a partire “dal basso”, cioè dall’impegno di attivisti e cittadini, collettivi ed esperienze che si pongono l’obiettivo di “decolonizzare” lo spazio pubblico. Alla base di questo lavoro c’è la consapevolezza che in molti centri urbani italiani, grandi e piccoli, esistono strade, piazze e monumenti che portano nomi legati a personaggi che hanno avuto un ruolo importante nel colonialismo italiano: tra questi troviamo figure di militari e di uomini politici che parteciparono direttamente o comunque contribuirono alla gestione e all’amministrazione dei possedimenti coloniali. Questi monumenti e toponimi riflettono una narrazione unilaterale che è tesa a glorificare il passato coloniale, spesso oscurando le atrocità, lo sfruttamento e la violenza perpetrati dagli italiani nelle colonie in Africa. L’obiettivo di questi collettivi è sollecitare un ripensamento del passato coloniale e della memoria storica partendo da strade, monumenti e piazze. Le azioni da loro intraprese o auspicate riflettono la volontà di affrontare criticamente la memoria del passato coloniale, provando a correggere le omissioni storiche e ricordando le vittime del colonialismo. Si tratta di un lavoro che coinvolge sempre più spesso anche gli studiosi e alcune amministrazioni locali.
Tra le esperienze esistenti vale la pena citare Resistenze in Cirenaica, collettivo che opera nel quartiere bolognese noto come Cirenaica, dal nome dall’omonima regione della Libia colonizzata dall’Italia. Il gruppo ha promosso iniziative per cambiare il nome di alcune vie del quartiere intitolate a figure di colonialisti italiani o che rimandano a luoghi di battaglia in cui l’esercito italiano si impose con l’uso della violenza più spietata. Attraverso azioni definite di “guerriglia odonomastica” sono applicate etichette esplicative sotto i nomi delle vie considerate più controverse. Nel caso di strade intitolate a persone, queste etichette rendono conto di che cosa quelle figure hanno fatto in colonia; nel caso dei luoghi, di che cosa è lì accaduto. Per molte di queste vie si lavora a proposte per modificarne il nome, sostituendo l’intitolazione esistente con i nomi di anticolonialisti, resistenti o vittime delle violenze coloniali. L’obiettivo è trasformare lo spazio pubblico in un luogo di memoria plurale, in cui le storie delle popolazioni colonizzate e delle vittime delle guerre coloniali possano emergere in modo chiaro. Non solo lo spazio pubblico, anche le raccolte documentali e museali in anni recenti sono state messe al centro del dibattito per riflettere su come il materiale raccolto durante le campagne coloniali oggi debba essere proposto alla cittadinanza. Per ciò che riguarda il contesto emiliano vale la pena segnalare che nel 2022 il Museo del Risorgimento di Bologna ha organizzato una mostra dal titolo Libia 1911-1912. Colonialismo e collezionismo, esponendo per la prima volta i documenti della Croce rossa italiana risalenti alla guerra di conquista italo-turca. L’esposizione è stata l’occasione per problematizzare il significato e il valore degli oggetti del periodo coloniale che molte istituzioni pubbliche e private ancora oggi conservano. A Reggio Emilia l’Istituto storico ha realizzato il progetto Migrazione in Comune, all’interno del quale ha indagato anche le tracce del colonialismo italiano, legando questo fenomeno alla più ampia analisi dei flussi migratori che hanno interessato il territorio reggiano nella seconda metà del Novecento. Tramite la raccolta di interviste e esperienze familiari il legame tra il passato coloniale dell’Italia e la composizione attuale della società italiana è raccontato attraverso percorsi biografici eterogenei e compositi, mettendo in evidenza così un aspetto molto spesso tralasciato. Un’altra esperienza degna di menzione è quella del collettivo Tezeta, che ha svolto un ruolo fondamentale nel portare alla luce il passato coloniale e le tante tracce ancora presenti a Roma, attraverso l’organizzazione di incontri pubblici in cui la cittadinanza discute sulla necessità di rimuovere monumenti o nomi di strade dedicati a figure che hanno commesso crimini in nome del colonialismo, per sostituirli con indicazioni che commemorano, invece, le vittime della colonizzazione e le figure della resistenza africana.
Il modo in cui raccontiamo la storia attraverso lo spazio pubblico ha un impatto profondo sulla nostra memoria collettiva e proprio la decolonizzazione di questi spazi rappresenta uno strumento importante per affrontare il passato coloniale in modo critico e promuovere una società più consapevole delle proprie responsabilità storiche. Sempre più frequentemente, anche a livello internazionale, le modalità di racconto del passato e il sistema valoriale che questo veicola sono messe in discussione da chi è stato a lungo escluso dalla memoria pubblica o è stato – e in alcuni casi ancora è – oggetto di discriminazione. Dalla contesa che ha riguardato i monumenti [Lorini 2023; Testi 2023; Salomoni 2024] alla riflessione sul patrimonio culturale e museale [Grechi 2021] che si sta sviluppando in numerose istituzioni, sembra esserci una sensibilità diffusa, soprattutto nelle generazioni più giovani, verso la richiesta di risignificazione e risemantizzazione del passato e dei suoi segni, che metta da parte la visione occidentale ed eurocentrica per dare spazio a ricostruzioni più complesse e composite. Recentemente la storiografia ha coniato l’espressione transimperial history per evidenziare la necessità di adottare una prospettiva che si basi sull’attraversamento dei confini e sulla costruzione di reti di persone e pratiche che sappiano superare e scardinare la logica degli imperi coloniali, lavorando soprattutto sulle interconnessioni e non sulle differenze [Ertola 2023]. Come mostrano i progetti avviati a Modena, l’importanza di acquisire e discutere nello spazio pubblico il tema del colonialismo italiano privilegiando fonti appartenenti a privati è rilevante per diverse ragioni. Da un lato, c’è l’importanza storica e storiografica di questi fondi, che consentono di ricostruire gli eventi attraverso un punto di vista diverso da quello tramandato dai documenti ufficiali del regime; un punto di vista capace di rendere conto della vita quotidiana che si svolgeva in colonia, di ciò che vi facevano gli italiani, con chi interagivano e in quali attività erano impegnati. Ma c’è un altro aspetto che è altrettanto rilevante: tali progetti hanno la capacità di attivare un processo di democratizzazione della storia. L’organizzazione di iniziative realizzate insieme ai cittadini aiuta a comprendere che la storia non è una disciplina soltanto per studiosi e specialisti, che si occupa di persone ed eventi estranei a noi e al presente. Al contrario, come ha avuto modo di sottolineare anche Paolo Bertella Farnetti, la storia «si occupa di tutti e tutte, quindi anche degli uomini e delle donne comuni». La storia, inoltre, ci dimostra che «gli antenati di ognuno di noi hanno preso parte a eventi storici e ne hanno lasciato delle tracce. Questo può essere utile anche ad uscire dal “presentismo” in cui viviamo e ad aumentare la coscienza di quello che succede oggi».
Bibliografia
- Bertella Farnetti 2007a
Paolo Bertella Farnetti, Sognando l’impero. Modena - Addis Abeba (1935-1941), Milano-Udine, Mimesis, 2007. - Bertella Farnetti 2007b
Paolo Betella Farnetti, Modena - Addis Abeba andata e ritorno. Esperienze italiane nel Corno d’Africa, Carpi, Nuovagrafica, 2007. - Bertella Farnetti 2009
Paolo Bertella Farnetti, Returning and Sharing Memories. Genesi e sviluppo di un progetto per l’uso del “passato comune” italo-etiope (1935-1941), Modena, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Economia Politica, 2009. - Bertella Farnetti 2010
Returning Memories. Pier Luigi Remaggi in Axum, 1935-36, a cura di Paolo Bertella Farnetti, Addis Ababa, Master Printing Press, 2010. - Bertella Farnetti, Mignemi, Triulzi 2013
L’impero nel cassetto. L’Italia coloniale tra album privati e archivi pubblici, a cura di Paolo Bertella Farnetti, Adolfo Mignemi, Alessandro Triulzi, Milano-Udine, Mimesis, 2013. - Calchi Novati 2011
Gian Paolo Calchi Novati, L’Africa d’Italia. Una storia coloniale e postcoloniale, Roma, Carocci, 2019. - Del Boca 1965
Angelo Del Boca, La guerra d’Abissinia 1935-1941, Milano, Feltrinelli, 1965. - Del Boca 1976
Angelo Del Boca, Gli italiani in Africa orientale, vol. 1: Dall’Unità alla marcia su Roma, Bari, Laterza, 1976. - Del Boca 1992
Angelo Del Boca, L’Africa nella coscienza degli italiani, Roma-Bari, Laterza, 1992. - Del Boca, Labanca 2002
Angelo Del Boca, Nicola Labanca, L’impero africano del fascismo nelle fotografie dell’Istituto Luce, Roma, Editori Riuniti, 2002. - Deplano, Pes 2014
Quel che resta dell’impero. La cultura coloniale degli italiani, a cura di Valeria Deplano, Alessandro Pes, Milano-Udine, Mimesis, 2014. - Deplano, Pes 2024
Valeria Deplano, Alessandro Pes, Storia del colonialismo italiano. Politiche, cultura e memoria dall’età liberale ai giorni nostri, Roma, Carocci, 2024. - Dodi, Negri 2023
Giulia Dodi, Francesca Negri, Memorie consapevoli. Modena racconta il colonialismo italiano con un progetto di public history, in «FareStoria», 2 (2023), pp. 105-112. - Dominioni 2008
Matteo Dominioni, Lo sfascio dell’impero. Gli italiani in Etiopia, 1936-1941, Roma-Bari, Laterza, 2008. - Ertola 2023
Emanuele Ertola, Tra le maglie degli imperi. Prospettive per ripensare il colonialismo italiano, in «Storica», 87 (2023), pp. 81-111. - Focardi, Pes 2023
Filippo Focardi, Alessandro Pes, Il colonialismo e l’Europa tra memoria e uso pubblico della storia, in «Memoria e Ricerca», 2 (2023), pp. 215-220. - Goglia 1995
Luigi Goglia, Considerazioni generali sulla fotografia coloniale privata italiana, in Fotografia e storia dell’Africa, a cura di Alessandro Triulzi, Atti del Convegno Internazionale (Napoli-Roma, 9-11 settembre 1992), Napoli, I.U.O.,1995, pp. 27-35. - Grechi 2021
Giulia Grechi, Decolonizzare il museo. Mostrazioni, pratiche artistiche, sguardi incarnati, Milano-Udine, Mimesis, 2021. - Labanca 2002
Nicola Labanca, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Bologna, Il Mulino, 2002. - Lorini 2023
Alessandra Lorini, Le statue bugiarde. Immaginari razziali e coloniali nell’America contemporanea, Roma, Carocci, 2023. - Mancosu 2022
Gianmarco Mancosu, Vedere l’impero. L’Istituto Luce e il colonialismo fascista, Milano-Udine, Mimesis, 2022. - Mancosu 2023
Gianmarco Mancosu, “Scatta la foto, soldato!”. Istantanee del colonialismo italiano tra propaganda e omissioni, in Immaginare la storia. Abbecedario del colonialismo italiano, a cura di Federica Sossi, Verona, Ombre corte, 2023, pp. 120-140. - Mignemi 1984
Adolfo Mignemi, Immagine coordinata per un impero, Torino, Gruppo editoriale Forma, 1984. - Montanari 2024
Tomaso Montanari, Le statue giuste, Roma-Bari, Laterza, 2024. - Palma 2013
Silvana Palma, “Mirror with a memory”? La confezione dell’immagine coloniale, in L’impero nel cassetto. L’Italia coloniale tra album privati e archivi pubblici, a cura di Paolo Bertella Farnetti, Adolfo Mignemi, Alessandro Triulzi, Milano-Udine, Mimesis, 2013, pp. 81-107. - Pes 2010
Alessandro Pes, La costruzione dell’impero fascista. Politiche di regime per una società coloniale, Roma, Aracne, 2010. - Pes 2023
Alessandro Pes, Discorso pubblico e stereotipo del buon colonizzatore. Le istituzioni italiane e il passato coloniale, in «Memoria e Ricerca», 2 (2023), pp. 255-274. - Proglio 2018
Gabriele Proglio, L’Italia e il passato coloniale. Riflessioni e considerazioni a margine del dibattito storiografico, in «Memoria e Ricerca», 1 (2018), pp. 113-132. - Proglio 2023
Gabriele Proglio, Metafore della memoria. Ricordare il colonialismo fuori e dentro l’archivio, in Immaginare la storia. Abbecedario del colonialismo italiano, a cura di Federica Sossi, Verona, Ombre corte, 2023, pp. 102-119. - Rochat 1972
Giorgio Rochat, Il colonialismo italiano, Torino, Loescher, 1972. - Salomoni 2024
Antonella Salomoni, Lenin a pezzi. Distruggere e trasformare il passato, Bologna, Il Mulino, 2024. - Stefani 2007
Giulietta Stefani, Colonia per maschi. Italiani in Africa orientale: una storia di genere, Verona, Ombre corte, 2007. - Testi 2023
Arnaldo Testi, I fastidi della storia. Quale America raccontano i monumenti, Bologna, Il Mulino, 2023. - Tomassini 2013
Luigi Tomassini, L’album fotografico come fonte storica, in L’impero nel cassetto. L’Italia coloniale tra album privati e archivi pubblici, a cura di Paolo Bertella Farbetti, Adolfo Mignemi, Alessandro Triulzi, Milano-Udine, Mimesis, 2013, pp. 59-70. - Volterra 2014
Alessandro Volterra, Morì, siccome ‘n topo. Le fotografie dei processi a Omar al-Mukhtar e ai resistenti libici, in Quel che resta dell’impero. La cultura coloniale degli italiani, a cura di Valeria De Plano, Alessandro Pes, Milano-Udine, Mimesis, 2014, pp. 235-257.
Risorse
- Memoria coloniali
www.memoriecoloniali.org - Odonomastica coloniale a Parma
https://colonialismoparma.it/odonomastica-coloniale/ - Libia 1911-1912. Colonialismo e collezionismo
https://www.culturabologna.it/events/libia-1911-1912-colonialismo-e-collezionismo - Migrazione in comune - Istoreco
https://www.istoreco.re.it/testimonianze/ - Postcolonial Italy
https://postcolonialitaly.com/ - Resistenze in Cirenaica
https://resistenzeincirenaica.com/ - Odonomastica coloniale a Milano
https://storymaps.arcgis.com/stories/e087792474d24dd5be0fa7015298e811 - Tezeta
https://tezeta.it/ - Viva Zerai!
https://umap.openstreetmap.fr/it/map/viva-zerai_519378#6/41.508/11.096 - Yektat 12-19 febbraio
https://www.facebook.com/people/Yekatit-12-19-Febbraio/100089938535409/
Note
2. Tra i progetti più significativi e con un maggiore impatto sul discorso pubblico si segnalano: Resistenze in Cirenaica (https://resistenzeincirenaica.com/); Viva Zerai! (https://umap.openstreetmap.fr/it/map/viva-zerai_519378#6/41.508/11.096); Postcolonial Italy (https://postcolonialitaly.com/); collettivo Tezeta (https://tezeta.it/).
3. Fra i fondi acquisiti si segnala la Biblioteca coloniale di Alessandro Spina, composta da oltre 600 volumi e altri materiali in lingua araba appartenuti all’industriale e scrittore italo-libico.
4. https://www.facebook.com/people/Yekatit-12-19-Febbraio.
5. Tra i progetti esclusivamente dedicati alla permanenza di riferimenti coloniali nell’odonomastica si segnalano: https://storymaps.arcgis.com/stories/e087792474d24dd5be0fa7015298e811 per il caso di Milano, e https://colonialismoparma.it/odonomastica-coloniale/ per il caso di Parma.
6. https://www.memoriecoloniali.org/pubblicazioni/impero-breve-e-memoria-corta-testimonianze-private-del-colonialismo-italiano-ivrea/.
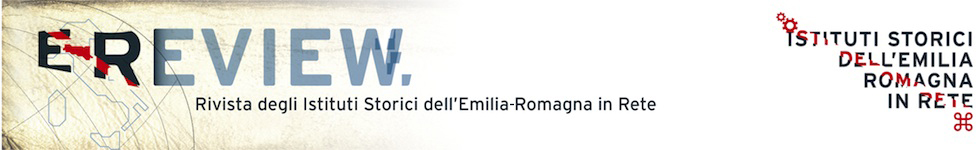
![Fig. 1. Pier Luigi Remaggi circondato da bambini [Archivio Moxa-Cdmc, fondo Pier Luigi Remaggi – A.O.].](./../../sites/default/images/articles/media/316/dodi_progettomc_01.jpg)
![Fig. 2. Lo sbarco a Mogadiscio del governatore Guido Corni, 1928, [Archivio Moxa-Cdmc, fondo Guido Corni – A.O.].](./../../sites/default/images/articles/media/316/dodi_progettomc_02.jpg)
![Fig. 3. Axum, ospedale da campo, ascari che hanno ricevuto cure medica, [Archivio Moxa-Cdmc, fondo Pier Luigi Remaggi - A.O.].](./../../sites/default/images/articles/media/316/dodi_progettomc_03.jpg)
![Fig. 4. Addis Abeba, Ascari a volto coperto montano e smontano mitragliatrici, [Archivo Moxa-Cdmc, fondo Luigi Perego – A.O.].](./../../sites/default/images/articles/media/316/dodi_progettomc_04.jpg)
![Fig. 5. Guido ed Elisa Corni, su dromedari, scortati da dubat, [archivio Moxa-Cdmc, fondo Guido Corni – A.O.].](./../../sites/default/images/articles/media/316/dodi_progettomc_05.jpg)



