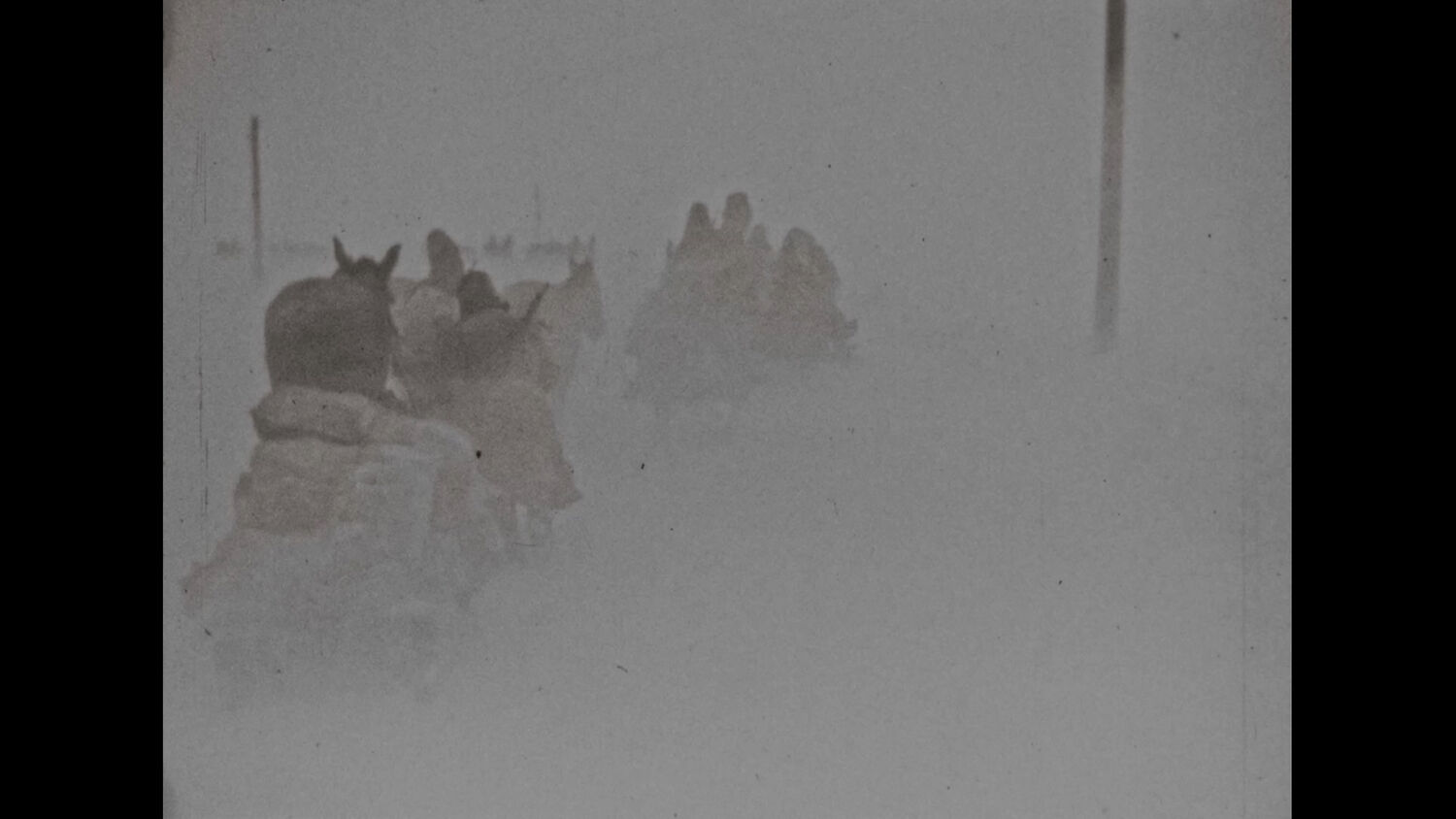1. Imprimere lo sguardo
«Per sapere bisogna immaginare» [1] [Didi-Huberman 2005, 15]: questo è l’incipit di un fondamentale saggio di Georges Didi-Huberman di quasi vent’anni fa, e tuttavia attualissimo. Images malgré tout mette a fuoco alcuni aspetti cruciali del legame tra i fatti della storia e la loro traccia visiva, a volte trasformata – e cristallizzata – in icona e in altri casi persa, diluita, in un flusso di immagini che gli studiosi faticano a interpretare per carenza di dati, ma anche per mancanza di strumenti ermeneutici.
Ma come possiamo immaginare i fatti della storia? Lo studioso si affida alle fonti per farlo: documenti ufficiali, cronache, solo in alcuni casi i documenti più personali, come diari, lettere, memorie. È grazie alle descrizioni, ai dettagli riportati in questi materiali per lo più testuali, che è possibile «dar figura concreta a un oggetto del pensiero» [2], dove per figura concreta si intende quel corpo sfuggente che è l’immagine. Le sue definizioni fondono aspetti scientifici e filosofici, in quanto questa forma esteriore degli oggetti corporei scaturisce dall’elaborazione che ne fa il senso della vista, dandocene percezione. Nulla di più reale e più apparente, di più oggettivo e più soggettivo di un’immagine. Per lungo tempo è rimasta sospesa nella personale sensazione di un istante, affidata, per essere comunicata, a descrizioni – in certi casi vere ekphrasis – oppure schizzi, disegni, rappresentazioni: ovvero, è stata perpetuata nel tempo tramite mediazioni, tentativi di trattenerla in altre forme.
È solo dall’Ottocento che è diventato possibile immortalare uno sguardo: da allora ha preso il via una proliferazione di immagini impensabile – inimmaginabile – in precedenza. Dai primi esperimenti sulla fotosensibilità fino alla scoperta della fotografia, questa tecnologia di scrittura attraverso la luce si è affinata e diffusa con un ritmo velocissimo. All’immagine fissa si è quindi affiancata l’immagine in movimento, scatenando una rivoluzione percettiva: se la fotografia era in grado di trattenere un istante, la cinematografia permetteva di salvare sequenze, e di conseguenza gesti, espressioni, piccoli e grandi fatti.
Con l’inizio del Novecento, la possibilità di filmare, prima appannaggio di pochissimi sperimentatori, inizia a diffondersi. E grazie all’invenzione della pellicola a formato ridotto (16mm e 9,5mm) negli anni Venti e poi, nel 1932, con la nascita dell’8mm, sempre più persone iniziano a cimentarsi nella pratica del cinema amatoriale. Infatti, a differenza del formato 35mm – usato in cinematografia dall’inizio del secolo, in nitrato di cellulosa e per questo altamente infiammabile – queste pellicole a passo ridotto vennero realizzate in un supporto safety (acetato di cellulosa), elemento che contribuì al loro successo di diffusione [Fiorini e Santi 2005]. Il boom di questa modalità di ripresa avverrà dopo la guerra, con un picco negli anni Sessanta, quando sarà introdotto il formato Super8, per poi sfumare sempre più a partire dagli anni Ottanta, soppiantato dal nastro magnetico prima, fino al digitale dei giorni nostri.
Nelle cantine e nelle soffitte, nei ripostigli e nei cassetti, molte case conservano bobine di pellicole dove è impressa la storia familiare: bambini che nascono e crescono, matrimoni, battesimi, pranzi di Natale, gite in montagna, vacanze al mare. Ma non solo. Home Movies, l’Archivio Nazionale del Film di Famiglia, fondato a Bologna nel 2002, raccoglie questi fondi in pellicola in formato ridotto: dai lavori di restauro, catalogazione e digitalizzazione, emerge una grande ricchezza di materiali – e di sguardi.
Per lo più si tratta di immagini illuminate dagli affetti: a prescindere sia dalla natura di ciò che viene filmato, sia dalla qualità della modalità di ripresa, tra l’occhio che gira e i volti, gli oggetti, i momenti ritratti c’è un legame di natura emozionale, fatto di sentimenti, di attrazione o di curiosità. Uno sguardo personale rivolto verso quello che accade: una fonte straordinaria anche per cogliere la storia “minuta”, quella che non si raggruma attorno ai grandi eventi, ma li prepara, li precede e li vede determinarsi, per poi continuare a svolgersi dopo di essi [3].
2. Il varco, tra archivio e fiction
Qualcosa di mai sopito rende gli home movies e i film amatoriali fondamentali per il cinema di ricerca contemporaneo. […] Film “ingenui” che invitano a ripensare i processi della percezione, la supposta naturalità del visivo, la possibilità di narrare altre storie [Bertozzi 2012, p. 53].
A partire dall’attraversamento di alcuni fondi di Home Movies è scaturito Il varco, progetto cinematografico di Federico Ferrone e Michele Manzolini [4].
Già nella loro produzione precedente, Il treno va a Mosca (2013), avevano lavorato sui fondi dei cineamatori Enzo Pasi, Luigi Pattuelli e Sauro Ravaglia, raccontando il viaggio nell’Unione Sovietica di un gruppo di militanti comunisti romagnoli, verso il Festival mondiale della gioventù e degli studenti del 1957, quell’anno dedicato alla pace e all’amicizia. Maneggiando quei filmati, Ferrone e Manzolini avevano però percepito la possibilità di andare oltre la narrazione specifica e circoscritta ai fatti ripresi.
I filmati amatoriali, infatti, sono spesso carichi di una peculiare capacità evocativa, che esula dalla loro stretta catalogazione. Non si tratta di cosa rappresentano, ma di come lo fanno. Luci, inquadrature, ma anche errori di esposizione, graffi, decadimenti dell’emulsione, corrosione del supporto: le immagini – anche grazie al caso e al passare del tempo – si trasformano in qualcosa di diverso, di astratto, quasi di universale. Qualcosa di auratico, che rimanda all’umano, alle emozioni comuni, alla comune caducità.
Questa dimensione, sospesa e sfumata, paradossalmente convive con l’altra, quella la cui forza risiede nel punto di vista particolare, individuale: dalle memorie filmiche amatoriali emerge uno sguardo personale sugli eventi della storia. Le immagini così prodotte, infatti, si collocano a grande distanza da quelle ufficiali, mentre hanno un tono affine ai diari e alle lettere, ovvero quello di documenti prodotti per se stessi o per la cerchia degli affetti.
Ferrone e Manzolini hanno così iniziato una ricognizione sui fondi di Home Movies relativi agli anni Venti, fino ai Quaranta: la fase di prima diffusione delle cineprese a passo ridotto, ma anche un periodo cruciale per la storia d’Italia. In particolare, la loro attenzione si è concentrata sui fondi di Enrico Chierici e di Adolfo Franzini, che contenevano diverse pellicole dedicate alla campagna di Russia. Se il fondo Chierici – fotografo e cineamatore genovese (1914-2001), sottotenente nella 3ª sezione fotografi - Comando 8ª armata, dotato di una cinepresa 9,5mm e una 16mm – era già stato catalogato e mostrato pubblicamente dai ricercatori di Home Movies [5], quello di Franzini invece era stato da poco preso in carico e i materiali dovevano ancora essere analizzati. Dalle prime ricerche emerse che Adolfo Franzini (Verona, 1911-1988), di madre tedesca, aveva prestato servizio in Africa Orientale Italiana, poi sul fronte francese, jugoslavo, russo e in Italia meridionale. Nel luglio 1941 partì per la Russia con il Corpo di spedizione italiano in Russia (Csir), come capitano di complemento d’artiglieria, portando con sé una cinepresa compatta Siemens 16mm.
Le immagini di Chierici filmate con la 16mm (la cinepresa con cui svolgeva servizio ufficiale per l’esercito) sono di documentazione: registrano la condizione delle infrastrutture, i ponti, la ferrovia, i danneggiamenti; quelle invece colte con la 9,5mm sono mosse da un’intenzione personale, come una cronaca di viaggio: le persone, i volti e le espressioni, la distribuzione del rancio, il mercato dei contadini.
Franzini, invece, ha uno sguardo più difficile da decifrare: il suo occhio è attratto dagli impianti industriali, ma anche dalle danze popolari; si muove spesso in solitaria, accompagnato solo da un autista; il suo fondo appare più frammentario, girato con discontinuità.
Si è così reso necessario un lavoro di ricerca per riuscire a interpretare, datare, geolocalizzare quelle immagini. Ferrone e Manzolini si sono avvalsi di studi storici, ma soprattutto di diari e memorie relativi alla campagna di Russia: alcuni ben noti e pubblicati negli anni successivi alla guerra, come Mai tardi di Nuto Revelli e Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern, altri individuati grazie alla bibliografia riportata nei saggi, come il diario del tenente medico Guido Balzani, o trovati nel web, come Sette mesi con la Pasubio di Giacomo Bruno Di Daniel, o infine depositati presso l’Archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, come quello di Remo Canetta.
Grazie a queste letture, non solo si è precisato il quadro storico generale, ma è emerso un livello personale, fatto di reazioni ed emozioni, che ha permesso di illuminare le immagini. Anche se non sempre era possibile individuare il punto preciso del passaggio della tradotta di Franzini, o di quella di Chierici [6], nei diari era riscontrabile a parole la stessa curiosità per quella sterminata pianura coltivata a grano, in cui i segni della guerra si addensavano progressivamente sempre di più. Una visione che non è la stessa “identica” per tutti, ma è “analoga”. In momenti diversi – ma simili – i soldati dello Csir, come Franzini, già nell’estate del 1941, i soldati dell’Armata italiana in Russia (Armir), come Chierici, in quella del 1942, attraversano quello spazio su direttrici diverse – ma simili: l’esperienza è comune, comuni le sensazioni, le domande, i dubbi.
Delle voci hanno così iniziato ad accostarsi alle immagini, innescando il lavoro di scrittura di Ferrone e Manzolini: la prima a emergere è stata una “sceneggiatura visiva” [7]. Necessariamente, il focus non poteva essere la disastrosa e terribile ritirata dell’Armir nel gennaio 1943: le immagini di Chierici e Franzini non la mostravano, si fermavano a una fase antecedente. O meglio, il motivo stesso per cui questi filmati sono arrivati fino a noi è che i loro autori sono tornati prima, non sono rimasti intrappolati nell’inverno russo [8]. Il limite imposto dalla natura del materiale ha così generato la possibilità di andare oltre un altro limite, quello dell’atteso, del noto: nella dimensione pubblica, evocare la campagna italiana di Russia rimanda all’immagine – questa sì, un’icona – delle interminabili file di soldati avvolti in coperte di fortuna, corpi neri nella neve. Ne Il varco non vediamo quel momento, ma quegli stessi soldati – o una parte di loro, o dei loro omologhi – “prima”. In questo senso, il film costituisce una sorta di analessi rispetto alla conoscenza del pubblico: guardando le immagini, sappiamo già da principio come andrà a finire quella spedizione, e per questo il destino di quei soldati, il loro partire sorridenti – «sembra di andare in gita!» commenta nel suo diario Remo Canetta – ci appare ancora più insostenibile.
Cucendo insieme diversi frammenti di memorie private e individuali, gli autori hanno creato un racconto finzionale «non accaduto ma verosimile» [9]. Soprattutto, hanno generato un’inversione rispetto a ciò che abitualmente vediamo nei film storici: vicende reali – magari romanzate – mostrate attraverso immagini di fiction, costruite ad hoc. Nel caso de Il varco, siamo di fronte a un ribaltamento: la narrazione è finzionale, le immagini sono “vere”. Veri i volti, la tradotta, il paesaggio, la distruzione. Una vertigine percettiva.
3. I fantasmi di una generazione
Ne Il varco la narrazione è affidata al monologo – un diario interiore – dell’unico personaggio: per la sua creazione i due registi si sono avvalsi della collaborazione dello scrittore Wu Ming 2. Ispirandosi alle domande sollevate dalle scarne notizie biografiche del cineamatore più misterioso, Adolfo Franzini, gli autori hanno immaginato una figura senza nome, con una madre russa, appartenente alla generazione nata all’inizio degli anni Dieci, ovvero quella che più è stata in guerra, iniziando con l’Etiopia nel 1935 e concludendo nel 1945. Per molti – o meglio, per quelli che l’hanno vissuto per intero, sopravvivendo ai diversi interventi, e fallimenti – quel decennio in guerra si è chiuso con le esperienze drammatiche del 1943-1945: dalla ritirata di Russia alla prigionia, dall’8 settembre alla deportazione come Imi (Italienische Militärinternierte). Le loro memorie sono rimaste indelebilmente segnate, tuttavia sovrascrivendo quello che era accaduto prima:
La guerra di Etiopia, il fronte occidentale, la campagna di Grecia, sono incise nel loro animo. Ma quando rivivono la ritirata di Russia, quando rivivono la prigionia di Russia, vanno in trance. Allora i visi si contraggono, le mani tremano, la follia riaffiora negli sguardi attoniti [Revelli 2010, 9].
E lo stesso, certamente, accade agli Imi ritornati dai campi nazisti.
A questo doloroso cumulo di memorie private probabilmente è dovuta l’assenza dalla memoria pubblica della consapevolezza di cosa è stata la guerra d’Etiopia. «La più grande campagna coloniale della storia» [Dominioni 2008, 5] e «la vera guerra fascista» [Rochat 2002, 698]: gli storici che vi si sono dedicati – a dire il vero, non tanti – ne hanno sottolineato con precisione la natura, ma raramente i loro approfondimenti sono stati recepiti in ambito pubblico. A tutt’oggi, la percezione per le responsabilità italiane in quella guerra coloniale e razzista – in cui sono stati usati come strumenti di combattimento antiguerrigliero (“antipartigiano”) i gas, ma anche i rastrellamenti, le deportazioni e i massacri di civili – è minima, per non dire assente. I fantasmi di quella generazione si sono dissolti nei suoi traumi successivi, senza depositarsi nelle memorie familiari, senza arrivare alla coscienza nazionale.
Fermando il tempo a “prima”, gli autori de Il varco hanno voluto dare voce a quei fantasmi, a quei demoni, che riaffiorano nelle fotografie e nei filmati di allora. L’istante è stato catturato, i gesti e le espressioni anche. E non essendo descrizioni o disegni, ma frammenti di passato impressi su pellicola fotosensibile, riemergono dai cassetti delle nostre case nella loro immediata crudezza.
A dare corpo visivo ai demoni del personaggio fittizio ma verosimile, ci sono dunque immagini vere: quelle filmate da Giuseppe Ferro in Etiopia, nei primi giorni di quella campagna [10]. Appaiono davvero come fantasmi, senza spiegazione, senza commento, lasciate al loro impatto visivo senza filtro: l’occhio del cineamatore è attratto dall’esotismo e dall’orrore. In un crescendo parossistico, i soldati italiani nuotano nudi, come in vacanza, nelle acque del fiume Tacazzé, scherzano tra loro, passano in rassegna i cadaveri di alcuni guerrieri etiopi, guardano ascari eritrei che saltano e danzano in modo sfrenato.
Anche nel viaggio verso il fronte russo, i soldati sulla tradotta incontrano figure che attirano il loro sguardo: le stazioni sono percorse da ebrei con la stella cucita sugli abiti o con un cencio chiaro – giallo, sappiamo – allacciato attorno al braccio, costretti a pulire attorno ai vagoni.
26 luglio
[...] Alle 11,10 siamo a Stolbtzy, Molti ebrei, uomini e donne, tutti con la stella gialla sul petto e sulla schiena, vagano lungo i binari: scalzi e cenciosi, passando da una tradotta all’altra, trascinano un secchio ed una scopa. Devono raccogliere le immondizie che le tradotte seminano nelle stazioni. Fingono di lavorare, come cani affamati chiedono pane e minestra. La fame e gli stenti li hanno inebetiti. Visi malati, stanchi, rassegnati: occhi pieni di fame. Alcuni bambini hanno forse sei anni. Alcune ragazze, forse appena rastrellate, sono ancora belle, in carne: con pudore si aggiustano gli stracci che le coprono.
Provo pena e nausea. Quasi tutti gli alpini guardano perplessi: guardano, non capiscono ... [Revelli 2001, 6].
È Chierici a filmare questo momento, sono Revelli e Canetta a riportarlo sui loro diari. Guardano incuriositi gli ebrei, li descrivono con attenzione, stupiti, perché non capiscono. I soldati della generazione precedente, quelli che hanno visto l’Etiopia, probabilmente si interrogano meno, perché hanno già visto qualcosa di “analogo”. Hanno già visto – e ripreso – «il dolore degli altri» [Sontag 2003].
Il racconto in prima persona, e in soggettiva visiva, procede: il monologo è un amalgama delle voci dei memoriali e dei diari, di cui riprende il tono scarno di un’intimità che a noi suona quasi anacronistica. La retorica di quegli anni penetra anche i pensieri privati.
E allo stesso tempo si ritrovano ne Il varco echi narrativi e visivi che vanno da l’Histoire du soldat di Stravinskij a Heart of Darkness di Joseph Conrad, da Les bienveillantes di Jonathan Littell a Full Metal Jacket di Kubrick. Ci sono le guerre italiane del 1935-1945 e gli altri fronti di quel periodo, le guerre coloniali e l’immaginario che abbiamo del Vietnam. Sono echi, risonanze. E mentre i due autori stavano concludendo la parte di ricerca, hanno ottenuto il permesso di andare sui luoghi, oggi. Ritrovandovi un’altra guerra, quella del Donbass, tuttora in corso. Le analogie con i filmati del 1942 – i paesaggi, i treni, le vacche, i mercati, i cimiteri ebraici abbandonati e le nuove sepolture militari – risuonavano in modo così forte da entrare nel film come contrappunti, come “varchi” temporali. Le sequenze più strettamente belliche – l’addestramento, la casa del cecchino – sono state girate, con il suo sguardo, da un ex soldato: l’autista della produzione, l’unico a poter procedere nelle zone più a rischio.
Il film si apre e si chiude con immagini “imperfette”: corrosione della pellicola ed errori di esposizione generano delle immagini dove predomina una luce biancastra, in cui le figure umane assumono una consistenza fantasmatica.
Le prime provengono dal fondo di Guglielmo Baldassini (Genova 1895 - Milano 1945), tra i più datati tra quelli conservati presso Home Movies. Girate negli anni Venti per riprendere giochi di bambini nella neve, queste immagini possiedono quella natura evocativa fatta di «oblii, decadimenti, riemersioni» [Bertozzi 2012, 54]: il deterioramento dell’emulsione genera aloni quasi pittorici. Le immagini così assumono sia il valore storico di filmati “pionieri” degli anni Venti, che un valore poetico, sospeso nel tempo, ammantato di «aura»: quel «valore cultuale» che trova il suo ultimo rifugio, secondo Benjamin, nelle prime fotografie e «nell’espressione fuggevole di un volto umano» [Benjamin 1966, 28].
Malinconia e bellezza emanano dalla materia filmica errata e corrosa dal tempo, affiancandosi tuttavia alla consapevolezza storica di quello che scorre davanti ai nostri occhi. Per questo percepiamo con più peso le immagini finali, girate da Franzini in modo spezzato, convulso, sbagliando l’esposizione o l’apertura del diaframma, mentre la strada si fa sempre più dissestata, i profughi sfilano a gruppi, la neve diventa un’allucinazione.
Lo scioglimento narrativo è affidato a una visione delle Alpi, sempre di Franzini, al pensiero di un sogno impossibile, quello di tornare a casa, accorgendosi solo un attimo prima della catastrofe imminente, già inscritta in tutto quello che è accaduto prima.
Per pochi, per caso, per una licenza al momento giusto o per pura fortuna, questo avvenne. E per alcuni di loro quell’esperienza determinò una scelta, che li porterà sulle montagne a combattere per la guerra partigiana.
La tradotta procede lentamente, quasi a passo d’uomo. Con le gambe che ciondolano da un vagone della truppa, osservo la campagna, le cose. Sul fondo di un’ampia radura verdissima, un’isba, un’isola di pace: un tarlo mi rode in testa, rincorro a lungo con la fantasia un sogno che stranamente non mi umilia, che mi piace: disertare [Revelli 2001, 10].
Bibliografia
- Benjamin W. 1966
L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, Torino: Einaudi (ed. or. 1936; raccolta saggi 1955, Suhrkamp: Frankfurt a.M.) - Bertozzi M. 2012
Recycled cinema. Immagini perdute, visioni ritrovate, Venezia: Marsilio - Didi-Huberman G. 2005
Immagini malgrado tutto, Milano: Raffaello Cortina (ed. or. 2003) - Dominioni M. 2008
Lo sfascio dell’Impero. Gli italiani in Etiopia 1936-1941, Roma-Bari: Laterza - Fiorini K. e Santi M. 2005
Per una storia della tecnologia amatoriale, in Farinotti L. e Mosconi E. (eds.) Il metodo e la passione. Cinema amatoriale e film di famiglia in Italia, “Comunicazioni sociali”, 3 - Simoni P. 2013
Archivi filmici privati: la rappresentazione del quotidiano e gli home movies, “Mediascapes journal”, 2
https://ojs.uniroma1.it/index.php/mediascapes/article/view/11615 - Simoni P. 2015
Eyewitnesses of History: Italian Amateur Cinema as Cultural Heritage and Source for Audiovisual and Media Production, “VIEW Journal of European Television History and Culture”, 4 (8)
http://doi.org/10.18146/2213-0969.2015.jethc092 - Revelli N. 1993
La guerra dei poveri, Torino: Einaudi 1993 (1a ed. 1962) - Revelli N. 2001
Mai tardi. Diario di un alpino in Russia, Torino: Einaudi (1a ed. 1967; ed. or. 1946 Cuneo: Panfilo) - Revelli N. 2010
La strada del Davai, Torino: Einaudi (1a ed. 1966) - Rochat G. 2002
Le guerre del fascismo, in Barberis W. (ed.), Storia d’Italia, Annali 18: Guerra e pace, Torino: Einaudi - Sontag S. 2003
Davanti al dolore degli altri, Milano: Mondadori (ed. or. 2003)
Note
1. Corsivo dell’autrice.
2. Voce “immaginare” del vocabolario Treccani.
3. Sulla scoperta del film amatoriale come fonte d’archivio e risorsa sia per la ricerca che per la produzione audiovisiva, si veda Simoni 2015. Sulla dimensione quotidiana della storia in questa tipologia di documento, rinvio invece a Simoni 2013.
4. Italia, 2019, prodotto da Kiné, Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia, Istituto Luce Cinecittà, Rai Cinema, con il contributo di Emilia-Romagna Film Commission.
5. Il fondo era già stato analizzato e schedato dai figli del cineamatore prima della donazione all’archivio. Home Movies ha promosso la prima valorizzazione pubblica di alcuni filmati di Enrico Chierici con la proiezione di Da Bologna a Stalino (Italia, 1942, 20’, 9,5mm), restaurato nei laboratori dell’Università di Udine e presentato in anteprima al festival Il cinema ritrovato (Bologna, 2012).
6. Enrico Chierici in realtà ha corredato i suoi filmati di note abbastanza minuziose, quindi il discorso vale soprattutto per gli altri materiali.
7. Completano il corpus dei materiali d’archivio utilizzati per il film alcuni cinegiornali e documentari del Luce.
8. Nelle note del loro archivio, i figli di Enrico Chierici ricordano che il padre usufruì di una licenza all’inizio di dicembre 1942, tornando in Italia (e portando con sé, probabilmente, negativi e pellicole). Nel gennaio 1943 ripartì per il fronte, ma la tradotta arrivò solo fino a Leopoli, agli inizi di febbraio 1943, quando era ormai in atto la ritirata dell’armata italiana. Qui riuscì a ricongiungersi col suo reparto e a far ritorno in Italia con mezzi di fortuna.
9. Dalle note di regia di Ferrone e Manzolini.
10. Il filmato è stato poi inserito dal figlio, il filmmaker Luca Ferro, nel film Impressioni a distanza (Italia, 1975). Il fondo di Giuseppe Ferro è conservato presso Home Movies, Archivio nazionale del film di famiglia.
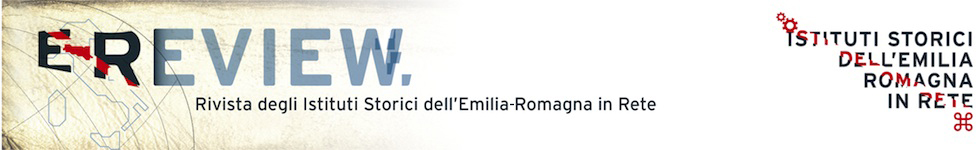
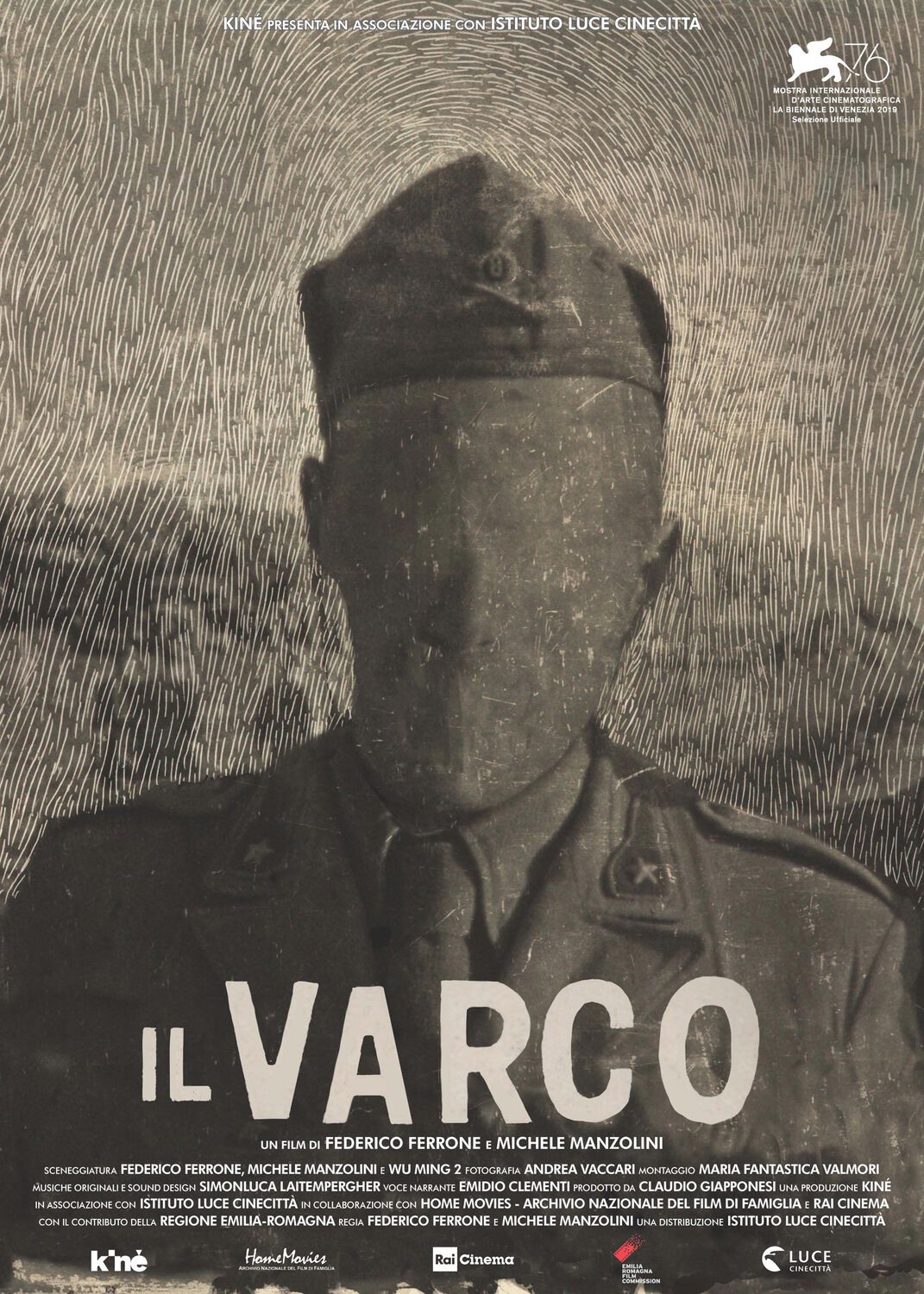
![Fig. 2. Tradotta [questa e le successive immagini sono tratte da “Il varco”]](././sites/default/images/articles/media/227/pirazzoli-2020-02.jpg)