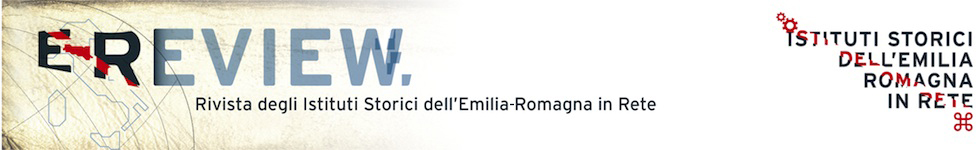«Non bisogna far morire il Po.
Il fiume si salva se si salvano le sue storie»
[Conti 2012, 217]
Il Po rappresenta un luogo cardine per la concettualizzazione novecentesca del paesaggio italiano (e quindi per l’italianità stessa) e la sua trasfigurazione filmica. A partire dalle riflessioni teoriche delle riviste di epoca fascista e arrivando alle successive elaborazioni neorealistiche e autoriali, l’ambiente padano ha ricoperto un ruolo di primaria importanza per le sue peculiarità paesaggistiche e sociali. La rappresentazione cinematografica ha contribuito a costruire immagini cristallizzate di una realtà in costante trasformazione [Basilio, Pinna 2025] definendo e, al medesimo tempo, venendo definita dai mondi naturali e culturali inquadrati dalla cinepresa. Se numerose sono le ricerche dedicate alle elaborazioni cinematografiche del paesaggio fluviale realizzate da registi come Luchino Visconti o Michelangelo Antonioni [Costa 1989; Fontanelli 1990; Candia 1995; Bernardi 2009; Guerra 2010; Micalizzi 2010; Roche 2015], più esiguo è il numero degli approfondimenti sulle declinazioni del “grande fiume” nei film di intrattenimento. Non è questa la sede per affrontare dal punto di vista teoretico la definizione di “cinema popolare”, concetto «ingannevole» [Starace 2019, 97] che risente dell’eredità di scansioni nette tra una cultura considerata alta e una bassa, tra una filmografia “impegnata” e una di stampo commerciale; assodata la problematicità di quest’etichetta euristica, verranno evidenziati alcuni caratteri salienti di questa tipologia di produzioni che porranno le basi per analisi puntali su alcuni casi studio.
Una dogmatica politique des auteurs non deve necessariamente imprimere la sensibilità del metteur-en-scene su opere che, nella declinazione di convenzioni legate al genere di afferenza e nella riproposizione (variata) dei topoi, individuano il loro grimaldello per la conquista del pubblico. In questa ricerca, verrà adottato un approccio fluido che tenga conto di diverse teorizzazioni sull’ontologia del cinema senza rinunciare ad abbracciare le compenetrazioni tra queste diverse dimensioni: si può infatti individuare una marca autoriale in produzioni che si appoggiano a una facile leggibilità, garantita dal riuso di costrutti narrativi e visivi consolidati. Isolde Standish, citando Steve Neale, sostiene infatti che il cinema di genere deve rispettare una precisa dinamica per essere definito tale: da un lato si deve conformare alle aspettative dello spettatore ma, per mantenere la sua freschezza, deve anche presentare elementi di novità [Standish 2005, 271]. Queste due prospettive possono e devono convivere. Il cinema popolare ha saputo originare «una vera e propria koiné» degli immaginari che rende possibile la costruzione di spazi di sintesi e/o di scontro tra una serie di istanze circostanziali e le diverse individualità spettatoriali [Manzoli 2012, 12-13]. Per la sua vocazione omnicomprensiva, è con le grandi masse novecentesche che il cinema commerciale intrattiene un legame privilegiato: fornisce loro strumenti critici e modelli comportamentali, creando un rapporto biunivoco di comunicazione tra le identità culturali e le opzioni di consumo [Manzoli 2012, 25]. Secondo Umberto Eco, questo processo di informazione della mentalità del pubblico avviene secondo una direttrice top-down da parte di un’industria che, attraverso l’adattamento mimetico ai gusti dello spettatore proletario (forse sarebbe più aggiornato parlare di spettatore massificato), lo illude che i «modelli culturali borghesi [siano una sua] espressione autonoma» [Eco 1964, 19]. Tuttavia, come sostiene Giacomo Manzoli, la cultura popolare ha creato spazi di negoziazione che si sottraggono alla tradizionale pedagogia statale-istituzionale, saldamente stretta nelle mani di specialisti ed esperti. Film e fumetti hanno creato arene di mediazione con il reale, lontane da una cultura «pensata» ed «infungibile» [Manzoli 2012, 61]: il cinema di genere ha saputo nella sua inorganicità offrire paradigmi cognitivi e interpretativi lontani da quelli dell’industria culturale elitaria che, grazie alla facile leggibilità dei suoi prodotti, sono penetrati nell’immaginario spettatoriale. La fruizione di produzioni pop diventa il luogo di scontro tra le forze di resistenza alla cultura egemonica e quelli originati da quest’ultima [Brizio-Skov 2011, 3]. In quest’arena, l’incontro tra il testo e il consumatore diventa un momento di riflessione sulla modernità e le sue progettualità politiche. Il cinema di genere, pertanto, non si configura come mero strumento di evasione ma piuttosto come una rete discorsiva sincronizzata con i cambiamenti e le trasformazioni della società italiana di cui, a seconda dei casi, asseconda posizioni conservatrici, progressiste e/o talvolta rivoluzionarie [Brizio-Skov 2011, 2].
A partire da queste considerazioni, il presente saggio si propone di analizzare come lo spazio naturale-culturale legato al Po sia stato inquadrato dal “cinema popolare”, in particolare dal genere orrorifico, combinando la metodologia della Film Analysis con quella della storia culturale. In un arco temporale che va dalla fine degli anni Cinquanta alla fine degli anni Ottanta – golden age per questo tipo di produzioni -, la declinazione in chiave nazionale (o regionale) di topoi narrativi e visuali, spesso ereditati da matrici culturali transazionali, ha generato nuovi paradigmi di interpretazione del rapporto tra l’individuo e l’ambiente fluviale fungendo da attore di trasformazione delle identità stesse dei luoghi. La translazione nel contesto padano dei costrutti del “cinema di genere” porta a una ri-significazione di questo ecosistema. Nonostante ogni genere cinematografico abbia avuto almeno una trasferta sul “grande fiume” – inclusi il melodramma e l’erotico, mentre nel cinema contemporaneo si segnalano anche il post-apocalittico e il neo-western [Ugolotti 2024] -, questo articolo si focalizzerà su un filone preciso: l’horror/giallo rurale. Questa scelta permette di verificare come l’ambientazione nel microcosmo del Po renda possibile lo sfruttamento di specificità legate al suo contesto naturale-culturale che, a loro volta, definiscono le direttive di racconto e di messa in scena. Oltre all’unicità di soluzione visive e narrative presenti in queste opere, la decisione di circoscrivere l’analisi al genere orrorifico deriva anche dall’importanza che la “regionalità” riveste nell’adattamento di una matrice considerata, come vedremo in dettaglio, lontana da una presunta sensibilità nazionale. Le specificità padane non sono mero sfondo di questo sottogenere ma sono una vera e propria risorsa tanto per l’individuazione particolare di questo corpus rispetto alle altre produzioni (tanto italiane quanto provenienti da altre cinematografie come quella statunitense e britannica) quanto per la sua riuscita in termini commerciali ed artistici. Domanda ultima della ricerca è verificare come l’immaginario orrorifico trovi una sua specificità italiana proprio grazie alla declinazione regionalistica, discostandosi o metabolizzando matrici estere o cosmopolite. La declinazione gotico-padana è quindi in grado di configurarsi in termini unici in merito di visualità e racconto, permettendo così di dare preminenza al rapporto tra individuo e paesaggio. In questa sinergia, mediata dalla cinepresa, si insinua in sottotraccia anche una riflessione sul rapporto tra l’ambiente e la modernità che riconfigura sotto il segno del perturbante e dell’abietto l’ecosistema fluviale.
Prima di procedere con l’analisi di alcuni casi studio, è necessario contestualizzare questo genere nella storia del cinema italiano ed enuclearne le caratteristiche costitutive, soprattutto in rapporto al tema della rappresentazione del paesaggio.
1. Mostri da immaginari lontani: dall’adozione di modelli stranieri alla “regionalizzazione” dell’orrore
Ragionare su un prodotto culturale iper-localizzato come l’horror padano richiede una riflessione introduttiva anche sull’italianità (vera o presunta) del genere orrorifico più in generale. La scarsa presenza di soggetti a tema soprannaturale nella cinematografia italiana della prima metà del Novecento è stata interpretata da critici e intellettuali come una “naturale” estraneità della sensibilità gotica o macabra al carattere nazionale: questa distanza culturale è stata giustificata ricorrendo anche a fattori ambientali e paesaggistici. Una recensione de Il suicida n. 359 (1913) asseriva che «certe follie collettive potranno anche frequentemente maturare tra le nordiche nebbie del Tamigi, non al certo presso le ridenti soleggiate rive del Po» [come citato in Venturini 2014, 5]. Secondo queste suggestioni, il mostruoso e il demoniaco sarebbero esclusiva del gusto dei popoli nord-europei; il critico parmigiano Pietro Bianchi, recensendo La moglie di Frankenstein (1935), perpetua lo stereotipo che «da buoni mediterranei non abbiamo alcuna simpatia per gli orrori» [come citato in Venturini 2014, 5]. Ancora nel 1977, il critico Massimo Moscati asserisce che il film horror «non è specialità italiana ma anglosassone» [Moscati 1977, 102].
A parte qualche fugace apparizione dell’orrorifico nel cinema muto, riguardo il periodo precedente al momento considerato fondativo della nascita del genere in Italia (la release di I vampiri di Riccardo Freda, 1957) Simone Venturini annovera come antesignano della filmografia nazionale del terrore, Malombra di Mario Soldati (1942). Secondo lo studioso, in quest’opera di derivazione letteraria il regista ha trovato la dimensione soprannaturale nella specificità della villa in cui è ambientata l’azione: questa location è caratterizzata dalla stratificazione tra antico e moderno (inteso come gotico e romantico) che permea l’edificio e dal fatto che la natura circostante salda «spirito e luogo»» [Venturini 2014, 93-95]. Le riprese oblique esaltano il legame tra acque e profondità dell’inconscio suscitando un sentimento di paura e attrazione nello spettatore: scrive Venturini, «il paesaggio e le architetture diventano un’estensione dei corpi e dei conflitti interiori della protagonista e di un corpo sociale in rovina»[Venturini 2014, 93-94]. Malombra, pellicola a cavallo tra melodramma e racconto gotico, configura la triangolazione di rispecchiamento e compenetrazione tra ambiente, corporalità e occhio della cinepresa che caratterizzerà le future opere avatiane.
Gli horror dei primi anni Sessanta, anche per ovviare alla presunta estraneità del cinema italiano alla sensibilità orrorifica e per rispondere alla domanda del mercato nordamericano [Di Chiara 2009, 42], optano per un camuffamento finalizzato a celarne l’identificabilità nazionale: i registi si firmano con nomi stranieri, si opta per cast internazionali e le vicende sono perlopiù ambientate in Germania o in Inghilterra [Baschiera, Hunter 2016, 14]. Centrali nelle narrazioni e caratterizzati come attributi del potere degli antagonisti, sono i castelli nord-europei nelle cui segrete avvengono ogni tipo di nefandezze [Di Chiara 2009, 69]. Dopo i prototipi del genere, anche per esigenze di budget, il gotico italiano verrà perlopiù ambientato in ambienti chiusi popolati da pochi personaggi: «una vera e propria corsa al ribasso» [Di Chiara 2009, 137]. Questi primi esempi di horror made in Italy non ebbero un buon successo di pubblico; Andrea Bini sostiene che il pubblico nazionale, inebriato dal miracolo economico, non riusciva a vedere nella modernità e nell’industrializzazione (e la conseguente emancipazione della donna, tema centrale di queste opere) una fonte di paura. Produzioni che riflettevano sui lati oscuri della società non sembrano attecchire negli spettatori, ancora troppo spaventati dal recente passato di povertà e miserie [Bini 2011, 62-63]. Nonostante il mascheramento del paese di provenienza, i film mantengono soprattutto nelle fonti d’ispirazione (letteratura di consumo e fumetti) una fortissima relazione con la cultura nostrana [Di Chiara 2016, 41]: il terrore italiano si configura quindi come il risultato di una serie di «operazioni intertestuali complesse, che partono dall’imitazione di contemporanei prodotti di successo ma fondono questi modelli espliciti con istanze provenienti dalla storia del cinema americano ed europeo» [Di Chiara 2009, 14]. Questo genere, insieme ad altri esempi di intrattenimento popolare come il musicarello e lo spaghetti western, si configura come prodotto impossibile da circoscrivere entro la pura cornice nazionale e, nel medesimo tempo, come fallimento di un progetto che mira ad essere operazione economicamente e culturalmente transnazionale [Baschiera, Di Chiara 2010, 31]. Questa identità ibrida (anche produttiva) permette il superamento dell’iniziale camuffamento con l’avvento del giallo, figlio dell’apertura dei limiti di rappresentabilità in termini di sesso e violenza a seguito delle proteste sessantottesche [Di Chiara 2009, 2011; Venturini 2014, 68]: questo sottogenere decide di sfruttare le possibilità atmosferiche delle location italiane, smorzandone il tono di specificità culturale e folklorico: si privilegiano le grandi metropoli e ambienti lussuosi legati al jet set. Abbandonando l’ambientazione gotica ottocentesca, con Dario Argento l’horror si fa «attuale» [Bocchi 2024, 16]. Il giallo propone un’identità italiana «neutrale», generata da un’operazione di «remapping» del territorio nazionale seguendo le nuove coordinate della società dei consumi, della mobilità di massa e della modernizzazione [Baschiera, Di Chiara 2010, 34-35; Bondanella, Pacchioni 2021, 446]. I suoi protagonisti sono spesso stranieri, privi di una casa e di patria (Heimat), che vivono negli spazi «in between» della modernità [Needham come citato in Baschiera, Di Chiara 2010, 35]. Questa traslazione urbana-cosmopolitica dell’horror nostrano esibisce città da incubo in cui si muovono attori provenienti dall’estero (che girano in inglese), i cui personaggi sono spesso risucchiati in spirali di violenza [Bini 2011, 65]. La topografia “argentiana”, seppur innegabilmente italiana, è tuttavia indecifrabile in quanto ottenuta combinando diverse location in sede di montaggio [Moscati 1977, 125]. Proseguendo sulla linea marcata dai prototipi gotici, la donna assassina del giallo è la prosecuzione della strega dei film di Mario Bava e Riccardo Freda, incarnazione della minaccia per una mascolinità aggredita dall’emancipazione femminile [Bini 2011, 70-71]. Questo genere è marcato da una violenza esplicita in cui gli stravaganti metodi di assassinio rappresentano il dispositivo attrattivo [1] inserito in trame più o meno lineari; il mondo in cui sono ambientate le vicende è cinico, avido, senza speranza di redenzione e caratterizzato dalla depravazione sessuale [Bondanella, Pacchioni 2021, 434].
Il giallo vive nella sua fase più matura (1970-1980) un cambiamento di segno che sostituisce alle metropoli geograficamente indeterminate con realtà locali, lontane dalla modernità della società del benessere e consumo: si rinuncia alle atmosfere cosmopolite ed esterofile precedenti per riscoprire le specificità del territorio nazionale. Nell’horror post-Sessantotto vengono abbandonati tanto i teatri di posa quanto i centri urbani e si va alla ricerca di contesti contadini e periferici. Il cinema del terrore, grazie alla sua inedita «vocazione realistica», opera una «una molteplice scoperta delle diverse Italie» [Venturini 2014, 70-71]. Con occhio quasi etnografico, il gotico rurale estende la geografia dell’orrore italiana «predisponendo un viaggio di attraversamento di una sorta di wilderness e alterità socioculturale» [Venturini 2014, 71]. La topografia del genere, in cui si fondono paesaggio e tradizioni locali per generare il perturbante, si estende dalla Sabaudia di Reazione a catena/Ecologia di un delitto (1971) alle Langhe del parodistico Hanno cambiato faccia (1971), dalla Basilicata di Non si sevizia un paperino (1972) alla montagna trentina di Buio Omega (1979). Gli esempi sono numerosi e non verranno qui descritti: prima di affrontare la declinazione padana del gotico, dovremo tuttavia analizzare brevemente alcuni di questi film per meglio contestualizzare la rappresentazione del Po all’interno di questo sottogenere. Se Reazione a catena/Ecologia di un delitto già dal titolo sottolinea il legame tra ambiente naturale e vicenda orrorifica [Lowenstein 2014, 131-132], con Non si sevizia un paperino di Lucio Fulci vengono definitivamente abbandonate le atmosfere urbane e cosmopolite di Argento. Questa vicenda legata a sacrifici e cerimonie stregonesche doveva essere inizialmente ambientata a Torino tra gli operai di origine meridionale che lavorano nelle fabbriche del Nord [Fisher 2014, 169]; il regista scelse poi di spostare l’azione in un Sud dimenticato dalla modernizzazione.
In un mondo sospeso tra religione e magia, l’unica figura contemporanea, proveniente da immaginari “argentiani”, è quella di Patrizia (Barbara Bouchet), ricca milanese tornata nel villaggio di origine del padre, che vive in un’abitazione dal design avveniristico. Il film adotta uno stile doppio: se riproduce stilemi del documentarismo antropologico per il contesto contadino premoderno, le scene nella villa utilizzano gli stilemi dell’horror cosmopolita [Bonadella, Pacchieri 2011, 451-452]. Questa dicotomia, oltre che stilistica, è centrale anche nel film stesso: si veda ad esempio l’inquadratura iniziale in cui una panoramica mostra una verde valle della Basilicata che improvvisamente viene tagliata da una autostrada in cemento. Il movimento orizzontale della cinepresa rivela le mani della “maciara” (Florinda Bolkan) che disseppelliscono delle ossa di un bambino della terra. La colonna sonora ripropone un canto antico a sottolineare lo scontro tra una modernità estranea al paesaggio e il suo cuore pulsante fatto di riti e tradizioni. Questa triangolazione orrorifica mostra come la natura selvaggia conviva con l’architettura delle grandi infrastrutture del boom e, ad esse, si affianchi la permanenza del magico. Il film dissemina luoghi, situazioni e oggetti legati alla contemporaneità che nel contrasto con il folklorico orrifico risultano ancora più stranianti: da una televisione che trasmette un western alla musica rock che accompagna la vendetta contro la “maciara”, dai tecnologici mezzi di investigazione della polizia al brano di Ornella Vanoni che chiude il film. Non si sevizia un paperino si configura come una riscoperta di un paesaggio umano e culturale che la società del benessere non riesce a soffocare. Come afferma un personaggio: «abbiamo costruito le autostrade ma non siamo riusciti a vincere la superstizione». Quest’opera di Fulci è speculare a La casa dalle finestre che ridono, non solo per la risoluzione della trama gialla (l’omicida è il prete) ma soprattutto per la centralità di subculture rurali, dimenticate dalla modernità. L’arcaico risponde agli attacchi della contemporaneità con atti di violenza estrema. La critica dell’epoca si divise sull’interpretazione da dare al film: vi fu chi vide la riscoperta folklorica come un atto di resistenza al “sistema” e chi invece accusò Fulci di rappresentare con superficialità il Sud e le sue tradizioni, senza proporre una sufficiente analisi sociologica e politica dell’arretratezza del Meridione [Noto 2014, 217].
Non si sevizia un paperino segna una rivoluzione nell’innesto del paesaggio italiano nell’horror. Se altri film, come detto in precedenza, sono ambientati interamente o parzialmente in città di provincia (a cui si aggiungono Bergamo in La farfalla con le ali insanguinate, 1971; Pavia in 5 donne per l’assassino, 1974; San Benedetto del Tronto in Il vizio ha le calze nere, 1975; Padova in Il gatto con gli occhi di giada, 1977), va tuttavia segnalato che se in tutte queste opere appaiono le funzioni dialettiche città storica/modernità e città turistica/luogo dell’orrore, rappresentate grazie a variazione di stile e cambiamenti atmosferici delle scelte di fotografia, questi ultimi si muovono nella scia di un cosmopolitismo argentiano che si limita a sfruttare le location. Il film di Fulci non solo rifiuta il contesto borghese di questi altri gialli ma fa risiedere proprio nella cultura rurale e premoderna la sede dell’orrore. A creare il sentimento perturbante, ricorrono tanto i paesaggi naturali, le architetture del villaggio e le credenze tradizionali (dalla tarantolata alla magia nera), rese ancora più disturbanti dallo scontro con una modernità esterna ma più vicina alla sensibilità degli spettatori urbanizzati. Sulla scorta del film di Fulci, si colloca un’opera curiosa di Gianfranco Mingozzi (già regista di documentari sul tarantismo), Flavia l’eretica/Flavia la monaca musulmana (1974), che declina l’attenzione verso il folklore meridionale e l’antropologia di scuola demartiniana in chiave erotico-orrorifica [Laviosa 2011, 165].
Il giallo rurale costituisce un filone quantitativamente esiguo ma di forte originalità nel campo della filmografia italiana di genere: questo sottogenere estremizza l’identificazione con lo sguardo straniero (tourist’s gaze) che era già propria del thriller “argentiano” [Fischer 2014], operando però una significativa differenziazione tematica e stilistica. Il processo di esotizzazione del paesaggio naturale e antropico, traendo origine da subculture e tradizioni lontane dallo spettatore urbanizzato, portano quest’ultimo a immedesimarsi in uno sguardo che percepisce come alterità spaventose le culture locali (premoderne) del suo stesso paese. Se il giallo cosmopolita sottolineava il lato oscuro della modernità abbracciandola e da essa venendo (letteralmente) sedotto, gli horror regionalisti mostrano invece le permanenze del premoderno nell’Italia contemporanea mostrando come credi e credenze siano tutt’altro che morti o inerti all’aggressione, ma siano disposti a reagire “ripulendo” l’inquadratura da elementi esterni. Il film dell’orrore rurale opera quella spettatorialità sottrattiva (subtractive spectatorship) tipica degli slasher del decennio successivo in cui il piacere spettatoriale deriva dalla progressiva eliminazione dei personaggi in campo. Desiderio ultimo di questo sottogenere è infatti un paesaggio de-umanizzato [Lowenstein 2011, 134]. Al medesimo modo, i personaggi dell’horror rurale sembrano volere annichilire qualunque minaccia esterna (modernizzante) alla loro esistenza quale si è configurata nella Storia.
Dopo Fulci e i suoi epigoni, sarà Pupi Avati a trasferire le atmosfere del terrore nell’area padana, creando un sottogenere che è tuttavia rimasto prerogativa (quasi) esclusiva di quest’autore: il gotico padano. Nella prossima sezione verranno contestualizzati i film dell’orrore del regista bolognese all’interno della sua filmografia con un particolare focus sulle sue opere ambientate sul Po. Nelle conclusioni, proveremo a inserire i film di Avati (e altri rari casi ascrivibili a questo genere) all’interno di un discorso più generale su come l’horror sia riuscito a creare una declinazione unica del paesaggio del fiume, fondendo suggestioni straniere a elementi locali.
2. «Il fiume, col suo silenzio che non è silenzio, racconta favole»: Il gotico padano di Pupi Avati
La filmografia di Pupi Avati è strettamente intrecciata con la sua terra di provenienza, l’Emilia-Romagna. La sua carriera si può intendere come un tentativo di fare della Pianura padana un polo cinematografico alternativo a quello romano-laziale, sia in termini di infrastrutture produttive che in termini contenutistici. Il regista ha infatti scelto e privilegiato tematiche legate al suo contesto di nascita – la borghesia bolognese – o tratte dall’immaginario contadino del Nord Italia. Avati attinge ai racconti della parte materna della sua famiglia che presentavano un universo «favolistico, dalla religiosità arcaica, scaramantica, quasi magica» [Avati 2008, 13] e «preconciliare» [Maioli 2019, 63], retto da credenze medioevali che hanno resistito per secoli e oggi in via di sparizione [Avati 2008, 24, 99]. Secondo la sua poetica, fare film è un procedimento eternante che permette di salvare su pellicola, grazie alla reinvenzione artistica, mitologie e racconti destinati all’oblio: «il cinema è giocare con il proprio passato, forzandolo, reimmaginando come avrebbe potuto essere, rifacendosi un’autobiografia ideale che in qualche modo ti imbellisca» [Avati 2008, 96]. Questo tratto del suo lavoro permette al critico Lorenzo Pellizzari di sostenere che il carattere distintivo della filmografia avatiana sia proprio «l’emilianità» [Brunetta, Tortolina 2005]. Nelle parole del regista: «Narrare la mia terra, la mia gente attraverso contesti, angoli, visuali, posizioni della macchina sempre diversi. Ma lo sfondo resta sempre lo stesso. È questo il carattere identitario delle mie proposte» [Maioli 2019, 69-70]. Il legame con la regione d’origine e la lontananza dalle consuetudini produttive dell’industria cinematografica sono tanto importanti per Avati che lo sceneggiatore Bernardino Zapponi lo paragonerà ai pittori naif che nell’area padana avevano visto il loro territorio di elezione [Zapponi come riportato in Romano, Tirapelle 1987, 49]. La sua predilizione per il grottesco, stile dominante nelle opere di esordio, deriva dalla sensibilità contadina per il mostruoso che, nelle parole del regista, è da considerare «non come qualcosa su cui impietosirsi, ma una forma di spettacolo» [Sarno 1992, 24]. Avati nota una divertita compenetrazione tra paesaggio e persone che, secondo lui, conferisce agli abitanti del delta un incarnato pallido, esemplificativo di un malessere sociale e ben diverso dal «colore» rubizzo dei romagnoli. Secondo lui, «tutto ciò prestava il fianco all’immaginazione di storie cupe» [Avati come citato in Adamovit, Bartolini 2011, 96-97].
Il regista gioca sul pervertire un paesaggio familiare in fonte di orrore, operando così un ribaltamento semantico rispetto alla provincia emiliana che origina un «fantastico quotidiano» [Moscati 1977, 126; Adamovit, Bartolini 2011, 109]. L’ecosistema padano è per lui, «un contesto in cui il fantastico convive con la realtà e, al centro di tutto, c’è il tema centrale di ogni esistenza che è quello della morte» [Avati come citato in Adamovit, Bartolini ٢٠١٠, ١٠١]. Traendo ispirazione non solo da film come Psyco (1960) e Non aprite quella porta (1974) ma anche da autori quali H. P. Lovecraft, Camillo Boito, Iginio Ugo Tarchetti o Emilio Praga [Adamovit, Bartolini 2010, 13], il futuro autore di La casa dalle finestre che ridono riesce ad amalgamare variegate suggestioni che daranno origine al sottogenere del gotico padano. Sulla linea di riletture paesaggistiche operate dal cinema d’autore (Ossessione di Visconti, 1943, e Deserto rosso di Antonioni, 1964), Avati si propone di ripulire l’ambiente padano dalle incrostazioni delle rappresentazioni passate, inscrivendolo in nuove coordinate narrative e visive. Nelle sue parole:
Ecco allora la tranquilla e piacente Emilia-Romagna, che il cinema e la letteratura avevano sempre letto e proposto alla maniera bonaria di Don Camillo, improvvisamente trasfigurarsi e diventare qualcos’altro. Anziché fotografare la parte soleggiata della siepe, abbiamo ripreso la parte in ombra la parte più buia. [Avati come citato in Adamovit, Bartolini 2010, 24].
L’introduzione di elementi della tradizione locale in narrazioni di genere sarà anche il principale fattore di interesse dei critici nei riguardi delle sue opere giovanili: Callisto Cosulich recensisce freddamente il primo film di Avati, Balsamus l’uomo di Satana, esaltando però il suo «carattere apertamente regionale» [Sarno 1992, 28-29]. Una ventina di anni dopo parlerà della filmografia del regista come incentrata sull’asse progettuale di un «decentramento» rispetto alle tradizionali geografie del cinema. La riscoperta della Pianura padana non è solo un carattere tematico-stilistico della sua opera ma corrisponde a un vero e proprio progetto di riassesto industriale: l’artista bolognese, sulla scorta dell’esempio di Marco Bellocchio, sognava di «portare il cinema fuori da Roma». Il suo piano, fallito negli esiti ma testimoniato dalle sue opere, prevedeva il raggiungimento di una cinematografia finalmente nazionale, conquistata attraverso il dislocamento «in ogni regione [di] un pezzettino di Cinecittà» [Sarno 1989, 32]. Anche uno dei più importanti esiti da sceneggiatore di Avati è legato alla sua regione di origine: si tratta della prima stesura dell’ultima opera di Pier Paolo Pasolini, Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975), girato sui colli bolognesi. Nonostante sia difficilmente ascrivibile al genere in senso stretto, per la sua insostenibilità Simone Venturini lo ha definito «il più importante film dell’orrore del cinema italiano». Il paesaggio emiliano diventa paesaggio di un vero e proprio teatro della crudeltà.
I primi lavori di Avati vengono finanziati e girati in contesti emiliano-romagnoli: dal grottesco-satirico degli esordi, la ricerca artistica e produttiva del regista raggiunge il suo apice con La casa dalle finestre che ridono, vero e proprio capostipite del gotico-padano. Questo film del 1976, scritto da Pupi insieme al fratello Antonio, all’attore Gianni Cavina e al giornalista Maurizio Costanzo, venne realizzato a basso costo con finanziamenti locali e girato in soli 12 giorni con un cast di amici. Il regista lo ha definito «un cinema familiare» [Avati come citato in Adamovit, Bartolini 2010, 140]. Quest’opera racconta le truculente vicende legate a un cupo affresco di una chiesa del delta del Po e al mistero circa il suo autore. Tratto da una storia “di paura” sentita durante l’infanzia, La casa dalle finestre che ridono fonde le leggende emiliane con le suggestioni della raccolta di racconti Sette storie gotiche di Isak Dinesen (pseudonimo maschile di Karen Blixen, pubblicato per la prima volta nel 1934) con il senso di oppressione noir di Il corvo di Henri-Georges Clouzot (1943) [Sarno 1992, 43]. L’angoscia è generata dall’onnipresenza del paesaggio fluviale, vero protagonista della vicenda [Sarno 1992, 45-46], e dall’ipocrisia della comunità di provincia: questo rispecchiamento terrificante tra l’umano e il naturale declina in salsa padana la lezione del folk-horror, sottogenere esploso qualche anno prima [De Simone 2019, 216]. Il film di Avati, fondendo le atmosfere di opere come La pelle di Satana (1971) e The Wickerman (1973) al giallo all’italiana, introduce due sostanziali novità rispetto ai precedenti di Dario Argento e Mario Bava: retrodata la vicenda agli anni Cinquanta e configura come luogo del male non più la metropoli, ma la campagna emiliano-romagnola. Conseguenza di questa scelta è una vera e propria rivoluzione copernicana per la rappresentazione dell’orrore: se prima era il buio a identificare la presenza del Male, ne La casa dalle finestre che ridono sono i desolati spazi di luce malata degli argini, fotografati da Pasquale Ronchini, a esaltare il senso di inquietudine dei personaggi [Avati come citato in Adamovit, Bartolini 2010, 145]. La natura del delta si presenta come una wasteland in cui è impossibile la vita: il fiume, chiuso tra «cieli enormi che schiacciano la terra» [Avati come citato in Maioli 2019, 67-68], favorisce lo slittamento verso la pazzia del protagonista. Il corso d’acqua non è maestoso ma è rappresentato come un sistema venoso che attraversa la superficie [Maioli 2019, 67-68]. Secondo lo sceneggiatore Maurizio Costanzo, il vero proposito del film era fornire una nuova prospettiva sul quotidiano: regista e sceneggiatore volevano mostrarlo con uno sguardo nuovo, «operare uno stravolgimento della realtà attraverso gli occhi dell’anima» [Costanzo come citato in Bergantin, Lupi 2018, 327]. Il labile confine tra acqua e suolo, tra follia e ragione, tra arte e natura, fa della “liminalità” il carattere essenziale determinante dell’intero film. Anche il travestitismo del prete assassino confonde la divisione dei generi introducendo un elemento di queerness: il suo essere al contempo uomo e donna (la sfera sonora presenta una voce prima maschile e poi femminile, il corpo dell’attore Eugene Walter incorpora nel finale un inserto in cui si intravede un seno) scardina i tradizionali paradigmi identitari. Avati sembra così adottare quella pratica che, in rapporto al “New Queer Cinema”, è stata definita genderfuck: un processo di destabilizzazione del gender come categoria analitica che destruttura ogni barriera di riconoscimento sessuale [Bocchi 2024, 50]. Insieme al genere viene così decostruito l’ordine sociale tradizionale della comunità (basato sulla normazione binaria delle identità sessuali) e con esso lo sguardo dello spettatore.
Il paesaggio fluviale viene inquadrato come un mondo selvaggio e arcaico che si scontra con le istanze della modernità: il restauratore bolognese Stefano (Lino Capolicchio) giunge nella bassa ferrarese a bordo di un traghetto, un gioco dialettico di controcampi ci mostra dal suo punto di vista il suo arrivo a Comacchio. La natura è inizialmente presentata come serena e idilliaca ma una serie di marcatori visivi anticipa il senso di morte che domina il film: cadaveri di navi sono arenate sulla riva e i moli sono costituiti da infrastrutture cementizie abbandonate. Il percorso sulla barca si presenta inizialmente come un’occasione di romance: un gioco di sguardi tra Stefano e una viaggiatrice, Francesca (Francesca Marciano), sembra preludere ad atmosfere romantiche ma subito il grottesco irrompe appena sbarcati. Ad attendere il protagonista c’è Solmi, il sindaco del paese (Bob Tonelli). Il primo cittadino, il cui corpo è affetto da nanismo, è un personaggio inquietate che, nel corso della narrazione, si rivela l’unico non invischiato nelle dinamiche ipocrite del paese, anche perché estraneo alla comunità: non solo è portatore di un’istanza di modernità in quanto vuole ravvivare il turismo locale grazie al recupero di un’opera d’arte, ma nel finale sarà l’unico a rompere l’omertà chiamando la polizia. Solmi porta il protagonista alla pieve in cui è conservato il dipinto: l’ombra del male che infesta il posto è radicata nella Storia, la chiesa infatti era stata un rifugio per le SS durante le Seconda guerra mondiale («gli ultimi turisti») e successivamente ha svolto la funzione di magazzino per i carri da morto. L’edificio religioso si configura come un palinsesto storico [Fischer 2014, 165] sotto la cui superfice risiede un passato di morte. Il restauratore arriva nel paese dove si scontra con le atmosfere da paranoia “polanskiana” della comunità: la corruzione morale che infesta la gente è proiettata tanto sulla natura quanto sullo spazio urbano. L’osteria è un luogo di scontri per le parole sfuggite a causa del troppo vino, i vicoli e i canali sono caratterizzati da un senso di minaccia omicida che ricordano la città lagunare horror di Chi l’ha vista morire? (1972) e A Venezia…un dicembre rosso shocking di Nicholas Roeg (1973). In questi spazi desolati, il protagonista si muove solitario o accompagnato da comprimari di cui non si può completamente fidare. Ogni abitante è portatore di segreti da nascondere – esattamente come nel Sud premoderno di Non si sevizia un paperino [Bondanella, Pacchioni 2011, 464]. La vita della comunità è a rischio a causa delle scarse possibilità lavorative: il poliziotto locale sostiene che la disoccupazione sta spingendo i giovani verso l’emigrazione decretando così la scomparsa del paese. La razionalità del protagonista (e i procedimenti scientifici delle sue tecniche di restauro) non servono a nulla contro la coltre di orrore e morte che domina l’ecosistema del delta. Nonostante il finale aperto lasci intravedere una lontana speranza di sopravvivenza, Stefano vede morire brutalmente i suoi amici e non vi è alcuna possibilità di redenzione per gli abitanti del luogo.
Costruito sul dispositivo narrativo della detection, La casa dalle finestre che ridono è un film sulle superfici tanto materiali quanto metaforiche: la verità va grattata dietro le muffe e i silenzi, non è mai esposta allo sguardo (o all’orecchio) ma è sommersa da una coltre di ipocrisia e di marciume. Le prove dei crimini vanno disseppellite dal terreno e portate alla luce, il fiume fa riemergere cadaveri scomparsi e le canne dell’argine sono un ostacolo alla vista. Il delta è dominato dalla morte che da esso emana e ricopre ogni aspetto della quotidianità: dall’arte al sesso, dall’architettura alla biodiversità della fauna del Po (un amico di Stefano sostiene che le anguille stanno scomparendo a causa dei residuati bellici). L’acqua si manifesta come elemento dominante del film che abbraccia ed imprigiona i personaggi e causa la stagnazione del paesaggio; inoltre, la liquidità riflettente del fiume si configura come quella superfice schermica che cela macabri segreti nelle sue profondità [Admovit, Bartolini 2010, 14]. La centralità atmosferica del setting è anche segnalata da un’altra scelta stilistica che lo differenzia dal cinema popolare dell’epoca, opere marcate da una forte intrusività della colonna sonora musicale: ne La casa dalle finestre che ridono vengono enfatizzati i rumori ambientali legati sia all’ambito umano che naturale (scricchiolii di porte, versi di animali notturni ecc.) [Bondanella, Pacchioni 2011, 464]. Come in altri horror italiani, il delta in questo film si caratterizza come una wasteland popolata da rovine culturali in cui l’opera di restauro artistico di Stefano dissotterra orrori e malumori, relegati a un passato mai morto, ma al massimo sepolto da coltri storiche stratificate. Nelle parole di Venturini, il cinema di paura «attraverso l’esplorazione del paesaggio e l’indagine “archeologica” e “stratigrafica”» allude a un momento retrospettivo che fa rinvenire «segni di una presenza antica e radicata nell’orrore nella memoria culturale, nella tradizione figurativa, nel folklore nazionale» [Venturini 2014, 72-73].
La critica mostrò atteggiamenti contrastanti nei confronti di La casa dalle finestre che ridono. Rifacendosi alla presunta estraneità della sensibilità orrorifica al gusto nazionale, Pietro Pruzzo nel cattolico Rivista del cinematografo criticava il film di Avati in quanto falliva ad unire due diverse tradizioni: l’horror di matrice anglo-americana e il grottesco provinciale italiano. Maurizio Porro segnalava il riuscito uso del paesaggio padano al fine di conferire alla vicenda un carattere più realistico [Noto 2014, 210]. Lo sfruttamento dell’ambiente padano originava nella riflessione critica esiti contrapposti che però rivelano in modo univoco l’eccezionalità della visione di Avati. Per la sua radicalità e per le sue atmosfere uniche nella loro capacità di visualizzare l’orrore, La casa dalle finestre che ridono ha rappresentato un punto di svolta nella carriera di Avati diventando anche un vero e proprio oggetto di culto, citato da altri registi - si pensi a Notte italiana di Carlo Mazzacurati (1987) [Sarno 1989, 88; Sarno 1992, 46-47] – e ragione primigenia per la nascita di un vero e proprio turismo delle location (reali o immaginate) [Maioli 2019, 65]. Il successo del film ha costituito però anche un pericolo per il regista, identificato esclusivamente come il «Polanski della Bassa Padana» e incaricato dai produttori di girare delle opere fotocopia del suo capolavoro [Bergantin, Lupi 2019, 70]. Avati cercò di sviare il rischio di ripetersi con il lavoro successivo, Tutti defunti tranne i morti (1977), in cui ammanta di grottesco il gotico padano fondendo le atmosfere del giallo alla Agatha Christie a intrusioni comiche: il whodunit viene ridicolizzato trasferendo le highland scozzesi nella campagna tra Bologna e Ferrara [Maioli 2019, 58].
Un sostanziale passo in avanti nella ricerca artistica del regista si ha con il film successivo, Le strelle nel fosso del 1979, racconto fiabesco dalle tinte fosche ma non strettamente appartenente al genere horror. Quest’opera dimostra come il percorso di Avati parta dalle forme consolidate del cinema di genere per giungere a porti di approdo molto personali. Viene narrata la vicenda settecentesca di una famiglia di personaggi stravaganti che vive in una casa sull’acqua: quando la giovane Olimpia (Roberta Paladini) si ferma nella loro abitazione isolata, mette a soqquadro le loro vite finora private della conoscenza dell’amore e del sesso, conducendoli a una misteriosa morte. Per questa favola del delta, il regista parte ancora una volta dalle storie ascoltate in gioventù, legate al mondo contadino dei nonni, e le mette in scena per il puro gusto di narrare, senza volere esporre alcuna tesi: dichiarerà in un’intervista del 1981 «questo film mi prescinde e il suo significato non mi è chiaro fino in fondo» [Maioli 2019, 73]. Avati segue il suo consueto procedimento artistico: attinge all’immenso repertorio di storie della campagna padana, da quell’immaginario e da quei luoghi si lascia ispirare e trascinare. Tutto il film, infatti, è incentrato sull’atto di narrare, è costruito a scatole cinesi in cui un personaggio racconta una leggenda legata al fiume i cui protagonisti, a loro volta, ne enunciano un’altra. Il Po è, secondo Avati, un grande magazzino di materiale narrativo [Avati 1995, 253-255]. La centralità dell’ispirazione fluviale è centrale non solo in fase di scrittura, ma anche per quanto riguarda la ricerca delle location:
Le strelle è un film anomalo, totalmente suggerito dal luogo. Siamo partiti sapendo che dovevamo trovare una casa nell’acqua, con uno script racchiuso in una mezza pagina che esigeva non solo gli attori giusti, ma anche la casa. E una sera, ormai avviliti, la vedemmo. Ed era quella. […] Quella storia era lì, giaceva, mi aspettava [Maioli 2019, 73; si veda anche Ghezzi 2008, 102].
Il set della casa di Val Cantone, «tra terra e acqua» è anfibia come i personaggi che popolano il film, la natura rappresenta una prosecuzione dei loro stati d’animo: ognuno di essi non può prescindere dal rapporto con il fiume. Dal vecchio conte impazzito che si è ritirato a vivere su una barca al chierico revenant morto affogato, dalla famiglia protagonista la cui dimora è a ridosso del canale per arrivare a Olimpia abbandonata su una riva: l’elemento acquatico genera una società separata da quella di terra, definendone anche la geografia («al di là dell’acqua c’è Costantinopoli») e marcando il passare del tempo (il segno delle precedenti alluvioni coincide con la nascita di ognuno dei fratelli). L’ambiente naturale è parte integrante del loro vivere: il personaggio di Carlo Delle Piane intrattiene conversazioni col corso d’acqua, cinematograficamente rese con una dialettica di campi e controcampi, come si trattasse di un dialogo tra due personaggi in carne ed ossa. Il fiume diventa il luogo della scoperta sessuale, determina tanto la vita quanto la morte: il Po fungerà da “officiante” del matrimonio tra la ragazza e la famiglia che culmina con un misterioso “trapasso” collettivo. Dopo la consacrazione con un misto di acqua fluviale e vino, un enigmatico visitatore pretenderà le vite del padre e dei suoi fratelli, lasciandone i cadaveri esanimi sulla tavola imbandita rivolta verso il canale. In Le strelle nel fosso, Avati ripropone il mondo contadino e magico dei suoi film precedenti (inclusa l’apparizione di una Santa Rosalia dall’iconografia non convenzionale), sottraendosi però agli stilemi del genere orrorifico.
Il progetto di declinazione regionalistica dei generi cinematografici continua con il musical Aiutami a sognare (1981), ambientato nell’Appenino bolognese ma girato a Riva del Po con tanto di un numero musicale sui battelli [Bergantin, Lupi 2018, 88], e con lo zombie horror romagnolo Zeder (1983), incentrato sul tema della memoria [Bergantin, Lupi 2018, 359] e sul conflitto tra un mondo magico e le illusioni del progresso. Una delle incursioni più interessanti del regista nel gotico padano è il recente Il signor Diavolo (2019). Avati ambienta una vicenda macabra tra la Laguna e Venezia:
città scelta sicuramente non a caso dato il suo imprescindibile rapporto con l’acqua, che consente di esplorare la duplicità di questo fondamentale elemento naturale, in grado tanto di portare la vita quanto di trasformarsi in un rigurgito acquitrinoso di tormenti e sofferenze sempre più lancinanti […] data anche la sua precarietà ed instabilità congenite che rendono plausibile immaginare lo svolgersi sul suo territorio sospeso di ogni possibile accadimento [Bergantin, Lupi 2018, 533-534].
Furio (Gabriele Lo Giudice) si reca da Roma, luogo della legge e della politica, prima nel capoluogo veneto e poi nel paesino di Lio Piccolo (le riprese però sono state effettuate, ancora una volta, nel delta del Po) per indagare sull’omicidio di un bambino da parte di un coetaneo, un assassinio in cui si insinua il dubbio su una eventuale presenza del Maligno. Il viaggio del protagonista verso queste terre di nessuno, dominate da una religione superstiziosa, ricorda quello affrontato da Stefano nella Casa dalle finestre che ridono [Maioli 2019, 93]. Il signor diavolo riprende gli stilemi codificati da Avati negli altri film: il racconto nel racconto (la lettura del verbale e delle testimonianze processuali), la proiezione degli stati d’animo nell’ambiente naturale (la tempesta durante l’omicidio) e la rappresentazione di un mondo fluviale anfibio (le abitazioni sull’acqua, le passeggiate sull’argine). Come in Le strelle nel fosso, il fiume caratterizza la temporalità della narrazione (le riprese del corso d’acqua marcano i passaggi temporali) e le sue identità (la dissolvenza incrociata tra le acque e la chiesa). Un personaggio afferma: «c’è un luogo e un tempo che sono solo di quel luogo». Nel corso della sua filmografia, il cinema di Pupi Avati dimostra come la declinazione degli stilemi di genere, propri del “cinema popolare”, possa creare nuove possibilità visive e di racconto filmico dando una forte impronta personale ed autoriale ad opere costruite sulla ripetitività di architetture narrative consolidate. Il regista ha saputo creare un sottogenere di cui è quasi esclusivamente il solo rappresentante [Adamovit, Bartolini 2010, 176]. Nella conclusione verrà analizzata l’influenza di Avati su un paio di altre opere ascrivibili al gotico padano e si rifletterà come la riscrittura del paesaggio del Po nell’ambito dell’horror localistico abbia proposto nuovi paradigmi di rappresentazione per questo ambiente.
3. Conclusioni
Il gotico padano coincide con la fase terminale della stagione d’oro del giallo all’italiana a cui seguirà una fase di flessione quantitativa dell’horror che si chiuderà con la sua deriva eccessiva e gore (si pensi al filone dei cannibal movie) [Bini 2011, 54; Baschiera 2014, 46]. Il cinema di Avati resterà un esempio unico che tuttavia influenzerà fortemente in termini di atmosfere e ambientazioni la filmografia del terrore nostrano. Il caso più vicino è Solamente nero di Antonio Bido (1978). Ambientato nella laguna veneziana, quest’opera racconta le vicende di Stefano, interpretato da Lino Capolicchio, professore universitario che si trova invischiato in trame di morte. Le similitudini con La casa dalle finestre che ridono sono tante: la presenza del medesimo attore che impersona un personaggio dallo stesso nome, il suo arrivo con il traghetto sull’isola lagunare si configura inizialmente come sito dell’incontro amoroso per poi trasformarsi in sede dell’orrore. I due Stefano sono messaggeri di una modernità, obbligati a scontrarsi con comunità locale che la rigetta [Bondanella, Pacchioni 2021, 58]. Anche in quest’opera l’osteria è il luogo in cui i segreti vengono custoditi, le cui superfici architettoniche sono in decomposizione così come l’integrità morale della comunità. Gli abitanti del paese hanno visi grotteschi, ad accentuarne la loro fisicità premoderna. Questa società anfibia è un sistema chiuso nei suoi silenzi e nel suo rifiuto del nuovo. Altre similarità rispetto a La casa dalle finestre che ridono (a loro volta condivise da altri gialli) risiedono nell’individuazione del prete come killer e nel ruolo del ruolo delle immagini come strumento di svelamento del mistero (il ruolo di foto e dipinti). Come nel film di Avati, gli agenti atmosferici rendono difficile la chiarezza di visione: la tempesta e la pioggia rendono impossibile a Stefano l’individuazione dell’assassino. Al pari del suo predecessore (e di altri horror regionalisti), l’ambiente circostante (non più il delta ma la laguna e l’isola di Murano) è caratterizzato da canali nebbiosi, vicoli silenziosi e piazze deserte, dialetticamente contrapposti alla Venezia popolata dai turisti [Bondanella, Pacchioni 2021, 465]. Come nel precedente Chi l’ha vista morire, il capoluogo veneto è rappresentato assecondando il tourist gaze codificato inizialmente dall’immaginario delle guide Baedeker e dalla pubblicista di viaggio [Fischer 2011, 167] per poi prendere la deriva gotica e orrorifica quando il protagonista si addentra nella comunità locale. Esemplare la scena di quest’ultimo film che prima mostra un mercato veneziano, ma “la grande bellezza” è interrotta dall’emersione di un cadavere dalle acque. Un similare destino è riservato al protagonista di Solemente nero: il paesaggio da cartolina si dischiude davanti a Stefano nella scena del giro romantico in barca. Il paradigma del “bel paesaggio” viene sottolineato dall’accompagnamento musicale allegro e da un cromatismo acceso. La scena d’amore si concluderà con un movimento della macchina da presa su un canale. Poche sequenze dopo saranno le stesse acque a inghiottire annegandolo il personaggio del medico (Sergio Mioni).
A partire da questa dualità, veniamo ora a tirare le file circa il rapporto tra il paesaggio e il gotico padano cercando di allargare la prospettiva su un autore-padre del genere (Avati) aprendosi ad altri horror similari in quanto incentrati su specificità regionali e il folklore locale. La traiettoria geografica del cinema dell’orrore italiano mostra come a seguito del processo di rimappatura del territorio nazionale, questo genere abbia saputo metabolizzare stilemi e suggestioni letterarie tanto esterne quanto indigene. Questo percorso è passato prima per un mascheramento esterofilo, prima totale e poi schiacciato dalla rappresentazione di una italianità internazionale e cosmopolita (la metropoli di Argento). L’horror rurale ha invece riproposto scoprendole subculture locali, finora relegate al melodramma neorealista o alla scrittura documentaristica: in alcuni casi riproponendo la compresenza di un paesaggio turistico con quello omicida del gotico (un movimento dalla piazza illuminata al vicolo nebbioso o al mulino abbandonato). Lo sguardo del racconto è identificato con quello del protagonista, adotta perciò la focalizzazione di uno spettatore appartenente al contesto urbano che si trova schiacciato dallo scontro con realtà regolate da codici arcaici. La narrazione si configura come un “viaggio nel tempo” [Fischer 2014, 165] in cui un emissario della modernità si scontra con mondi lasciati indietro dalla modernità. Come già accennato, se prima l’estraneo era il viaggiatore straniero che nella dissolutezza e nel cinismo dell’Italia cosmopolita si perdeva nel labirinto della metropoli, nell’horror rurale ora è l’italiano (urbanizzato) a perdersi in microcosmo dominato dall’omertà o dalla superstizione. La specificità orrorifica di marca italiana, prima giudicata estranea al gusto nazionale, viene riscoperta e fatta risiedere in comunità iper-locali e nel loro folklore. I mondi contadini sono rappresentati come sacche di resistenza alla modernità e depositari di un senso del magico e del mostruoso che innerva tanto il paesaggio quanto la cultura.
Il contesto padano quale appare nel gotico avatiano (e nei suoi pochi seguaci) è quindi un ambiente lugubre, segnato da una perfetta corrispondenza tra un ecosistema funereo che segna ogni aspetto della vita dei suoi abitanti. Il fiume non è fonte di vita ma torna ad essere incarnazione della Morte come lo era ai tempi delle inondazioni, prima che una propaganda industrial-estrattivista e positivista lo presentassero come domato: le sue acque uccidono e rilasciano cadaveri nascosti. L’emergenzialismo sociale e ambientale che caratterizza il racconto del Po e delle sue comunità [Ugolotti 2024] trova nell’horror padano una perfetta fusione con l’immaginario contadino presentando una collettività lasciata ai margini del benessere economico, che tuttavia rifiuta la modernità fino alle sue conseguenze omicide. La sua stessa storia ne determina l’arretratezza e la stretta connessione con la morte (il sopramenzionato palinsesto storico della chiesa de La casa delle finestre che ridono). Il “cinema popolare” sembra così rifiutare apertamente la retorica governativa di bonifica dell’ambiente fluviale (si pensi alla titolazione dell’Ente per la colonizzazione del delta padano, istituito nel 1951 [Piastra 2025]): al contrario, il sottogenere del gotico padano contraddistingue questo paesaggio come riserva del sacro e del magico, governato da forze (quasi) soprannaturali. L’horror rurale decreta l’impossibilità del trionfo della modernità sull’arcaico. Per Avati, la cultura contadina e il delta si qualificano tuttavia come una riserva di storie in cerca di un narratore disponibile a raccontarle. Inoltre, il cinema del regista bolognese resta a testimonianza di un tentativo di “regionalizzare” l’industria del cinema: cioè di creare infrastrutture predisposte alla realizzazione di prodotti che valorizzino così il paesaggio e la cultura contadina, seppur riletta attraverso codici narrativi transnazionali.
Attraverso l’analisi delle declinazioni padane di questo genere “popolare”, il saggio ha voluto dimostrare come il cinema di intrattenimento abbia saputo offrire un ritratto specifico dell’ecosistema fluviale, che è stato decisivo per trovare una specifica “via italiana” al racconto orrorifico attraverso la riscoperta del locale. Questo studio, dichiaratamente non esaustivo, vuole così porre i fondamenti per una ricerca della relazione tra cinema di intrattenimento e contesto padano, rapporto tanto frequente quanto foriero di soluzioni originali per lo story-telling cinematografico.
Bibliografia
- Adamovit, Bartolini 2010
Ruggero Adamovit, Claudio Bartolini, Il gotico padano: dialogo con Pupi Avati, Genova, le Mani, 2010. - Avati 1995
Pupi Avati, Il Po come luogo incontaminato della fiaba e della inquietudine, in Il Po del ‘900: arte, cinema, letteratura, a cura di Renato Candia, Bologna, Grafis, 1995. - Avati 2008
Pupi Avati, Sotto le stelle di un film, con Paolo Ghezzi, Trento, Il margine, 2008. - Baschiera 2014
Stefano Baschiera, The 1980s Italian Horror Cinema of Imitation: the Good, the Ugly and the Sequel, in Italian Horror Cinema, a cura di Stefano Baschiera, Russ Hunter, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2014, pp. 45-61. - Baschiera, Di Chiara 2010
Stefano Baschiera, Francesco Di Chiara, Once Upon a Time in Italy: Transnational Features of Genre Production 1960s1970s, in «Film International», 48 (2010), pp. 30-39. - Baschiera, Hunter 2014
Stefano Baschiera, Russ Hunter, Introduction in Italian Horror Cinema, a cura di Stefano Baschiera, Russ Hunter, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2014, pp. 1-14. - Bernardi 2002
Sandro Bernardi, Il paesaggio nel cinema italiano, Venezia, Marsilio, 2002. - Bergantin, Lupi 2018
Michele Bergantin, Gordiano Lupi, Tutto Avati, Piombino, La cineteca di Caino, 2018. - Bini 2011
Andrea Bini, Horror Cinema: The Emancipation of Women and Urban Anxiety, in Popular Italian Cinema: Culture and politics in a postwar society, a cura di Flavia Brizio-Skov, London, I.B. Tauris, 2011, pp. 53-82. - Biasillo, Pinna 2025
Roberta Biasillo, Pietro Pinna, Storia dei fiumi e storia del Po. Introduzione, in «E-Review», 12 (2025), DOI: 10.52056/9791257010133/04. - Bocchi 2024
Pier Maria Bocchi, So cosa hai fatto: scenari, pratiche e sentimenti dell’horror moderno, Torino, Lindau, 2024. - Bondanella, Pacchioni 2021
Peter Bondanella, Federico Pacchioni, A History of Italian Cinema, Second Edition, New York, Bloomsbury, 2021. - Brizio-Skov 2011
Flavia Brizio-Skov, Introduction, in Popular Italian Cinema: Culture and politics in a postwar society, a cura di Flavia Brizio-Skov, London, I.B. Tauris, 2011, pp. 1-16. - Brunetta, Tortolina 2005
Dizionario dei registi del cinema mondiale, a cura di Gian Piero Brunetta, Piero Tortolina, Volume I, Torino, Einaudi. 2005. - Brooks 1985
Peter Brooks, L’immaginazione melodrammatica, Parma, Pratiche, 1985. - Burch 1994
Nöel Burch, Il lucernario dell’infinito: nascita del linguaggio cinematografico, Parma, Pratiche, 1994. - Candia 1995
Renato Candia, I fantasmi del Delta, il giovane cinema del Po, in Il Po del ’900: arte, cinema, letteratura, a cura di Renato Candia, Bologna, Grafis, 1995, pp. 51-57. - Conti 2012
Guido Conti, Il grande fiume Po, Milano, Mondadori, 2012. - Costa 1989
Antonio Costa, Paesaggio e storia del cinema: alcune questioni di metodo, in «Padania: storia, cultura, istituzioni», nn. 5-6 (1989), pp. 21-28. - Di Chiara 2009
Francesco Di Chiara, I tre volti della paura. Il cinema horror italiano (1957-1965), Ferrara, Unife Press, 2009. - Di Chiara 2014
Francesco Di Chiara, Domestic Film Made for Export: Modes of Production of the 1960s Italian Horror Film, in Italian Horror Cinema, a cura di Stefano Baschiera, Russ Hunter, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2014, pp. 30-44. - De Simone 2019
Alessandro De Simone, Orrori di provincia e metropolitani: il cinema di Pupi Avati e Marco Risi, in Ieri, oggi e domani, il cinema di genere in Italia, a cura di Pedro Armocida, Boris Sollazzo, Venezia, Marsilio, 2019, pp. 215-221. - Eco 1964
Umberto Eco, Apocalittici e integrati. Comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa, Milano, Bompiani, 1964. - Faldini, Fofi 1990
L’avventurosa storia del cinema italiano. Da «Ladri di biciclette» a «La grande guerra», a cura di Franca Faldini, Goffredo Fofi, Bologna, Cineteca di Bologna, 1990. - Fischer 2014
Austin Fischer, Political Memory in the Italian Hinterland: locating the “Rural Giallo”, in Italian Horror Cinema, a cura di Stefano Baschiera, Russ Hunter, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2014, pp. 160-174. - Fontanelli 1990
Mario Fontanelli, Emilia Romagna terra di cineasti, Salsomaggiore, Salso Film & Tv Festival, 1990. - Gaudeault 2004
André Gaudeault, Il cinema delle origini, o della cinematografia-attrazione, Milano, Il Castoro, 2004. - Guerra 2010
Michele Guerra, Gli ultimi fuochi: cinema italiano e mondo contadino dal fascismo agli anni Settanta, Roma, Bulzoni editore, 2010. - Gunning 1991
Tom Gunning, D. W. Griffith and the origin of American narrative film: the early years at Biograph, Urbana, University of Illinois Press, 1991. - Laviosa 2011
Flavia Laviosa, Tarantula Myths and Music: Popular Culture and Ancient rituals, in Popular Italian Cinema: Culture and politics in a postwar society, a cura di Flavia Brizio-Skov, London, I.B. Tauris, 2011, pp. 153-188. - Lowenstein 2014
Adam Lowenstein, The Giallo/Slasher Landscape: Ecologia del delitto, Friday the 13th and the Subtractive Spectatorship, in Italian Horror Cinema, a cura di Stefano Baschiera, Russ Hunter, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2014, pp. 127-144. - Maioli 2019
Andrea Maioli, Pupi Avati. Sogni incubi visioni, Bologna, Cineteca di Bologna, 2019. - Manzoli 2012
Giacomo Manzoli, Da Ercole a Fantozzi. Cinema popolare e società italiana dal boom economico alla neotelevisione (1958-1976), Roma, Carocci Editore, 2012. - Micalizzi 2010
Paolo Micalizzi, Là dove scende il fiume: il Po e il cinema, Firenze, Aska, 2010. - Moscati 1977
Massimo Moscati, Guida ai film dell’orrore: registi, attori, trucchi, filmografia, bibliografia, Milano, Il formichiere, 1977. - Noto 2014
Paolo Noto, Italian Horror Cinema and Italian Film Journal of the 1970s, in Italian Horror Cinema, a cura di Stefano Baschiera, Russ Hunter, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2014, pp. 207-221. - Pescatore 2009
Guglielmo Pescatore, La cultura popolare negli anni Settanta, tra cinema, televisione, radio e fumetto in Gli anni Settanta. Tra crisi mondiale e movimenti collettivi, a cura di Alberto De Bernardi, Valerio Romitelli, Chiara Cretella, Bologna, Archetipolibri, 2009, pp. 153-164. - Piastra 2025
Stefano Piastra, Acque, terre, politica. La Riforma agraria nel delta padano emiliano-romagnolo sullo sfondo della Guerra fredda in «E-Review», 12 (2025). DOI: 10.52056/9791257010133/02 - Roche 2015
Thierry Roche, “Neorealismo/paesaggio”, in Invenzioni dal vero: discorsi sul neorealismo, a cura di Michele Guerra, Parma, Diabasis, 2015, pp. 255-264. - Romano, Tirapelle 1987
Paolo Romano, Roberto Tirapelle, Il cinema di Pupi Avati, Verona, Nuova Grafica Cierre, 1987. - Sarno 1989
Antonello Sarno, Vent’anni dopo. Il cinema e la tv di Pupi Avati, Torino, Nuova Eri, 1989. - Sarno 1992
Antonello Sarno, Pupi Avati, Pavia, Il Castoro, 1992. - Standish 2005
Isolde Standish, A New History of Japanese Cinema: a Century of Narrative Film, New York-London, Continuum, 2005. - Starace 2019
Sergio Starace, Il nostro è sempre stato un cinema di genere, in Ieri, oggi e domani, il cinema di genere in Italia, a cura di Pedro Armocida, Boris Sollazzo, Venezia, Marsilio, 2019, pp. 99-104. - Ugolotti 2024
Carlo Ugolotti, La bellezza o l’apocalisse. Tendenze e trasformazioni del paesaggio padano nel cinema italiano contemporaneo, in «Quaderni del CSC», 20 (2024), pp. 82-94. - Venturini 2014
Simone Venturini, Horror italiano, Donzelli Editore, Roma, 2014. - Vitella 2024
Federica Vitella, Maggiorate: divismo e celebrità nella nuova Italia, Marsilio, Venezia, 2024.
Note
1. Uso questo termine in riferimento al cosidetto “cinema delle attrazioni” delle origini. Si veda: Gunning 1991; Burch 1994; Gaudeault 2004.