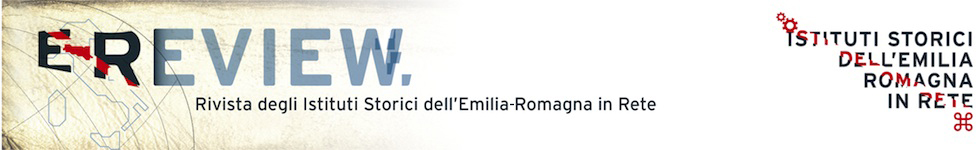1. La strage di Caià Zeret
Nel 2006 lo storico Matteo Dominioni pubblicò un fondamentale articolo sulla strage di Caià Zeret, avvenuta tra il 9 e l’11 aprile 1939 [Dominioni 2006], episodio che rimase per lungo tempo nel silenzio e su cui fecero luce proprio le ricerche dello storico torinese [1]. La vicenda di Zeret fu una delle azioni più efferate del colonialismo fascista in Etiopia ed è paragonabile, per il numero di vittime e la brutalità impiegata contro i civili, alle più famose stragi di Addis Abeba – avvenuta a seguito dell’attentato a Rodolfo Graziani – e di Debra Libanòs.
Il massacro si colloca nel più ampio contesto dei rastrellamenti nell’Alto Scioa dei due mesi precedenti: Amedeo di Savoia aveva già sostituito Graziani da più di un anno e stava cercando, oltre all’azione militare, di intavolare trattative con il ras Abebè Aregai, ancora a capo della resistenza etiopica; tuttavia il viceré venne emarginato a partire dai primi mesi del 1939 e di fatto la gestione passò nelle mani del generale Ugo Cavallero che, con tutt’altro approccio, presto impose un controllo militare severissimo [Dominioni 2008, 205-206]. Cavallero e il colonello Lorenzini il 7 marzo 1939 decisero che sarebbe stata necessaria, per indebolire Abebè Aregai, un’operazione nei pressi di Debra Brehan. La zona, attaccata tra il 14 e il 16 marzo, vide uno scontro diretto con la resistenza etiope il primo giorno, mentre nei due successivi fu scenario di intensi rastrellamenti e bombardamenti – anche ad iprite – che causarono oltre un migliaio di morti [Dominioni 2008, 209]. Tra le colonne che attaccarono la zona di Debra Brehan vi fu anche quella guidata dal tenente colonello Gennaro Sora, a capo del 20° e del 41° battaglione.
Il 30 marzo l’aeronautica avvistò un gruppo di etiopi rifugiarsi nella caverna della rivolta [2] di cui – nonostante nei documenti fosse indicata come il reparto salmerie di Abebè Aregai – Dominioni scrisse trattarsi perlopiù di feriti, anziani, donne e bambini insieme al sottocapo Tesciommé Sciancut [Dominioni 2008, 209]. Lorenzini chiese dei reparti lanciafiamme per le colonne di Sora che, insieme al suo battaglione, venne incaricato di assediare la zona, della quale restituiva questo resoconto:
accessibilità ingresso caverna facile at valle ma battuto ambedue versanti. At monte 50 metri circa parete strapiombante. Bocca caverna larga circa 40 metri habet labbro superiore at tetto. Labbro inferiore in muro at secco che spero abbattere con artiglieria. Nostre truppe at meno di 50 metri. Tentativo consigliato che posso effettuare senza poterne precisare per ora l’esito che però credo favorevole. Comunque occorre che miccia sia accompagnata almeno con 400 metri corda manilla onde tentare messa at posto anche dall’alto. [3]
Il tenente colonello Sora per riuscire a disfarsi dei ribelli dentro la grotta «chiese l’intervento di un plotone del reparto chimico. Da Massaua […] portarono con sé 100 proiettili 65/17 caricati ad arsina, una sostanza lacrimogena e una bomba C500T a iprite» [Dominioni 2008, 210]. Le armi arrivarono due giorni dopo e durante la notte ebbe inizio l’operazione. Il sergente Boaglio, come riportò nel suo diario di memorie, era stato incaricato di calare dodici bidoncini, precedentemente riempiti con l’iprite della C500T, all’ingresso della grotta:
Avevo la maschera antigas legata al petto ma mi era assolutamente impossibile mettermela al viso, avendo ambedue le mani impegnate, e non vi era un minuto da perdere poiché ora i bidoncini danzavano innanzi agli occhi, certo stupiti, dei ribelli, e sarebbe stato facilissimo per loro troncare la corda e far finire nel nulla tutto il nostro lavoro. Diedi il segnale e subito sentii lo scoppio e contemporaneamente vidi salire verso di me una densa nube di yprite vaporizzata [...]. Sparai verso la valle un razzo verde con la pistola «Very» e il cannone prese a tuonare, infilando nella caverna i proiettili ad arsina [Dominoni 2008, 211-212].
Tesciommé Sciancut riuscì a scappare, mentre i civili rimasti, arresisi due giorni dopo, vennero divisi: gli uomini vennero immediatamente fucilati «a gruppi di cinquanta», mentre le donne, insieme ai bambini, vennero «ammassate vicino alla tenda del comando» [Dominioni 2008, 211-212]. Le azioni nella grotta di Caià Zeret, secondo i calcoli di Dominioni basati sulla quantità di cibo presente nella caverna, provocarono tra i 1500 e i 2000 morti, una quantità che quasi eguaglia la strage di Debrà Libanòs.
Il massacro della grotta di Zeret tuttavia non si colloca in una posizione paragonabile alla strage del monastero solo per le barbarie commesse, ma soprattutto perché Gennaro Sora, al comando dei battaglioni incaricati di annientare i patrioti etiopi a Zeret, come Rodolfo Graziani fu un militare decorato e commemorato positivamente tanto durante il ventennio quanto a guerra conclusa, nel nuovo contesto dell’Italia antifascista [4]. I due casi si trovano quindi accomunati dai cortocircuiti della memoria pubblica che non ricorda i crimini del colonialismo italiano e del fascismo e tende a dare una rappresentazione edulcorata degli eventi e dei loro protagonisti.
2. L’eroicizzazione di Gennaro Sora e le polemiche sulle ricerche di Matteo Dominioni
Prima di analizzare la memoria di Gennaro Sora vale la pena ripercorrere brevemente alcune delle opinioni riguardo la vicenda di Zeret che compongono un quadro autoassolutorio delle operazioni militari e di repressione dell’opposizione portate avanti dagli italiani in Etiopia negli anni Trenta. L’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’esercito nel 2010 pubblicava un libro che, grazie all’analisi della documentazione d’archivio relativa alle operazioni di grande polizia coloniale di Federica Saini Fasanotti, ridusse la strage di Zeret a conflitto ordinario, sottolineando che, sulla base delle armi trovate nella grotta «non era certo stato un assedio a dei disarmati», e soprattutto che: «se ci atteniamo a questo documento [un telegramma indirizzato a Cavallero dove si lamenta l’inefficacia dei gas], come ci siamo attenuti a tutti gli altri, i gas tossici non avevano funzionato […] non ci sono dati ufficiali che avallino l’ipotesi che l’utilizzo dei gas abbia ucciso anche una sola persona. Né nel momento in cui si è usato e neppure nei giorni successivi, visto che lì, a pochi metri, operavano le stesse truppe italiane». [5] A delegittimare gli studi di Dominioni sul numero di vittime fucilate vi fu anche l’affermazione di Fasanotti sulla difficoltà di considerare come fonte autorevole il diario di Boaglio.
Del medesimo avviso fu Gian Paolo Rivolta, che addirittura si recò a Zeret per un rilievo speleologico e che, sulla base della morfologia della grotta [Viazzi, Zanchi 2021, 55-63] [6], giunse anche all’affrettata conclusione che le aggressioni italiane non poterono che essere limitate:
emerge un quadro generale, indubbio, di una feroce guerra all’ultimo sangue tra le truppe italiane e gli ascari, contro partigiani irriducibili, i quali hanno respinto le condizioni di resa, che avrebbero loro risparmiato la vita e ridato la libertà […] La fucilazione finale degli uomini arresisi rientra quindi in un atto finale bellico, sanguinoso, e di regole di guerra crudeli, ma purtroppo consuete e generalizzate, di uccidere chi rifiutava di arrendersi e continuava a combattere fino alle estreme conseguenze, e non può configurarsi come una strage efferata, né tanto meno di inermi [7]
Questi studi, più o meno autorevoli, hanno legittimato gli scritti postumi aventi l’obiettivo di proteggere la reputazione del colonello Sora, tra i quali spicca il libro Gennaro Sora. L’Alpino leggendario di Luciano Viazzi e Valerio Zanchi pubblicato nel 2021 che oltre ad esplicitare, già dall’introduzione, il suo obiettivo difensivo [Viazzi, Zanchi 2021, 9-12] raccoglie immagini e informazioni sui luoghi e i momenti celebrativi delle gesta dell’alpino Sora [Viazzi, Zanchi, 2021, 89-104] [8]. In questo stesso filone si situano anche le dichiarazioni dell’Associazione Nazionale Alpini [9] e quasi tutte le polemiche a seguito dell’uscita dell’articolo e del libro di Dominioni. Tuttavia, la mitizzazione dell’alpino ebbe inizio già durante il corso della sua vita e negli anni immediatamente seguenti la sua morte, avvenuta nel giugno 1949: tra le prime opere commemorative vi fu un monumento a lui intitolato, oggi localizzato in via Roma a Foresto Sparso [10], l’intitolazione a suo nome di una via della città di Bergamo avvenuta nel 1952 [Bendotti 2017], un trofeo a lui dedicato per la gara Nazionale di staffetta alpina [11] e un museo inaugurato nel 1963 a Foresto Sparso, per celebrare le imprese di Sora e quelle delle truppe alpine.
Gennaro Sora guadagnò il grado di comandante e tre medaglie d’argento alla fine della prima guerra mondiale, ma giunse all’apice della sua carriera militare solo nel 1928, quando partecipò alla spedizione al Polo Nord del dirigibile Italia, che incidentato venne soccorso da Sora, i suoi alpini, l’ingegnere Ludvig Varming e l’olandese Sief van Dongen. Nonostante l’alpino non avesse contribuito così nobilmente all’impresa, ma anzi i due tentativi lo fecero capitolare insieme ai suoi compagni nella posizione di colui da soccorrere [Vittori 2008, 80; Viazzi, Zanchi, 2021 26], al suo ritorno in patria venne accolto come «l’eroe del Polo», mito poi rafforzato dalla sua autobiografia del 1929 e, dopo l’esperienza Africana (1937-1945) [12] e la seconda guerra mondiale dal libro Il capitano Sora. L’eroico leggendario alpino [Viazzi 1969].
La pubblicazione del libro di Dominioni, e più precisamente la sua presentazione il 28 novembre 2008 presso la libreria Ubik di Bergamo, accese un dibattito avvenuto principalmente sulle colonne de «L’Eco di Bergamo» che mise in luce la difficoltà da parte dei cittadini, e soprattutto degli alpini di Foresto Sparso, di accettare che Sora non fosse «l’eroe dell’artico» [Viazzi, Zanchi 2021, 73], ma un criminale di guerra. Pochi giorni dopo la presentazione del libro, Vincenzo Guercio intervistò Angelo del Boca chiedendogli se fosse accettabile considerare il ruolo di Sora una mera esecuzione di ordini:
Assolutamente no. Un tenente colonnello come Sora, che operava in una zona lontana dal comando centrale, aveva ampia autonomia. Non mi risulta nemmeno avesse informato per radio su quanto stava avvenendo. Si verificano anche “eccessi di zelo” [Del Boca, Guercio 2008].
La nipote Giuditta Sora fu la prima ad esprimere il suo disappunto e lo fece scrivendo direttamente al giornale il 10 gennaio 2009:
Egregio direttore,
su «L’Eco di Bergamo» di mercoledì 5 dicembre scorso ho letto gli articoli a firma di Vincenzo Guercio circa le scoperte fatte da uno storico torinese e contenute in un libro di recente pubblicazione sulla guerra d’Etiopia che dedica alcune pagine alla battaglia detta di Caja-Zeret svoltasi nell’aprile del 1939. I fatti essenziali di quella battaglia, inclusa la triste contabilità sui morti e feriti da entrambe le parti, sono già noti al pubblico interessato da almeno quasi 40 anni […] Gennaro Sora era mio zio, ed è [sic] il motivo per cui le scrivo, è l’impostazione parziale e quasi scandalistica dello stesso tesa ad attribuire a Sora ogni responsabilità di quanto accaduto durante quella battaglia [Sora 2009]. [13]
Oltre a non nominare Dominioni, assumendo così un atteggiamento quasi sprezzante nei suoi confronti, la signora Sora – facendo fede a ciò che scrisse sul giornale – non ebbe intenzione di mettere in discussione il lavoro dello storico, ma piuttosto di ristabilire quanto prima il nome dello zio alpino, la cui immagine era minacciata da una rappresentazione, a suo dire, scandalistica.
Dallo stesso lato, ma su un altro piano, si posizionarono le dichiarazioni di Luigi Furia, direttore de «Lo scarpone orobico», periodico dell’Associazione Alpini di Bergamo [Bramati, Vittori, 2009], che a distanza di un mese da Giuditta Sora, e sempre tramite la penna di Vincenzo Guercio, non si limitò a voler proteggere l’immagine del tenente colonello cercando di dimostrare la sua antipatia nei confronti di Graziani, ma negò la responsabilità di Sora riguardo la richiesta di armi chimiche e giustificò l’impiego di queste con la stagnante retorica del «perché dall’altra parte si usavano altri metodi proibiti dalla Convenzione» [Furia 2009a], senza porsi il benché minimo dubbio riguardo le differenze di armamenti tra la resistenza etiope e l’esercito italiano.
Oltre al diretto intervento di Matteo Dominioni [2009], Rodolfo Vittori e Luciana Bramati, con una lineare argomentazione, dimostravano che nessuna antipatia tra Sora e Graziani impedì la sua partecipazione alle azioni comandate dal viceré, e che tantomeno vi fosse una correlazione tra questo rapporto e la sua ipotetica benevolenza nei confronti degli indigeni; in ultimo, mettendo in luce le lacune di carattere storico di Furia, sottolineavano la gravità delle sue affermazioni [Bramati, Vittori, 2009], provocando la risposta dell’alpino. Il 28 febbraio, infatti, Luigi Furia ripeté a grandi linee le dichiarazioni che già aveva rilasciato al giornale bergamasco e concluse la difesa di Sora con una, forse necessaria, breve apologia di sé stesso: «Un’ultima precisazione: non sono mai stato un nostalgico, né del fascismo né del comunismo con buona pace dei loro attuali tifosi» [Furia 2009b].
Il libro di Viazzi e Zanchi uscito nel 2021, che è forse il prodotto più recente di questa polemica, ben riassume tutti i tentativi fatti a partire dal 2008 di riabilitare la reputazione infangata di Gennaro Sora. Sforzi che sono figli di un’estrema localizzazione della memoria e che portano alla spiacevole constatazione che la ricerca storica accademica passa in subordine rispetto alle memorie familiari, di corpo e locali, le quali si suppone siano una fonte più attendibile, o l’unica attendibile, per la narrazione storica e non, piuttosto, una delle voci da tenere in considerazione accanto alle altre fonti nel complesso processo di ricostruzione della storia attraverso la ricerca da parte degli studiosi italiani.
Emerge un’Italia che ancora fatica a considerare autorevoli le ricerche degli storici, a cui preferisce una narrazione autoconsolatoria del testimone oculare, e che nella sfera pubblica è chiusa in sé stessa, come Stato rispetto al contesto internazionale e come pluralità di centri locali rispetto al contesto nazionale. L’eroicizzazione di criminali di guerra come Gennaro Sora è il risultato di un silenzio, seppur non in ambito accademico, durato quasi ottant’anni, che è a sua volta figlio di un bombardamento propagandistico durato venti e che acquista forza nell’isolamento che le città italiane vivono in termini di aggiornamento storico e storiografico. Laddove manca una coscienza collettiva sul proprio passato, in questo caso sul colonialismo fascista, si inserisce il contesto privato, carico di vissuti potenzialmente utili alla narrazione storica, ma anche di pregiudizi, miti, stereotipi e timori dell’avvenire.
Bibliografia
- Bramati, Vittori 2009
Luciana Bramati, Rodolfo Vittori, Il capitano Sora e la serietà di storici e fonti, «L’Eco di Bergamo», 26 febbraio 2009. - Bendotti 2017
Angelo Bendotti, I conquistatori dell’impero. Tre vie, una piazza e un passaggio, La Spezia, Il Filo di Arianna, 2017. - Del Boca, Guercio 2008
Angelo Del Boca, Vincenzo Guercio, La via italiana al colonialismo, un modello per l’apartheid sudafricano, «L’Eco di Bergamo», 3 dicembre 2008. - Dominioni 2006
Matteo Dominioni, Etiopia 11 aprile 1939. La strage segreta di Zeret, in «Italia contemporanea», 243 (2006), 287-302. - Dominioni 2008
Matteo Dominioni, Lo sfascio dell’impero. Gli italiani in Etiopia 1936-1941, Bari, Laterza, 2008. - Dominioni 2009
Matteo Dominioni, Dominioni: Sora responsabile dell’operazione di Zeret, «L’Eco di Bergamo», 23 febbraio 2009. - Furia 2009a
Luigi Furia, Sora non chiese il gas contro gli etiopi, «L’Eco di Bergamo», 8 febbraio 2009. - Furia 2009b
Luigi Furia, Il caso Sora. “Non sono un nostalgico”, «L’Eco di Bergamo», 28 febbraio 2009. - Guercio 2008
Vincenzo Guercio, Gennaro Sora, un’ombra dell’Etiopia, «L’Eco di Bergamo», 3 dicembre 2008. - Pioselli 2012
Andrea Pioselli, Zeret, Gennaro Sora e la memoria degli italiani, in «Studi e ricerche di storia contemporanea», 77 (2012), 71-96. - Sora 2009
Giuditta Sora, Gennaro Sora e la difficile ricostruzione storica. Nessuna parzialità, ma i fatti di una guerra brutale, «L’Eco di Bergamo», 10 gennaio 2009. - Viazzi 1969
Luciano Viazzi, Il capitano Sora l’eroico leggendario alpino, Trento, Monauni, 1969. - Viazzi, Zanchi 2021
Luciano Viazzi, Valerio Zanchi, Gennaro Sora. L’Alpino leggendario, Milano, Editoriale Delfino, 2021. - Vittori 2008
Rodolfo Vittori, Italiani brava gente. Gennaro Sora e l’eccidio di Gaia Zeret, in «Studi e ricerche di storia contemporanea», 70 (2008), 73-81.
Risorse
- Ciriaci 2015
Documentario If Only I Were That Warrior di Valerio Ciriaci (2015), 72 minuti.
Programma 64° Trofeo Gennaro Sora
https://www.valdiscalve.it/eventi/64-trofeo-gennaro-sora/ - Il capitano Sora e i crimini che non commise, lettera pubblicata sul sito dell’Associazione Nazionale Alpini
https://www.ana.it/2015/10/12/il-capitano-sora-e-i-crimini-che-non-commise/ - Catalogo generale dei Beni Culturali: Gennaro Sora
https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/0303265960 - Museo della Scienza, arriva la mostra sull’alpino-eroe della spedizione al Polo Nord, in «Milano Today», 16 aprile 2019
https://www.milanotoday.it/eventi/museo-scienza-mostra-alpino.html
Note
1. Le ricerche di Dominioni non si sono limitate a ricerche storiche e d’archivio, ma sono il frutto anche di un dettagliato lavoro archeologico sul campo [Pioselli 2012, 79-81].
2. «Caverna della rivolta» era il nome attribuito alla grotta dai locali, secondo la testimonianza di uno scioano che combatté nei pressi di Zeret. Irma Taddia, Autobiografie africane. Il colonialismo nelle memorie orali, Milano, Angeli, 1996, 101-102 cit. in: Dominioni 2006, 300.
3. Telegramma n.125 di Sora al Comando settore nord-orientale, in marcia 3 aprile 1939 cit. in: Dominioni 2008, 210.
4. Rodolfo Graziani si colloca perfettamente nel contesto dell’eroicizzazione dei criminali di guerra avvenuta a partire dalla fine dell’esperienza coloniale, e che ancora oggi si protrae in alcuni manifestazioni locali. Si veda, per Graziani, il caso del mausoleo intitolatogli ad Affile: Tribunale di Tivoli, sent. n. 24241, 7 novembre 2017. Intitolazione del parco pubblico Radimonte e del museo al soldato al Generale Rodolfo Graziani, con riferimento all’art. 4, comma 2, L. 645/1952 e successive modifiche [Ciriaci 2015].
5. Federica Saini Fasanotti, Etiopia 1936-1940: le operazioni di polizia coloniale nelle fonti dell’esercito italiano, Stato maggiore dell’esercito, Ufficio storico, 2010 cit. in: Pioselli 2012, 77.
6. Dominioni aveva precedentemente fatto un’accurata valutazione archeologica insieme a Yonatan Sahle nell’aprile 2006.
7. Gian Paolo Rivolta, La battaglia alla grotta del ribelle di Zeret (Etiopia) nell’aprile 1939. Un episodio di guerra del tenente colonnello Gennaro Sora nel Corno d’Africa, Atti del Centro Ricerche e Studi sull’Ambiente, gli Ipogei e le Acque Carsiche, vol. 1, Nerviano, 2011, p. 93 cit. in Pioselli: 2012.
8. Tra i più recenti la mostra fotografica dedicata a Sora nel 2019 presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano: https://www.milanotoday.it/eventi/museo-scienza-mostra-alpino.html, consultato il 25.03.2025
9. Il capitano Sora e i crimini che non commise, https://www.ana.it/2015/10/12/il-capitano-sora-e-i-crimini-che-non-commise/, consultato il 02.03.2025
10. Catalogo generale dei Beni Culturali, https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/0303265960, consultato il 25.03.2025
11. 64° Trofeo Gennaro Sora, https://www.valdiscalve.it/eventi/64-trofeo-gennaro-sora/, consultato il 28.02.2024.
12. Dal 1941 Sora fu prigioniero inglese e nel 1945 tornò in Italia.
13. L’articolo a cui probabilmente Giuditta Sora si riferisce è: Guercio 2008.